 |
|
| Eduardo: Vita, opere e spunti di riflessione sul suo
Teatro di Vincenzo Morvillo |
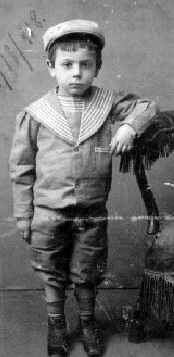 «Sono nato a Napoli il 24 Maggio del 1900, dall’unione del più grande attore-autore-regista e capocomico napoletano di quell’epoca, Eduardo Scarpetta, con Luisa De Filippo, nubile. Mi ci volle del tempo per capire le circostanze della mia nascita perché a quei tempi i bambini non avevano la sveltezza e la strafottenza di quelli di oggi e quando ad undici anni seppi che ero “figlio di padre ignoto” per me fu un grosso choc. La curiosità morbosa della gente intorno a me non mi aiutò certo a raggiungere un equilibrio emotivo e mentale. Così, se da una parte ero orgoglioso di mio padre, della cui compagnia ero entrato a far parte, sia pure saltuariamente, come comparsa e poi come attore, fin dall’età di quattro anni […], d’altra parte la fitta rete di pettegolezzi, chiacchiere, e malignità mi opprimeva dolorosamente. Mi sentivo respinto, oppure tollerato, e messo in ridicolo solo perché “diverso”. Da molto tempo, ormai, ho capito che il talento si fa strada comunque e niente lo può fermare, ma è anche vero che esso cresce e si sviluppa più rigoglioso quando la persona che lo possiede viene considerata “diversa” dalla società. Infatti, la persona finisce per desiderare di esserlo davvero, diversa, e le sue forze si moltiplicano, il suo pensiero è in continua ebollizione, il fisico non conosce più stanchezza pur di raggiungere la meta che si è prefissa. Tutto questo però allora non lo sapevo e la mia “diversità” mi pesava a tal punto che finii per lasciare la casa materna e la scuola e me ne andai in giro per il mondo da solo, con pochissimi soldi in tasca ma col fermo proposito di trovare la mia strada. Dovrei dire: di trovare la mia strada nella strada che avevo già scelto da sempre, il teatro, che è stato ed è tutto per me».
Così Eduardo raccontava, in una nota autobriografica risalente ai primi anni settanta, l’alba della sua vita, che coincise, ineluttabilmente, col Teatro – data la sua origine – ma principalmente con il trauma di una ambigua identità che, in seguito, fortemente avrebbe influenzato la poco convenzionale comprensione del mondo reale e legale, nonché l’amarissima poetica eduardiana. Una poetica che non può essere compresa appieno se non si tiene in giusta considerazione l’elemento biografico. E difatti, l’intera sua opera, o quanto meno la parte di essa più riuscita e capace di scrutare a fondo tra le pieghe della realtà e dei suoi fenomeni, e con essa l’intimità dell’anima e la coscienza soggettiva e collettiva dell’uomo, è completamente investita del problema dell’identità, intesa non soltanto, e non tanto, come soggettività parlante e, dunque, legale, ma come universo interiore, immagine intima e s-conosciuta tra sconosciuti. Verità e bugia, realtà e mondo metafisico, realtà e fantasmi, parola espressa e voci di dentro, configurano, costantemente nelle sue commedie, un rapporto tra “maschera e volto” in cui consiste la vita e insieme il dramma della condizione dell’attore. Una condizione che la meta-attoralità eduardiana riesce a trascendere il teatro e a manifestare come tragico destino umano. Ed è qui che l’attore e il drammaturgo s’incontrano e si fondono, in un rapporto osmotico che diventa identità. Eduardo autore, altri non è che l’Eduardo uomo che, con il suo “sguardo profetico” – per parafrasare il titolo di un saggio di Franco Carmelo Greco – osserva la vita e raccoglie materiale per la sua arte per poter, successivamente, trasformare la vita stessa in arte. E sarà poi l’attore, magica allegoria dell’uomo, a dare corpo a quella visione. Anche mentre scrive, la sua esperienza di attore lo guida nella scelta delle espressioni più recitabili, più efficaci, o più adatte al comportamento di personaggi che, mentre nascono, cominciano già a muoversi nel suo corpo di attore. Eduardo, forse, è stato l’attore-autore del novecento che più e meglio di ogni altro ha sezionato, «Sono nato a Napoli il 24 Maggio del 1900, dall’unione del più grande attore-autore-regista e capocomico napoletano di quell’epoca, Eduardo Scarpetta, con Luisa De Filippo, nubile. Mi ci volle del tempo per capire le circostanze della mia nascita perché a quei tempi i bambini non avevano la sveltezza e la strafottenza di quelli di oggi e quando ad undici anni seppi che ero “figlio di padre ignoto” per me fu un grosso choc. La curiosità morbosa della gente intorno a me non mi aiutò certo a raggiungere un equilibrio emotivo e mentale. Così, se da una parte ero orgoglioso di mio padre, della cui compagnia ero entrato a far parte, sia pure saltuariamente, come comparsa e poi come attore, fin dall’età di quattro anni […], d’altra parte la fitta rete di pettegolezzi, chiacchiere, e malignità mi opprimeva dolorosamente. Mi sentivo respinto, oppure tollerato, e messo in ridicolo solo perché “diverso”. Da molto tempo, ormai, ho capito che il talento si fa strada comunque e niente lo può fermare, ma è anche vero che esso cresce e si sviluppa più rigoglioso quando la persona che lo possiede viene considerata “diversa” dalla società. Infatti, la persona finisce per desiderare di esserlo davvero, diversa, e le sue forze si moltiplicano, il suo pensiero è in continua ebollizione, il fisico non conosce più stanchezza pur di raggiungere la meta che si è prefissa. Tutto questo però allora non lo sapevo e la mia “diversità” mi pesava a tal punto che finii per lasciare la casa materna e la scuola e me ne andai in giro per il mondo da solo, con pochissimi soldi in tasca ma col fermo proposito di trovare la mia strada. Dovrei dire: di trovare la mia strada nella strada che avevo già scelto da sempre, il teatro, che è stato ed è tutto per me».
Così Eduardo raccontava, in una nota autobriografica risalente ai primi anni settanta, l’alba della sua vita, che coincise, ineluttabilmente, col Teatro – data la sua origine – ma principalmente con il trauma di una ambigua identità che, in seguito, fortemente avrebbe influenzato la poco convenzionale comprensione del mondo reale e legale, nonché l’amarissima poetica eduardiana. Una poetica che non può essere compresa appieno se non si tiene in giusta considerazione l’elemento biografico. E difatti, l’intera sua opera, o quanto meno la parte di essa più riuscita e capace di scrutare a fondo tra le pieghe della realtà e dei suoi fenomeni, e con essa l’intimità dell’anima e la coscienza soggettiva e collettiva dell’uomo, è completamente investita del problema dell’identità, intesa non soltanto, e non tanto, come soggettività parlante e, dunque, legale, ma come universo interiore, immagine intima e s-conosciuta tra sconosciuti. Verità e bugia, realtà e mondo metafisico, realtà e fantasmi, parola espressa e voci di dentro, configurano, costantemente nelle sue commedie, un rapporto tra “maschera e volto” in cui consiste la vita e insieme il dramma della condizione dell’attore. Una condizione che la meta-attoralità eduardiana riesce a trascendere il teatro e a manifestare come tragico destino umano. Ed è qui che l’attore e il drammaturgo s’incontrano e si fondono, in un rapporto osmotico che diventa identità. Eduardo autore, altri non è che l’Eduardo uomo che, con il suo “sguardo profetico” – per parafrasare il titolo di un saggio di Franco Carmelo Greco – osserva la vita e raccoglie materiale per la sua arte per poter, successivamente, trasformare la vita stessa in arte. E sarà poi l’attore, magica allegoria dell’uomo, a dare corpo a quella visione. Anche mentre scrive, la sua esperienza di attore lo guida nella scelta delle espressioni più recitabili, più efficaci, o più adatte al comportamento di personaggi che, mentre nascono, cominciano già a muoversi nel suo corpo di attore. Eduardo, forse, è stato l’attore-autore del novecento che più e meglio di ogni altro ha sezionato,
 analizzato e interpretato la realtà sociale e storica in cui era immerso, traducendo sulla scena più o meno identificabili protagonisti sociali. Le sue commedie e, come logica conseguenza il suo lavoro sulla scena, aderiscono al proprio tempo, ne sono il riflesso e insieme la coscienza critica, producono nello spettatore un effetto di identificazione che lo porta a riconoscersi in vicende e personaggi apparentemente lontani da lui. E
questo nonostante, anzi soprattutto perché sullo sfondo c’è Napoli. I napoletani di Eduardo sono uomini e donne comuni, colti nella loro quotidianità, ma non sono mai chiusi, oppressi in una rigida e riduttiva forma teatrale di folcloristico napoletanismo. Sono uomini e donne in cui l’intera umanità del nostro tempo può riconoscersi, perché le loro vicende sono le stesse che quell’umanità ha vissuto e vive. Qui sta l’universalità del teatro di Eduardo che, come autore, ha trattato, pur servendosi del dialetto, i grandi temi umani, storici, sociali, politici.
Il problema della lingua in lui è stato urgente e fondamentale. Nonostante molti critici e uomini di cultura – per lo più resi miopi da un assurdo snobismo intellettuale – abbiano a lungo contestato la natura dialettale del suo teatro, in cui credevano di scorgere un provincialismo che, inevitabilmente, doveva interessare anche l’aspetto contenutistico della sua opera, la dimensione universale e l’ampio respiro della drammaturgia eduardiana acquistano vitalità e spessore proprio grazie alla linfa napoletana che scorre negli ambienti, nei personaggi, nei modelli di vita e storia, nella quotidianità. Il napoletano era la sua lingua madre, e su quella lingua aveva modellato la propria gestualità di attore, i meccanismi della sua comicità specialmente durante i primi anni della sua attività, ai quali, come molti ricorderanno, risale il sodalizio con i due fratelli, Peppino e Titina. Fu di quel periodo il Teatro Umoristico i De Filippo, che tanto successo riscosse tra gli anni trenta e quaranta e che si sciolse, per sopravvenute incompatibilità, ma anche per esigenze strettamente artistiche, nel 1945. Di quegli anni sono le commedie de “La analizzato e interpretato la realtà sociale e storica in cui era immerso, traducendo sulla scena più o meno identificabili protagonisti sociali. Le sue commedie e, come logica conseguenza il suo lavoro sulla scena, aderiscono al proprio tempo, ne sono il riflesso e insieme la coscienza critica, producono nello spettatore un effetto di identificazione che lo porta a riconoscersi in vicende e personaggi apparentemente lontani da lui. E
questo nonostante, anzi soprattutto perché sullo sfondo c’è Napoli. I napoletani di Eduardo sono uomini e donne comuni, colti nella loro quotidianità, ma non sono mai chiusi, oppressi in una rigida e riduttiva forma teatrale di folcloristico napoletanismo. Sono uomini e donne in cui l’intera umanità del nostro tempo può riconoscersi, perché le loro vicende sono le stesse che quell’umanità ha vissuto e vive. Qui sta l’universalità del teatro di Eduardo che, come autore, ha trattato, pur servendosi del dialetto, i grandi temi umani, storici, sociali, politici.
Il problema della lingua in lui è stato urgente e fondamentale. Nonostante molti critici e uomini di cultura – per lo più resi miopi da un assurdo snobismo intellettuale – abbiano a lungo contestato la natura dialettale del suo teatro, in cui credevano di scorgere un provincialismo che, inevitabilmente, doveva interessare anche l’aspetto contenutistico della sua opera, la dimensione universale e l’ampio respiro della drammaturgia eduardiana acquistano vitalità e spessore proprio grazie alla linfa napoletana che scorre negli ambienti, nei personaggi, nei modelli di vita e storia, nella quotidianità. Il napoletano era la sua lingua madre, e su quella lingua aveva modellato la propria gestualità di attore, i meccanismi della sua comicità specialmente durante i primi anni della sua attività, ai quali, come molti ricorderanno, risale il sodalizio con i due fratelli, Peppino e Titina. Fu di quel periodo il Teatro Umoristico i De Filippo, che tanto successo riscosse tra gli anni trenta e quaranta e che si sciolse, per sopravvenute incompatibilità, ma anche per esigenze strettamente artistiche, nel 1945. Di quegli anni sono le commedie de “La
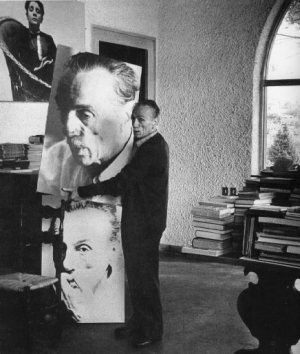 Cantata dei Giorni Pari”, cui appartengono lavori come “Uomo e Galantuomo”, “Sik-Sik, l’artefice magico”, “Natale in casa Cupiello”, “Ditegli sempre di si”, cui seguiranno i testi de “La Cantata dei Giorni Dispari”, che segneranno la completa maturazione dell’Eduardo drammaturgo. Tra essi ricordiamo “Napoli Milionaria!”, “Non ti pago”, “Questi fantasmi”, “Filumena Marturano”, “La grande magia”, “Le voci di dentro”, “De Pretore Vincenzo”, “Sabato, domenica e lunedì”, “Il Sindaco di Rione Sanità”.
Per tornare al problema, sollevato più volte dalla critica tanto teatrale quanto letteraria, del provincialismo legato al dialetto e al microcosmo Napoli, vogliamo dire, senz’altro, che Napoli fu e continua ad essere – sempre per citare Greco – lo sguardo di Eduardo, più che esserne oggetto. Eduardo guarda al mondo attraverso la sua città e Napoli include e conclude il mondo stesso. Lo sguardo profetico di Eduardo è tale perché attraverso Napoli, e la sua crisi di valori post-bellica, lui è riuscito a cogliere la crisi dell’intero mondo contemporaneo, un mondo cristallizzato e bloccato in una dimensione astorica che il baratro morale della guerra ha determinato e che sarà, ed è, il segno del futuro. Se ci fu profezia, mai fu più
azzeccata! Dunque, anche il dialetto diventa una funzione, una semplice convenzione teatrale, come scrisse Corrado Alvaro, uno strumento più adatto di altri perché più aderente alla realtà che vuole rappresentare. E lui si servì del dialetto soprattutto per la sua grande arte attorale. Anche quando recitava i lavori di altri autori, non li interpretava mai senza tradurli, non tanto in un vero e proprio napoletano, quanto in una sorta di italiano napoletanizzato. Quando recita, tra la battuta scritta e quella detta lascia sempre una certa distanza,
modificando sempre un po’ la struttura della frase, senza però cambiarne il concetto o la battuta finale, per non disorientare i compagni di scena. Era questo uno di quegli elementi che davano alla sua recitazione quella naturalezza che, ai più, sembrava spontaneità o istinto naturale e che, invece, era frutto di una tecnica talmente raffinata e pulita da diventare impalpabile. In genere, nel suo repertorio, Eduardo attore non ha personaggi: e questo perché la sua parte è normalmente quella del coro. Come tale, egli impersona quella saggezza che vorrebbe dominasse il mondo. Una saggezza che, però, lui stesso sapeva bene essere un’utopia. L’utopia di Antonio Barracano, quel “Sindaco del Rione Sanità” che aveva dedicato l’intera vita a cercare di “istruire” gli uomini. L’Utopia di Luca Cupiello che l’immagine presepiale, la rinascita del “Bambino” si possa realizzare nella grande famiglia degli uomini! L’Attore diventa, ancora una volta, Autore e Uomo nell’Eduardo che, con il suo Teatro, recitato e scritto, ha cercato, forse, di realizzare quella grande Utopia. Cantata dei Giorni Pari”, cui appartengono lavori come “Uomo e Galantuomo”, “Sik-Sik, l’artefice magico”, “Natale in casa Cupiello”, “Ditegli sempre di si”, cui seguiranno i testi de “La Cantata dei Giorni Dispari”, che segneranno la completa maturazione dell’Eduardo drammaturgo. Tra essi ricordiamo “Napoli Milionaria!”, “Non ti pago”, “Questi fantasmi”, “Filumena Marturano”, “La grande magia”, “Le voci di dentro”, “De Pretore Vincenzo”, “Sabato, domenica e lunedì”, “Il Sindaco di Rione Sanità”.
Per tornare al problema, sollevato più volte dalla critica tanto teatrale quanto letteraria, del provincialismo legato al dialetto e al microcosmo Napoli, vogliamo dire, senz’altro, che Napoli fu e continua ad essere – sempre per citare Greco – lo sguardo di Eduardo, più che esserne oggetto. Eduardo guarda al mondo attraverso la sua città e Napoli include e conclude il mondo stesso. Lo sguardo profetico di Eduardo è tale perché attraverso Napoli, e la sua crisi di valori post-bellica, lui è riuscito a cogliere la crisi dell’intero mondo contemporaneo, un mondo cristallizzato e bloccato in una dimensione astorica che il baratro morale della guerra ha determinato e che sarà, ed è, il segno del futuro. Se ci fu profezia, mai fu più
azzeccata! Dunque, anche il dialetto diventa una funzione, una semplice convenzione teatrale, come scrisse Corrado Alvaro, uno strumento più adatto di altri perché più aderente alla realtà che vuole rappresentare. E lui si servì del dialetto soprattutto per la sua grande arte attorale. Anche quando recitava i lavori di altri autori, non li interpretava mai senza tradurli, non tanto in un vero e proprio napoletano, quanto in una sorta di italiano napoletanizzato. Quando recita, tra la battuta scritta e quella detta lascia sempre una certa distanza,
modificando sempre un po’ la struttura della frase, senza però cambiarne il concetto o la battuta finale, per non disorientare i compagni di scena. Era questo uno di quegli elementi che davano alla sua recitazione quella naturalezza che, ai più, sembrava spontaneità o istinto naturale e che, invece, era frutto di una tecnica talmente raffinata e pulita da diventare impalpabile. In genere, nel suo repertorio, Eduardo attore non ha personaggi: e questo perché la sua parte è normalmente quella del coro. Come tale, egli impersona quella saggezza che vorrebbe dominasse il mondo. Una saggezza che, però, lui stesso sapeva bene essere un’utopia. L’utopia di Antonio Barracano, quel “Sindaco del Rione Sanità” che aveva dedicato l’intera vita a cercare di “istruire” gli uomini. L’Utopia di Luca Cupiello che l’immagine presepiale, la rinascita del “Bambino” si possa realizzare nella grande famiglia degli uomini! L’Attore diventa, ancora una volta, Autore e Uomo nell’Eduardo che, con il suo Teatro, recitato e scritto, ha cercato, forse, di realizzare quella grande Utopia.
Foto: |