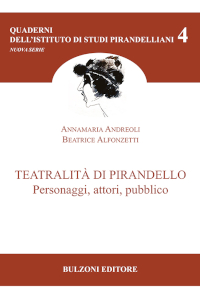Da persona a star, da ragazza insicura e tanto americana a colorato e indiscutibile mito planetario: è stato questo, a pensarci bene, il destino, tanto straordinario quanto fulmineo, di Norma Jeane Mortenson in arte Marilyn Monroe. Un destino, davvero «uno strano copione», così denso di significati da diventare, immediatamente dopo la sua morte
 (verificatasi in circostanze ancora oggi misteriose il 4 agosto del ’62), paradigma di quella che generalmente viene definita la cultura Pop e che forse nessuno ha mai saputo capire e ritrarre meglio, nella sua ripetitività tragica e ossessiva, di Handy Warrol. Scriviamo questa volta di “Marilyn 5 agosto”, lo spettacolo che la compagnia siculo-bolognese “Trame perdute” ha portato in scena, sabato 4 maggio, a Noto nel contesto della stagione del Comunale “Tina Di Lorenzo”: la regia è curata da Giuseppe Liotta, il testo è dell’indimenticato poeta e drammaturgo Gregorio Scalise, mentre l’interpretazione è affidata alla giovane e pur brava Martina Valentini. In scena Marilyn si racconta, si confessa, attraversa e scandaglia dolorosamente i giorni della sua vita: gli uomini, i suoi amori innanzitutto (Arthur Miller, Joe Di Maggio, Lee Strasberg, i fratelli Kennedy), e poi il suo insopprimibile bisogno d’essere amata, e gli oggetti, e i vestiti, la sua bellezza bambina, la sua sensualità, ed ancora il cinema, i sogni, le ambizioni, i viaggi, lo star system, le menzogne, le fughe, lo champagne e le sue mille e mille fragilità. Il monologo assume, nel suo dispiegarsi, il respiro tormentato e quasi la concretezza di un dialogo, un dialogo con sé stessa certo, ma soprattutto coi fantasmi che hanno attraversato la sua vita e, perché no, col pubblico. Sì, col pubblico: perché guardare a questa vita come alla vita di una donna semplice («gelosa e prodiga della mia intimità»), percepirne il dolore e la fragilità, non è facile affatto, anzi è doloroso giacché comporta la possibilità non solo di guardare dritto negli occhi un mito, guardarlo senza abbassare lo sguardo, quasi sfidandone la capacità mistificatoria e normalizzatrice, ma anche di guardare dentro noi stessi, alla nostra fragilità, al nostro stesso bisogno di avere e di costruire miti che, pur mentendoci spu-doratamente (o forse proprio per questo), danno forma e senso alla nostra vita, miti su cui proiettare i nostri desideri e le nostre ansie. Una proiezione che per altro non teme d’essere intrinsecamente violenta (e in qualche modo masochista) perché si nasconde dentro al respiro d’immagini seducenti e di grandissimi movimenti di massa. Una complessità umana e drammaturgica, un raggio di movimenti interiori e una quantità di significazioni davvero enormi per un semplice monologo teatrale che, pur soffrendo complessivamente per una certa discontinuità del tono e del ritmo, tuttavia Liotta sa gestire con sicurezza e rendere emozionante.
(verificatasi in circostanze ancora oggi misteriose il 4 agosto del ’62), paradigma di quella che generalmente viene definita la cultura Pop e che forse nessuno ha mai saputo capire e ritrarre meglio, nella sua ripetitività tragica e ossessiva, di Handy Warrol. Scriviamo questa volta di “Marilyn 5 agosto”, lo spettacolo che la compagnia siculo-bolognese “Trame perdute” ha portato in scena, sabato 4 maggio, a Noto nel contesto della stagione del Comunale “Tina Di Lorenzo”: la regia è curata da Giuseppe Liotta, il testo è dell’indimenticato poeta e drammaturgo Gregorio Scalise, mentre l’interpretazione è affidata alla giovane e pur brava Martina Valentini. In scena Marilyn si racconta, si confessa, attraversa e scandaglia dolorosamente i giorni della sua vita: gli uomini, i suoi amori innanzitutto (Arthur Miller, Joe Di Maggio, Lee Strasberg, i fratelli Kennedy), e poi il suo insopprimibile bisogno d’essere amata, e gli oggetti, e i vestiti, la sua bellezza bambina, la sua sensualità, ed ancora il cinema, i sogni, le ambizioni, i viaggi, lo star system, le menzogne, le fughe, lo champagne e le sue mille e mille fragilità. Il monologo assume, nel suo dispiegarsi, il respiro tormentato e quasi la concretezza di un dialogo, un dialogo con sé stessa certo, ma soprattutto coi fantasmi che hanno attraversato la sua vita e, perché no, col pubblico. Sì, col pubblico: perché guardare a questa vita come alla vita di una donna semplice («gelosa e prodiga della mia intimità»), percepirne il dolore e la fragilità, non è facile affatto, anzi è doloroso giacché comporta la possibilità non solo di guardare dritto negli occhi un mito, guardarlo senza abbassare lo sguardo, quasi sfidandone la capacità mistificatoria e normalizzatrice, ma anche di guardare dentro noi stessi, alla nostra fragilità, al nostro stesso bisogno di avere e di costruire miti che, pur mentendoci spu-doratamente (o forse proprio per questo), danno forma e senso alla nostra vita, miti su cui proiettare i nostri desideri e le nostre ansie. Una proiezione che per altro non teme d’essere intrinsecamente violenta (e in qualche modo masochista) perché si nasconde dentro al respiro d’immagini seducenti e di grandissimi movimenti di massa. Una complessità umana e drammaturgica, un raggio di movimenti interiori e una quantità di significazioni davvero enormi per un semplice monologo teatrale che, pur soffrendo complessivamente per una certa discontinuità del tono e del ritmo, tuttavia Liotta sa gestire con sicurezza e rendere emozionante.