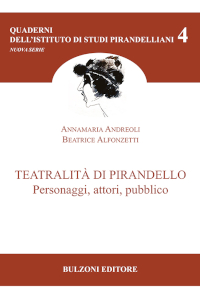Non ci vuole molto a capire che, se c’è un aspetto dell’attuale realtà mediterranea che merita d’esser raccontato, questo non può che essere l’imponente fenomeno migratorio che, dalle coste africane e mediorientali, sta toccando in questi anni e ogni giorno di più le coste meridionali dell’Europa
 e, al primo impatto, la Sicilia e le sue isole minori. Un fenomeno imponente, troppo spesso tragico, denso d’implicazioni di senso e i cui effetti demografici, già visibili, annunciano grandi cambiamenti sociali, politici e culturali. Disinteressarsi di un fenomeno del genere, girarsi dall’altra parte, far finta di niente, significa non aver voglia di capire come funziona il mondo (per ignoranza, pregiudizio razzista, egoismo in malafede) e però l’arte non può essere indifferente al mondo. Da questa prospettiva, al contrario, Lina Prosa, drammaturga e regista palermitana ha da sempre vista lunga e sguardo profondo: la sua ricerca ha intersecato negli anni frontiere che riguardano i segmenti più vivi, mobili e fecondi della cultura contemporanea: le migrazioni, il corpo, la diversità, la malattia. E la sua scrittura teatrale ha già avuto i riconoscimenti che merita, ma in Francia, dove è stata accolta (non per la prima volta) con una messa in scena, nella primavera scorsa, del testo “Lampedusa Beach” sulla scena parigina della Comédie Française e, sempre in questo teatro, con la realizzazione dell’intera “Trilogia del Naufragio” (oltre “Lampedusa Beach”, anche “Lampedusa Snow” e “Lampedusa Way”), presentata tra gennaio e febbraio scorsi. Detto ciò, non può che far piacere constatare che dal 21 marzo al 17 aprile e poi dal 6 al 18 maggio, “Lampedusa Beach” è stato, finalmente, in scena anche in Sicilia, a Palermo, con un nuovo spettacolo firmato dalla drammaturga, anche in veste di regista, e con l’interpretazione della giovane Elisa Lucarelli (una prova di maturità espressiva); a produrlo e ospitarlo il Teatro Biondo con un’operazione meritoria alla quale è quasi ovvio sperare che si dia seguito con la produzione degli altri due testi di questa trilogia. Lo spettacolo si dispiega come monologo: il monologo terso e tremendo di una giovane nordafricana, immigrata clandestina, di nome Shauba che affoga nel mare proprio di fronte alla costa di Lampedusa. Shauba affonda inesorabilmente e quasi paradossalmente, affoga e rievoca la sua breve esperienza di vita, i suoi affetti, i colori del suo paese, le sue speranze, le motivazioni che l’hanno indotta a fuggire dalla sua terra («non si può rimanere nel luogo in cui si nasce, se hai la certezza che in quel luogo vive pure il tuo carnefice»): il tempo di uno spasimo, pochi istanti che si dilatano ad accogliere e ricapitolare il senso di una vita, di un viaggio, di un futuro stroncato, il senso del tradimento nei suoi confronti dell’occidente “capitalista” (in cui lei era pur pronta a integrarsi). Rievoca gli istanti tremendi della sua caduta in mare Shauba, dal rovesciarsi di quel barcone zeppo di settecento immigrati, di quella carretta che si ribalta proprio mentre lei sta per esser violentata dagli scafisti, cani che s’azzuffano per il suo corpo di giovane donna come per un pezzo di carne, fino al momento in cui lei (ma il suo corpo è già un’altra cosa), stremata ed esanime, tocca il fondale. La scrittura scenica è pulita, i colori netti, non ci sono musiche (scelta davvero interessante), né ridondanze espressive che tradirebbero la tremenda semplicità dell’accadimento, quasi ogni parola respira col suo tempo esatto e la profondità che questa vicenda implica in quanto tale: si percepisce chiaramente che coincidono regista e drammaturga. Eppure, se qualcosa appesantisce questo lavoro, è proprio l’esplicitarsi della riflessione critica e apertamente politica, il ragionare sul tradimento dell’occidente e sulla sua ostile indifferenza rispetto a quanto accade nel Mediterraneo: quel che succede a Shauba, il suo corpo che affonda e diventa pasto per i pesci, è un urlo politico in sé, lacerante e durissimo, non occorrono parole per spiegarlo, per definirlo e situarlo. Se noi italiani, se noi europei non capiamo il senso di quel che accade a Shauba siamo già perduti; se il Mediterraneo si è trasformato, in questi ultimi anni soprattutto, in uno sterminato cimitero sottomarino, forse dovremmo capire davvero che questo cimitero altro non è che l’immagine reale che l’Occidente dà di sé riflettendosi nel mare. «Il mare è innocente» dice, a un certo punto dello spettacolo, Shauba ed ha ragione.
e, al primo impatto, la Sicilia e le sue isole minori. Un fenomeno imponente, troppo spesso tragico, denso d’implicazioni di senso e i cui effetti demografici, già visibili, annunciano grandi cambiamenti sociali, politici e culturali. Disinteressarsi di un fenomeno del genere, girarsi dall’altra parte, far finta di niente, significa non aver voglia di capire come funziona il mondo (per ignoranza, pregiudizio razzista, egoismo in malafede) e però l’arte non può essere indifferente al mondo. Da questa prospettiva, al contrario, Lina Prosa, drammaturga e regista palermitana ha da sempre vista lunga e sguardo profondo: la sua ricerca ha intersecato negli anni frontiere che riguardano i segmenti più vivi, mobili e fecondi della cultura contemporanea: le migrazioni, il corpo, la diversità, la malattia. E la sua scrittura teatrale ha già avuto i riconoscimenti che merita, ma in Francia, dove è stata accolta (non per la prima volta) con una messa in scena, nella primavera scorsa, del testo “Lampedusa Beach” sulla scena parigina della Comédie Française e, sempre in questo teatro, con la realizzazione dell’intera “Trilogia del Naufragio” (oltre “Lampedusa Beach”, anche “Lampedusa Snow” e “Lampedusa Way”), presentata tra gennaio e febbraio scorsi. Detto ciò, non può che far piacere constatare che dal 21 marzo al 17 aprile e poi dal 6 al 18 maggio, “Lampedusa Beach” è stato, finalmente, in scena anche in Sicilia, a Palermo, con un nuovo spettacolo firmato dalla drammaturga, anche in veste di regista, e con l’interpretazione della giovane Elisa Lucarelli (una prova di maturità espressiva); a produrlo e ospitarlo il Teatro Biondo con un’operazione meritoria alla quale è quasi ovvio sperare che si dia seguito con la produzione degli altri due testi di questa trilogia. Lo spettacolo si dispiega come monologo: il monologo terso e tremendo di una giovane nordafricana, immigrata clandestina, di nome Shauba che affoga nel mare proprio di fronte alla costa di Lampedusa. Shauba affonda inesorabilmente e quasi paradossalmente, affoga e rievoca la sua breve esperienza di vita, i suoi affetti, i colori del suo paese, le sue speranze, le motivazioni che l’hanno indotta a fuggire dalla sua terra («non si può rimanere nel luogo in cui si nasce, se hai la certezza che in quel luogo vive pure il tuo carnefice»): il tempo di uno spasimo, pochi istanti che si dilatano ad accogliere e ricapitolare il senso di una vita, di un viaggio, di un futuro stroncato, il senso del tradimento nei suoi confronti dell’occidente “capitalista” (in cui lei era pur pronta a integrarsi). Rievoca gli istanti tremendi della sua caduta in mare Shauba, dal rovesciarsi di quel barcone zeppo di settecento immigrati, di quella carretta che si ribalta proprio mentre lei sta per esser violentata dagli scafisti, cani che s’azzuffano per il suo corpo di giovane donna come per un pezzo di carne, fino al momento in cui lei (ma il suo corpo è già un’altra cosa), stremata ed esanime, tocca il fondale. La scrittura scenica è pulita, i colori netti, non ci sono musiche (scelta davvero interessante), né ridondanze espressive che tradirebbero la tremenda semplicità dell’accadimento, quasi ogni parola respira col suo tempo esatto e la profondità che questa vicenda implica in quanto tale: si percepisce chiaramente che coincidono regista e drammaturga. Eppure, se qualcosa appesantisce questo lavoro, è proprio l’esplicitarsi della riflessione critica e apertamente politica, il ragionare sul tradimento dell’occidente e sulla sua ostile indifferenza rispetto a quanto accade nel Mediterraneo: quel che succede a Shauba, il suo corpo che affonda e diventa pasto per i pesci, è un urlo politico in sé, lacerante e durissimo, non occorrono parole per spiegarlo, per definirlo e situarlo. Se noi italiani, se noi europei non capiamo il senso di quel che accade a Shauba siamo già perduti; se il Mediterraneo si è trasformato, in questi ultimi anni soprattutto, in uno sterminato cimitero sottomarino, forse dovremmo capire davvero che questo cimitero altro non è che l’immagine reale che l’Occidente dà di sé riflettendosi nel mare. «Il mare è innocente» dice, a un certo punto dello spettacolo, Shauba ed ha ragione.
Lampedusa Beach
- Scritto da Paolo Randazzo
- Visite: 3980