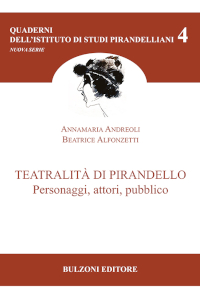Ho visto recentemente due spettacoli che mi hanno fatto riflettere su alcuni importanti aspetti del lavoro teatrale: si tratta di riflessioni che vorrei, credo utilmente, porgere ai nostri lettori. Mi riferisco a Play, portato dal gruppo di danzatori-acrobati-ginnasti Kataklò, al teatro Vittoria di Roma, e a Il dio della carneficina, testo arcinoto e di successo europeo, di Yasmina Reza, messo in scena presso il teatro romano Eliseo, con la regia di Roberto Andò, e interpretato da quattro “assi” delle scene e del cinema italiani: Silvio Orlando, Anna Bonaiuto, Alessio Boni, Michela Cescon. Voglio anche ricordare che del testo della Reza si dispone di un'edizione recente (2008), per i tipi della Arcadia&Ricono, con la traduzione di Alessandra Serra, alla cui lettura invito. Vorrei ora dedicare, quasi a mo' di recensione lampo, un poco di spazio a ciascuno dei due spettacoli.
Play (s'intende in italiano “gioco”, ma anche azione scenica, rappresentativa) è l'ultima creazione della coreografa, allieva di Pendleton, Giulia Staccioli, magnificamente coadiuvata da Jessica Gandini, e per le scene e i costumi da Sara Costantini, per le musiche dalle creazioni dell'autore jazz-lounge Ajad, per l'illuminazione e il suono da Andrea Mostachetti; sulla scena agiscono i danzatori, acrobati, mimi, ginnasti, attori, Maria Agatiello, Elisa Bazzocchi, Paolo Benedetti, Eleonora Di Vita, Leonardo Fumarola, Serena Rampon, Marco Ticli, Marco Zanotti. Diviso in due tempi lo spettacolo è costituito da 22 coreografie dedicate alle varie discipline sportive (non per niente è stato ospite in Cina in occasione delle recenti Olimpiadi): dal tennis alla pallavolo, dal salto con gli sci al calcio, dal ciclismo al pugilato, e così via. Ogni quadro, magnificamente “sostenuto” da un funzionale e assai creativo gioco di luci, di atmosfere luminose stupefacenti, e da un tappeto sonoro musicale di assoluto rilievo, segue, per l'intuito espressivo della Staccioli, una linea coreutica impostata sulle metafore, che spiazzano, sorprendono, catturano l'attenzione dello spettatore, e lo immettono in un flusso di immagini, ritmi, gesti, movimenti che trapassano dall'ironia comica al sentimento puramente poetico, dove le canoniche “posizioni” e “gestualità” di ciascuno degli sport rappresentati divengono poi dei pretesti, per assolutizzare anche formalmente la creazione coreografica che finisce per superare il referente di partenza e divenire pura significazione artistica, puro gesto, pura parola (nei rari casi in cui essa è presente), puro rapporto suono-azione. Gli otto meravigliosi “attori” (perché non c'è vera separazione fra teatro agito e teatro danzato) raggiungono una piena libertà espressiva, agendo appunto sul piano della metafora e sovrapponendo vari strati di significati che scaturiscono dal primo input offerto dalla disciplina che è alla base di ciascuna azione coreografica. Insomma spettacolo davvero coinvolgente, di altissimo livello qualitativo, dove si coniugano in pienezza creativa tecnica e poesia scenica.
Il dio della carneficina è, diversamente da Play, la messinscena di un testo drammaturgico di partenza, è teatro meramente di parola, dove si affrontano temi sociali e nevrosi personali molto attuali; il regista Andò, nelle sue note di regia, sottolinea la struttura di divertissment del testo della francoiraniana Yasmina Reza, senza negare un non-detto, o dei sottotesti, che avrebbero ben poco di divertente, semmai si tratta di un sottofondo di ferocia, oscuro, rattenuto, barbarico, fino al punto di costituire “un piccolo trattato morale di teoria della cultura”. Il plot è molto semplice: Véronique e Michel Houillè, genitori del piccolo Bruno, ricevono in casa Annette e Alain Reille, genitori di Ferdinand, il quale ha colpito al volto il loro figlio durante una lite. Le due coppie vogliono incontrarsi per regolare la disputa all'insegna del buon senso civile, ma le buone intenzioni (che per l'autrice evidentemente non servono a ricomporre alcun conflitto) naufragano nell'incapacità di comprensione fra le due coppie. La commedia è tutta nei dialoghi fra i quattro protagonisti, dialoghi svolti su una lingua media, della medio alta borghesia francese, infarcita di modi di dire, di frasi fatte, di allocuzioni, di termini chiave, riportabili alle mode espressive massmediatiche. Sono personaggi la cui coscienza è davvero infelice, perché “sanno” le possibili soluzioni di un vero dialogo, ma nell'intimo non riescono a percorrerle fino in fondo, il sacrificio di se stessi non è un prezzo sostenibile. Va detto, ora, che lo spettacolo è inevitabilmente altamente gradevole per una platea “media”, supportato da quattro mostri sacri sopracitati, che danno davvero il fritto per conquistare i favori del pubblico stesso.
La regia asseconda anche con notevole inventività quanto richiesto dal testo: niente naturalismo nella scena e nel decor, se non il minimo indispensabile che riporta a un salotto decoroso e tipico di una famiglia pseudo “intellettuale”; sottolineatura dei frequenti ed efficaci mini colpi di scena, sommariamente riconducibili ai tentativi di ricomposizione fra le coppie che sembrano essere sul punto di realizzarsi, per poi naufragare; l'esterno, il fuori scena preme (una vecchia madre che telefona per i suoi acciacchi; un secondo figlio che chiama disperato perché il padre, Michel, ha portato fuori casa il suo amato criceto, i produttori di una multinazionale del farmaco che premono sull'avvocato Alain per chiudere transazioni commerciali poco oneste). Tutti interventi che sviano, riportano il dialogo al punto di partenza, riportano i protagonisti alle loro abitudini di vita ormai catafratte, e va detto che le linee psicologico-comportamentali dei personaggi vengono magnificamente rese dai quattro interpreti.
Evidentemente non c'è alcun cambiamento di rotta nei quattro, nessuna metanoia, che ribalti il corso delle loro azioni, parole e pensieri. Possiamo anche spiegarci il successo non solo italiano della commedia divertissment della Reza, configurandola come uno specchio dove la società media e di massa d'oggi può vedere se stessa con autoindulgenza, divisa fra teoria morale incerta, relativistica, superficiale, e prassi egoistica, coartata, succube di modelli imposti e vincenti; ci sarebbe il diritto, la giustizia a poter regolare i rapporti (le due coppie potrebbero andare in giudizio per i danni riportati dal ragazzo colpito), ma nel momento in cui si vuol scegliere una soluzione che vada oltre, i quattro protagonisti si rivelano incapaci di quello che potremmo definire un vero dialogo, un rapporto dialogale, non dialettico, fondato cioè sulla messa in crisi di se stessi che l'altro può far scaturire.
Entrambi gli spettacoli mostrano e dimostrano un bagaglio tecnico di alto livello: in Play è la tecnica della azioni fisiche coreutiche a primeggiare, accompagnata da una, appunto, illuminotecnica perfetta, da un'emissione del suono inappuntabile; in Il dio della carneficina è la tecnica di composizione del testo, sia dal punto di vista dell'intreccio, che della configurazione dei personaggi, a risaltare, come pure sulla scena è la tecnica attoriale a mettersi in mostra, nella magnifica recitazione di Orlando, Boni, Bonaiuto, Cescon. Ma cosa vuol dire tecnica a teatro? In che consiste la techné, il saper fare? I maestri del Novecento teatrale, i Padri fondatori, ci hanno insegnato che in scena occorrono assolutamente due condizioni dell'agire: la precisione e il controllo, e assieme la capacità di essere autonomi e originali e inventivi, pur nell'ambito predeterminato della partitura.
Ciò vale per ogni “autore” dello spettacolo teatrale. il drammaturgo, il regista, lo scenografo, e soprattutto, evidentemente, l'attore o danzatore che sia. Precisione e controllo garantiscono la “poesia” di uno spettacolo? Certamente no, ne sono però il presupposto, e direi che, nella fattispecie dei nostri due spettacoli, tale presupposto non manca affatto, anzi, è ben presente e pienamente realizzato, ma... a parer mio in Play, c'è “poesia”, il poiein, inteso come fare, anzi, ri-fare la vita in termini artistici, di, appunto, ars poetica, mentre in Il dio della carneficina, al di là di qualche micro azione, o battuta, o gesto, che suscitano una certa ilarità, un mini sommovimento della percezione che provochi delle reazioni nello spettatore, non si realizza quel tropismo assoluto che rivela allo spettatore una verità altra, una surrealtà che lo spettacolo inveri ed esprima, un significato polivalente che apra verso una rivelazione, una “rivoluzione” del senso: insomma dallo spettacolo non promana una vera poesia teatrale, sulla scena non si ri-fa poeticamente la vita. Dovrei circostanziare nei particolari quanto sostengo, ma mi limito ad invitare i lettori “motivati”, se sarà possibile, a vedere le due rappresentazioni, eppoi magari ad aprire un dialogo su quanto sostengo attraverso dramma.it.
Questo perché qui dovrei sottolineare cosa manca a Il dio della carneficina e il discorso si farebbe lungo, in sintesi a parer mio manca: una conclusione che scombini le posizioni di partenza delle due coppie di protagonisti, o sotto il profilo comportamentale, o dal punto di vista interiore, psicologico, di pensiero; manca la presenza dei due ragazzi il cui scontro apre l'intreccio della commedia; manca una vera ragion d'essere a trattare il soggetto come vero divertissment, o come pura commedia, o come dramma, o al limite come tragedia borghese. Infine una parola sulla drammaturgia “nostrana” che rivolgo a voi lettori. Pensate che la nostra letteratura teatrale manchi davvero di autori e di “modelli”, esempi, capaci di trattare temi simili? Vogliamo ricordare, per il carattere di divertissment feroce e “leggero” i plays di un Achille Campanile? O, per l'irruzione del tragico nel comico, un Eduardo e un po' tutta la scuola napoletana fino ad oggi? O viceversa per l'immissione del comico nel tragico, un Dario Fo e i suoi numerosi allievi oggi molto presenti nel nostro teatro, anche in veste di narrautori? E per i drammi o pseudo tali, di una borghesia nevrotica e falotica, non è grande autore un Manfridi? E dal punto di vista delle analisi sociologiche e di etica sociale possiamo dimenticare le lucide interpretazioni di un Baliani, di una Emma Dante, di un Fortunato Calvino? E per i dilemmi di coscienza, la ricerca di una verità, l'ansia di un rinnovamento, non valgono i lavori ormai maturi di un Marcello Isidori, di un Francesco Randazzo? E ancora per il grande tema della donna nella società d'oggi vanno dimenticate forse le pièces di una Maraini, di una Boggio, e tra le nuove generazioni di una Russo? E per un efficacissimo lavoro drammaturgico che sa coordinare e ricreare in un caleidoscopico quadro di teatro totale, possiamo trascurare il lavoro di un Alfio Petrini?
E l'elenco potrebbe continuare, ma dovrei aprire un doloroso contenzioso che separa autori, quelli autentici, da “mettitori in scena”, una delle sette (?!) piaghe del teatro italiano, che preferisce guardare oltre le Alpi e proteggersi con il sicuro successo che nulla sposta nelle coscienze di una Yasmina Reza!
Una riflessione a mo' di recensione
- Scritto da Giorgio Taffon