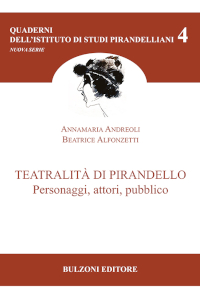Il nostro VII Napoli Teatro Festival Italia 2014 si apre con "Il sindaco del rione sanità" di Eduardo De Filippo. A trent’anni dalla morte, il drammaturgo viene ricordato e commemorato attraverso numerose manifestazioni, iniziative ed eventi. E anche il NTFI quest’anno presenta alcuni spettacoli
 legati alla figura di Eduardo.
legati alla figura di Eduardo.
Marco Sciaccaluga si cimenta per la prima volta con un testo eduardiano, il cui protagonista è Don Antonio Barracano, interpretato da un fenomenale Eros Pagni. IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ, in scena presso il teatro San Ferdinando di Napoli, il 7 e 8 giugno, è uno dei primi spettacoli che introducono al programma di questo Festival. Nonostante alcuni rimaneggiamenti del testo, questo viene riportato in scena rispettandone l’originaria volontà: basti notare gli abiti, l’interpretazione, la gestualità tipicamente napoletana ma con un linguaggio epurato, così come voleva Eduardo, da eccessivi dialettalismi. L’introduzione alla storia, infatti, viene modificata e la scena si apre con l’entrata di tutti i personaggi. Figurine stagliate sul fondo, emergono dall’oscurità e ascoltano il racconto del protagonista, per poi sparire dietro le quinte non appena la storia si materializza in scena. La presenza di Don Antonio, all’inizio figura solitaria che riempie il palcoscenico, crea una costruzione temporale a ritroso: il protagonista racconta ciò che è diventato, poiché ciò che è stato si materializza successivamente, attraverso il racconto testuale vero e proprio. Un piccolo monologo iniziale introduce dunque la storia di un uomo che proviene dalla povertà e dall’ignoranza: da ragazzo pascolava le pecore fino a quando, un giorno, assopitosi, venne picchiato ferocemente dal guardiano della terra confinante, poiché alcune pecore avevano sconfinato. L’ossessione nei confronti del guardiano trasforma il diciottenne Antonio. L’uomo ripete incessantemente che la legge è stata creata per imbrogliare la gente ignorante, per creare dei grovigli burocratici, trappole in cui le persone cadono, distruggendosi. Il boss è conosciuto e riverito presso il Rione Sanità, ma gran parte della vicenda si svolge a Terzigno, luogo di villeggiatura. La famiglia Barracano si è arricchita attraverso le attività di Don Antonio e tutti i membri dimostrano rispetto per un uomo e per una vita le cui leggi specifiche sembrano essere accettate da tutti. Anche lo spettatore si ritrova improvvisamente a seguire la vicenda attraverso il punto di vista del boss, poiché sembra che le leggi private appaiano le migliori, le più coerenti, le più utili a cambiare le situazioni e gli uomini. Testo attualissimo, che non vuole essere una descrizione della camorra, né unicamente di una famiglia che si affida ad azioni camorristiche per vivere, poiché ciò che si vuole comunicare al pubblico sono soprattutto le cause e gli effetti di una condotta atipica, all’interno di una dura analisi della società. Nonostante, in effetti, la matrice malavitosa sia il fondamento della storia, l’insegnamento finale è universale. Antonio Barracano parla di ignoranza, il male peggiore dell’umanità, poiché permette al potere di utilizzare la legge e di trasformarla a suo piacimento. “ Da qui il sogno delirante di farsi giustizia da solo, di farsi carico del compito di rimettere il mondo in sesto, di contrapporre alla formalità della legge sociale, i valori di una moralità arcaica, di cui egli si è eletto a depositario, con finalità di redenzione”, il regista sottolinea, dunque, il nodo fondamentale della vicenda e del personaggio. Barracano non sa leggere, riesce a malapena a scrivere la sua firma, e il suo potere deriva proprio da questo. Il suo essere debole davanti alla legge lo spinge a crearne una maggiormente fruibile ed adatta al popolo ignorante. Il cibo diventa elemento ricorrente, così come il mangiare, l’ingozzarsi, la fame di giustizia, qualunque essa sia. Il collegamento è evidente: ignoranza- fame, giustizia ( quella di Barracano)- benessere. Il boss non sarebbe tale se all’interno del suo ambiente non emergessero due personaggi contraddittori: il medico Fabio Della Ragione ed Arturo Santaniello, il fornaio arricchitosi. Due nomi, due figure. Il dott. Della Ragione, nome non casuale, come sottolinea lo stesso regista, è il braccio destro, umile servitore del Barracano, interpretato da Federico Vanni. Durante tutta la vita ha assecondato la legge e il volere del Barracano, più volte minacciando la sua partenza verso l’America. Ma rimane. Fino alla fine, fino alla morte del boss. La svolta avverrà proprio nell’ultima scena. Il seguito non lo conosciamo e l’interrogativo rimane: perché non ribellarsi prima? Perché aspettare fino alla morte? Perché affidarsi, dopo, alla legge ufficiale? La morte di Barracano distrugge il punto di riferimento attorno a cui gravitano tutti i personaggi, compresso Arturo Santaniello, uomo viscido e arricchito che però sostiene la sua causa di onestà. Il fornaio, interpretato da Massimo Cagnina, minacciato di morte dal figlio, del quale veste i panni Orlando Cinque, è illeso, ma solo corporalmente e non finanziariamente, perché la legge del Barracano rispetta la vita dei padri e dei figli ma non lascia incompiuta l’opera. Sarà proprio lo scontro tra i due a ferire mortalmente il boss, che si accascia, in una scena memorabile del Pagni, durante l’ultima cena. Né vinti, né vincitori. Il testo lascia aperte tutte le riflessioni possibili. All’interno di una costruzione scenica ed attoriale di stampo tradizionalistico ma non antiquato, la scenografia di Guido Fiorato appare, invece, innovativa, contemporanea, asettica. Un palcoscenico in pendenza accentuata, che rende difficili gli spostamenti degli attori: a volte in salita, a volte in discesa, gli alti e i bassi della storia e delle decisioni. Ai lati persiane macroscopiche filtrano la luce esterna. Gli interni entrano in comunicazione con l’esterno solo attraverso queste persiane appena aperte, o attraverso la porta sul fondo, accostata o chiusa del tutto. Il pavimento a quadroni grandi, il mobilio e i tavoli rettangolari posti in diagonale, come ad indicare i rapporti che si intersecano tra i personaggi e le vendette che si innescano, tutto sembra geometricamente stabilito. Nell’ultimo atto però, quello di ambientazione napoletana, il soffitto quadrato si abbassa e pende da un lato: il macigno che incombe sulle teste di tutti sta per cedere. La morte di Barracano è imminente. Affidata, nella scena finale, al dott. Della Ragione, la teoria di Don Antonio riecheggia così: “può darsi che da questa distruzione viene fuori un mondo come lo sognava il povero don Antonio, «meno rotondo ma un poco più quadrato»”. E quadrata è anche quella carta che si trasforma in busta per contenere il simbolo della vera giustizia: il denaro. Ottimo il cast di questo bel lavoro che appare profondamente drammatico, nonostante alcuni momenti appaiano più leggeri, nonostante la natura linguistica non napoletana di alcuni attori, e nonostante il pubblico, rumoroso e indisciplinato, che fa da protagonista continuamente, attraverso gli applausi a scena aperta. È d’obbligo riportare, quindi, il cast di questa produzione, costituito anche da giovani attori napoletani di grande esperienza, indispensabili per dare vita alle storie minori che si intersecano inevitabilmente con la principale: Eros Pagni, Maria Basile scarpetta, Angela Ciaburri, Marco Montecatino, Luca Iervolino, Federico Vanni, Massimo Cagnina, Orlando Cinque, Francesca De Nicolais, Dely De Majo, Rosario Giglio, Pietro Tammaro, Gennaro Apicella, Gino De Luca, Gennaro Piccirillo. CAFFÈ NÉMI ROVSKY
CAFFÈ NÉMI ROVSKY
Il Festival continua all’interno del Ridotto del Mercadante, luogo in cui debutta uno spettacolo letterario a puntate. Parliamo di CAFFÈ NÈMIROVSKY, che andrà in scena nel corso di diverse date: dal 9 al 22 giugno presso il Ridotto, e il 16 giugno presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, dove si replicherà la lettura del 9 giugno. E proprio di quella ci accingiamo a parlare. Protagonista è la brava attrice Sara Bertelà ( i prossimi appuntamenti vedranno in scena invece Cristina Donadio, Angela Pagano. Margherita Di Rauso, Manuela Mandracchia, Anna Bonaiuto), osservata ed applaudita durante la stagione, nello spettacolo “Una specie di Alaska”, e che ritroviamo in scena anche durante il Festival. Parliamo di un progetto curato da Patrizia Bologna e Stefania Maraucci, produzione del Teatro Stabile di Napoli. L’attenzione posta su Irène Némirovsky fa riscoprire una delle scrittrici di inizio Novecento, di origine russa, ebrea ma convertitasi al cattolicesimo e trasferitasi in Francia, deportata poi ad Auschwitz ed uccisa lì nel 1942. Piccoli brani, brevi storie vengono portate in scena attraverso la voce e l’interpretazione di attrici intense. Numeroso il pubblico e per lo più composto da donne. Il caffè a cui fa riferimento il titolo è dovuto al particolare allestimento della scena: tavolini rotondi, un pianoforte, un leggio. Alcuni spettatori si accomodano ai tavolini, altri in platea, creando un contatto continuo tra lo spazio di solito riservato agli attori e quello occupato dagli spettatori. L’attrice, accompagnata dal pianista Paolo Coletta e dalle musiche di tradizione russa, è protagonista di un reading recitato. Non si tratta, infatti, di sola lettura, poiché la Bertelà non si ferma solo alla caratterizzazione delle voci dei vari protagonisti, ma le sue mani, i suoi piedi, le sue vene pulsano attraverso la recitazione e l’immedesimazione. Ecco perché si può parlare di reading recitato. Se all’inizio la formula del reading fa storcere il naso a qualche spettatore, successivamente il pubblico segue in silenzio il racconto. Il primo, intitolato IL BALLO, è stato scritto nel 1928. Si racconta di Antoinette, figlia di ebrei arricchitisi improvvisamente, ragazza adolescente che assiste alle scelte bizzarre ed ipocrite dei genitori. Il ballo è una di queste: la madre cerca di organizzare un evento in casa, invitando i membri della società che conta, cercando di dimostrare alla città che anche i Kampf sono ricchi e possono far parte di un certo ambiente. Il rapporto violento tra madre e figlia si acutizza durante i preparativi della festa. La ragazza, adolescente, vorrebbe ricevere maggiore considerazione ed essere trattata da adulta, ma la madre e il padre sono troppo impegnati nella loro ascesa verso l’alta società. Il ballo sarà un fallimento, perché Antoinette non spedirà i numerosi inviti compilati con pazienza. La vendetta dell’adolescente nei confronti della madre, scioglierà, nel finale, il rapporto tra le due, facendo apparire la donna forse finalmente consapevole dei suoi errori. Naturalmente ci ritroviamo davanti ad una critica della società borghese arricchita e il racconto, nonostante la sua scrittura sia collocata dopo la Prima Guerra Mondiale, sembra mostrare tocchi di romanticismo francese ottocentesco, e ricorda anche particolari personaggi femminili come la Jo di Piccole donne, romanzo inglese di metà ottocento, o la figura di Emily Dickinson, il tutto condito con un tocco di ibsenismo. La formula del reading, dopo un primo attacco rigido, propriamente più vicino alla lettura e al racconto, piuttosto che all’interpretazione, successivamente diventa immedesimazione. Il pubblico incuriosito vuole conoscere la fine, l’attrice alterna la sua natura tra la ferocia ridicola della madre, la curiosità della protagonista, la presenza dell’insegnante inglese, la passività del padre, l’arcigna e rigida caratterizzazione della maestra di piano. Buona la fusione tra parola e musica, poiché si amalgamano all’unisono, soprattutto in alcuni momenti in cui il racconto raggiunge una tensione maggiore. Si tratta di un’interpretazione che regala un flusso di parole con un ritmo ben preciso ed, infatti, quando a volte qualche frase si inceppa, zoppica o viene ripetuta, purtroppo musica e parole si slegano, per poi riprendersi e riallacciarsi più avanti. Intensa, come sempre, l’interpretazione della Bertelà, che ancora una volta riesce a piangere, in scena, dando quel tocco di sentimentalismo larmoyant che affiora dal testo e che caratterizza la tradizione ottocentesca. Le lacrime qui vengono però contrastate dalla volontà della giovane, che si ribella agli stilemi, poiché desidera vivere, piuttosto che sognare. La donna europea vive il difficile passaggio dall’Ottocento al Novecento e alla guerra, ed è inevitabile che ciò si evinca anche nei testi letterari.  FINALE DI PARTITA
FINALE DI PARTITA
Il Teatro Nuovo di Napoli è sede dello spettacolo allestito da un regista straniero. Una delle collaborazioni tra il Festival e l’Estero si concretizza nella figura del regista spagnolo Lluìs Pasqual. In scena, il 9 e 10 giugno, lo splendido testo di Samuel Beckett, FINALE DI PARTITA.
Protagonisti Lello Arena, Gigi De Luca, Stefano Miglio, Angela Pagano, rispettivamente nei panni di Hamm, Nagg, Clov, Nell. La scena di questo spettacolo rispetta la didascalia originaria: ambiente vuoto, due bidoni della spazzatura, due finestre, una porta, una poltrona. Ma qui le pareti sono bianche, anzi ingiallite, plastificate, issate come palizzate che dividono nettamente l’interno dall’esterno. Le due finestre non si aprono e non si chiudono. Il fondo- cielo è grigio. Di là il mondo in sfacelo, di qua l’umanità superstite che si sgretola. I due bidoni sono interrati, come botole che guardano ad un mondo sotterraneo ed oscuro. La sabbia nera, unico elemento che lega l’interno all’esterno, è sparsa ai piedi delle mura, pulviscolo nero che si accumula all’interno, forse perché è entrato dagli spifferi della porta e delle finestre, o forse simbolo della natura che sta ingoiando tutto. Il regista Pasqual afferma di aver voluto dare un tocco napoletano ai suoi personaggi, giocando maggiormente sull’ironia piuttosto che sullo sfacelo. O meglio, evidenziando la ricerca di sopravvivenza attraverso l’ironia, quando si è consapevoli che tutto, lì fuori, non esiste più. Beckett, esponente del filone definito da Martin Esslin “Teatro dell’assurdo”, fa parte di una cerchia di autori europei che, reduci dalla Seconda Guerra Mondiale, non ricercano più l’introspezione psicologica di cui parlava Pirandello ad inizio secolo. Non cercano ma testimoniano. Commentano, in un circolo vizioso, ciò che non ha fine né inizio, ciò che non porta a miglioramenti né a speranze, ciò che resta e attraversa il declino. Hamm sopravvive alla sua cecità grazie alla presenza di Clov, servo di scena, colui che gli dà “la battuta”, in questa immensa commedia ridicola che è l’umanità e il mondo. E il riferimento alla partita, al finale di partita, è appunto legato alla fine di una storia, o della Storia, in un momento in cui microcosmo e macrocosmo sono entrambi sullo stesso piano ed entrambi decaduti. Apparentemente legato ad una storia privata, il testo in realtà è profondamente astratto ed universale insieme. Anche qui, come nel Godot mai arrivato, si gira in tondo aspettando un’evoluzione che in realtà non si desidera, richiamando a sé la morte che è l’unico vero finale degno di applauso, aspettando una partenza, un allontanamento, quello di Clov, reiterato e poi, forse, effettuato. “L’uscita di scena finale”, quella di Clov, in realtà nel lavoro di Pasqual viene smorzata, poiché Hamm non vede e non sente risposta, ma Clov rimane in scena, con la sveglia in mano. Forse un’apertura piuttosto che un finale, forse la speranza è la reiterazione infinita. Il regista sottolinea l’arduo lavoro nella comprensione dei ritmi che Beckett ha trasferito nel suo testo: pause, silenzi, metrica. Appare complesso, dunque, lo studio di un testo del genere, ma soprattutto la sua interpretazione è ardua. Durante le prove a cui abbiamo assistito, il lavoro di Pasqual è apparso certosino: ogni frase, ogni parola, ogni virgola, ogni punto, diventano elementi da studiare approfonditamente, poiché è impossibile lasciarli al caso. Studio accurato anche sui movimenti, sulle espressioni del viso e degli occhi, sulle posizioni, soprattutto per i due attori immersi nelle botole. Il lavoro registico non si ferma solo alle posizioni, ai movimenti o all’intonazione, ma tutti questi elementi vengono regolati puntigliosamente da Pasqual, ad ogni battuta, ritrovandosi egli stesso sul palco a recitare con gli attori. Proprio per questo motivo il risultato ci sorprende e ci meraviglia, sia positivamente che negativamente. Mentre da un lato i due attori che fuoriescono dalle botole, Gigi De Luca e Angela Pagano, appaiono con volti pittati da clown e danno vita a due ottime interpretazioni in cui l’ironia offre la giusta dose di riso e di amaro insieme, dall’altra parte Hamm e Clov, i due personaggi principali, sembrano avere un stile completamente differente. Il regista afferma di aver voluto evitare un’ esecuzione meccanica, problema spesso riportato in alcuni allestimenti di “Finale di partita”, poiché, secondo lui, è importante considerare le pause e la frammentazione del testo beckettiano, ma senza dare aridità all’esecuzione. Per questo motivo, probabilmente, Lello Arena e Stefano Miglio si adagiano su una recitazione dai toni più popolareschi, con accenti dialettali evidenziati, con piccoli tocchi di improvvisazione, evitando, quindi, un ‘interpretazione rigida a cui siamo di solito abituati. Il problema si pone, però, nel confronto con gli altri due attori che, nonostante la cadenza napoletana ed alcune piccole espressioni ( contenute) tipicamente partenopee, trasmettono comunque un senso di angoscia, disfacimento e morte. Purtroppo non riusciamo a cogliere positivamente l’interpretazione di Lello Arena e soprattutto di Stefano Miglio, poiché i due personaggi non riescono a raggiungere un ritmo univoco, calpestando a volte le battute l’uno dell’altro e soprattutto Miglio, a tratti sembra recitare con accento napoletano, a tratti pugliese, a tratti siciliano, senza fornire una ben precisa identificazione di suono e lingua. Nella scena finale, inoltre, Hamm, che sin dall’inizio indossa una vestaglia ricca di colore e di ornamenti, come un mago estrae dal taschino il fazzoletto, pulisce gli occhiali, getta il cane, si toglie il fischietto dal collo ed interagisce con il pubblico, dicendo che il fischietto è un regalo, intimando gli spettatori di aspettare, scherzando sull’attesa. Il pubblico ride, così come succede anche nel corso dello spettacolo. Del resto << non c’è niente di più comico dell’infelicità>> dice Nell. Ma qui, nonostante il gusto della macchietta e della battuta, implicito nel testo beckettiano, non ritroviamo, invece, l’enorme angoscia dell’umanità decaduta, monca e cieca, che ci fa ridere, è vero, ma che dovrebbe anche farci riflettere.
Napoli teatro festival - I parte
- Scritto da Emanuela Ferrauto
- Visite: 4062