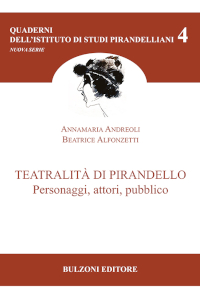Con il tuo ultimo lavoro, Robinson Crusoe il Betseller, mi sembra tu abbia avviato una indagine sulla genesi e sulle modalità dell’invenzione narrativa e drammaturgica, genesi e modalità ineluttabilmente fondate sulla parola e sulla scrittura come tramite per dare sostanza ed esistenza ad una storia. È come affondare le mani in un archivio indistinto ed indisciplinato, strutturarlo in scena e dare senso, un senso nuovo ai tanti significati potenziali. È una impressione corretta?
Ricordo un’opera molto giovanile di Giulio Paolini (non riesco a datarla ma erano gli ultimi anni Sessanta): una tela bianca sulla quale l’artista aveva appoggiato un campionario di colori e un tiralinee; era un metadiscorso: facciamo il punto, cioè incominciamo a catalogare gli strumenti; ma, se vogliamo, significava anche: “Sono qui”, perché nell’opera figurativa si legge sempre il gesto dell’artista; si rivela nella pennellata sontuosa del grande maestro ma anche nell’accostamento
intenzionale e malizioso di questo oggetto a quello. Negli anni, quel gesto, pur museificato, continua a esprimere, immutabile, la sua dinamica e le sue potenzialità. Sulla scena, tutto è instabile e inoltre le possibilità combinatorie degli strumenti (dei linguaggi) che agiscono sono pressoché infinite: l’interpretazione dell’attore, nella sua complessità vocale e gestuale, si confronta con lo spazio scenico, che a sua volta viene modificato dalle luci e dalle musiche; si genera dunque una rete di relazioni e di segni continuamente mutevoli: ogni battuta cambia di senso a seconda che sia pronunciata sotto la luce di un sagomatore o di un riflettore da mille, per non parlare poi di un’eventuale gelatina colorata, che produrrebbe un’ampia gamma di connotazioni, kitsch, parodistico, risonante o straniante. Per venire finalmente a Robinson Crusoe, il best seller, il progetto è quello che tu hai individuato: entrare nell’archivio (degli archetipi?), scegliere due macchine produttrici di senso – il romanzo, il linguaggio drammaturgico – collocarle sul palcoscenico e metterle in azione tentando di gestire i loro percorsi. E’ evidente che si tratta di un’impresa avventurosa, anzi, come tu suggerisci, dominata dall’indisciplina; il materiale narrativo, portato sulla scena, non può non trasformarsi in monologo – nonostante la ormai lunga tradizione e gli esempi illustri di teatro classificato “del racconto”, mi sembra che l’attore non possa fare a meno di impadronirsi del romanzo e di indossarlo, a meno che non si rifugi in un’interpretazione neutra che è difficile anche soltanto da immaginare; dal canto suo, la macchina drammaturgica procede, direi inevitabilmente, per sentieri non lineari, si frammenta nel dialogo, si distrae dal fine della narrazione per soffermarsi su un rapporto, su un tempo vuoto divagatorio, su una singola battuta che non esprima alcuna istanza di racconto. Per di più, in questo Robinson, entra una terza componente narrativa, che è il film al quale Defoe affida il compito di supportare la fabula del romanzo che ha in mente di scrivere – e bisogna dire che le immagini, volutamente approssimative e reticenti (Defoe ha girato il suo promo con un budget decisamente ridotto), svolgono egregiamente il loro compito: mostrano l’isola, per quanto non esotica al punto giusto, un Robinson (sia pure fuori età) e perfino un Venerdì abbastanza credibile, anche se non abbastanza rousseauiano. Ma, come dice il personaggio di Defoe, tutto ciò non è che una sinossi visiva che lui deve rinforzare narrando: siamo dunque immersi nel racconto di un racconto. Di conseguenza, sul palcoscenico la storia esiste ma non ha sostanza, e quella alla quale assistiamo è la riscrittura di un mito universalmente noto ma non più ripercorribile. Dentro questo involucro ormai svuotato del mito si consuma la fatica di un raccontare impossibile ma che mi pare, tuttavia, una base dalla quale ripartire, nel disincanto.
Tu hai una esperienza e quindi una sapienza per così dire multimediale e multisegnica, grazie ai tuoi trascorsi sia professionali che accademici. In che maniera la contaminazione di stili e di linguaggi può essere, se può esserlo, efficace nel rinnovare la forza dell’espressione teatrale che oggi tante critiche riceve?
Credo di aver molto lavorato sulla contaminazione. Negli anni Settanta, ad esempio, affiancai Carlo Quartucci come drammaturgo e si può dire che la contaminazione era alla base dei nostri spettacoli. Mi ricordo, ad esempio, Il romanzo di Camion, con Carla Tatò e Gigi Mezzanotte, nel quale lavoravamo sulla profonda dicotomia fra Carla, narratrice di un romanzo che raccontava le storie ipotetiche della compagnia (una specie mise en abime che poteva ricordare Le Roman Comique) mentre a Gigi veniva affidata il ruolo istrionico di un attore che vagava per lo spazio scenico, solitamente ampio, ove trovava reperti di citazioni dal grande repertorio. Il romanzo aveva una sua consistenza fisica e troneggiava su un leggio messo in evidenza. A volte venivo scaricato io stesso, col mio tavolino e la mia macchina da scrivere, come materiale dello spettacolo, che andavo scrivendo anche in diretta. Negli stessi anni, portai al Festival di Spoleto un mio spettacolo, Felina, nel quale scorreva un film i cui personaggi, ritratti a figura intera e a misura naturale, passeggiavano avanti e indietro su uno schermo di tre metri, dialogando con un’attrice (Marzia Ubaldi), unico elemento umano dello spettacolo, che pareva caduta sul palcoscenico come espulsa dal mondo immateriale del film. In quegli anni, pareva del tutto logico, anzi fisiologico accostare e combinare linguaggi. Mi sembra che nel tempo il gioco della contaminazione sia stato accompagnato da un giovanile entusiasmo che definirei “da piccolo chimico”, o “per vedere l’effetto che fa”, come direbbe Jannacci. Non so, francamente, se la contaminazione, oggi, possa essere un buon ricostituente per il teatro; forse, perché avesse effetto, dovrebbe essere accompagnata da una maggiore consapevolezza drammaturgica.
Da oltre un secolo si profetizza la fine del teatro destinato per taluni a soccombere di fronte ai nuovi strumenti di comunicazione di massa. Eppure questi stessi strumenti per essere efficaci sembrano ancora e sempre dipendere da modalità estetiche che nascono e sono nate dal teatro. Ritieni che, in questo contesto, il teatro sia destinato a recuperare anche quantitativamente la sua presenza ed influenza sulle società contemporanee?
Non credo alla fine del teatro, o per dir meglio: non credo che in tempi immaginabili qualcuno avviterà una lastra di marmo sulla sua tomba; temo, piuttosto, qualcosa di più avvilente: una progressiva perdita di forza del teatro – e ciò a causa della corrosione dell’istituzione teatrale; le cause sono molteplici e sarebbe lungo elencarle tutte; metterei solo in primo piano – , per strano che possa sembrare, nessuno ne parla – il venir meno della critica. Per discutibili che potessero essere alcune recensioni degli anni Sessanta, esse affermavano, se non altro, una necessità primaria: lo spettacolo teatrale chiede di essere letto, e questa lettura necessita di strumenti interpretativi; il critico, dunque, non è tanto (o non solo) il mediatore fra il palcoscenico e il pubblico, ma piuttosto (e primariamente) il testimone di un’esigenza metodologica, senza la quale il medium più diffuso prevale e contamina (questa volta in senso distruttivo) ogni altra forma di spettacolo. Nel corso di un’intervista radiofonica, Luca Ronconi, richiesto se, secondo lui, il rapporto con la televisione avrebbe potuto giovare al teatro, rispose: “Non saprei dire, mi sembra che ci sia già tanta televisione nel nostro teatro”.
Al riguardo una delle accuse che spesso vengono rivolte al teatro è quello di essere elitario e dunque non sufficientemente popolare. Per te che hai praticato i nuovi media ed a lungo lavorato e studiato la televisione è una accusa fondata?
Mi sentirei di rispondere che per certo teatro è vero ma che non si tratta di un’accusa. Credo che ogni spettacolo messo in scena sulla base di una precisa idea drammaturgica, da Non andartene in giro tutta nuda a Ritter, Dene, Voss sia (e debba essere) in qualche modo elitario, cioè rivolgersi a un gruppo di persone che ha scelto di andare ad assistere a uno spettacolo, non che è capitato casualmente in un teatro così come avrebbe potuto finire in un qualsiasi altro locale. Un discorso analogo lo si potrebbe fare per la lettura: da qualche tempo si cerca di indurre i consumatori a leggere garantendo che si tratta di un’attività assolutamente facile e piacevole, cosa che induce il neo-lettore a chiudere con dispetto, sentendosi truffato, un libro che gli appaia come “troppo difficile” e, di conseguenza a cercare di navigare nelle acque della sottocultura letteraria oppure ad abbandonare del tutto la lettura. Come non avrebbe senso pubblicizzare le passeggiate in montagna garantendo che non sono per niente faticose, così non si può identificare il teatro con l’intrattenimento o col divertimento, concetti cardine dei media più forti.
Viviamo oggi in una sorta di circo barnum di messaggi e linguaggi che ci assediano fin quasi a travolgerci. Per te il teatro può essere un luogo per così dire di chiarezza e identificazione, come sembrerebbe indicare il tuo recente ritorno alle sue forme più tradizionali?
Da qualche anno, non riesco a ricostruire da quanti, circola l’espressione “spettacolo dal vivo”, sancita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Una volta coesistevano, in un unico crogiolo, il cinema, il teatro, il circo, la danza, la televisione, ecc. Mi sembra che questa distinzione, così ministeriale e asettica, delinei anche se sommariamente due universi; uno è quello della comunicazione elettrica; in esso i linguaggi si travasano e si rispecchiano l’uno nell’altro; la sua punta di lancia è il cellulare, lo strumento nel quale tutto si fonde e si confonde (la televisione, il cinema, la scrittura, il videogioco, la comunicazione vocale, la musica…).è il mondo della virtualità, quello in cui non si muore mai e nel quale, anzi, continuano a vivere, grazie ai grumi dei pixel, anche i morti, registrati quando erano vivi oppure rigenerati dai programmi di grafica virtuale; l’altro è il mondo dei viventi, cioè di coloro ai quali è consentito invecchiare (gli attori, con le loro rughe a volte gloriose) e morire. Non saprei dire se sono tornato a forme più tradizionali del teatro; forse dovrei chiedermi se le avevo davvero abbandonate durante le stagioni in cui erano maturati i frutti apparentemente più sperimentali del mio lavoro; forse (ancora) il mio lavoro è stato un aggirarmi fra le stanze di una casa che m’illudevo di poter conoscere esplorandola senza un metodo, quindi ripassando più volte per gli stessi corridoi e gli stessi vestiboli senza riconoscerli e soprattutto senza rendermi conto che, durante le mie esplorazioni, nuove stanze si andavano edificando a mia insaputa. Questa costruzione così mutevole e inquieta, e sorprendente, si colloca nella dimensione del deperibile, certamente non in quella di un eterno presente, fittizio e virtuale: è dunque un luogo di chiarezza, di identificazione, come tu dici, cioè una scelta di un campo, di un tempo nel quale le cose, fra il loro inizio e la loro fine, hanno una vita.