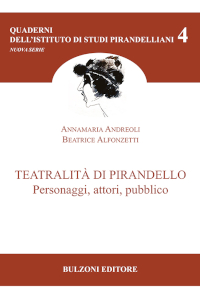Il nostro sguardo rivolto al NTFI 2015 si sofferma ancora una volta su alcuni spettacoli inseriti all’interno del programma del Fringe Festival. In realtà il nostro percorso si conclude proprio con gli spettacoli di giovani compagnie provenienti dal Sud Italia, e con un approfondimento su DINAMO, produzione internazionale che vede tornare Tolchachir sul palcoscenico napoletano.
L’esperienza con JERNEJ apre le porte ad un’atmosfera delicata che ricorda il racconto d’altri tempi. Il primo impatto con questo spettacolo sembra catapultare lo spettatore verso il racconto medievale che si allestiva nelle piazze e negli spazi aperti, riproducendo in scena il contatto con la tecnica del mimo, con il teatrino dei burattini ed il racconto popolare con morale finale. In realtà, ci spiega la protagonista, l’attrice Simona Di Maio, il racconto è ottocentesco ed
ha una provenienza legata alla cultura dell’Europa dell’Est. Ci sorprende, dunque, seguire la storia di questo anziano servo, Jernej, appunto che, dopo la morte del padrone, ricco proprietario terriero, viene messo alla porta dal figlio erede, poiché non è più utile al lavoro a causa dell’età avanzata. Jernej si chiede come è possibile essere cacciato da quella casa e da quella terra dove ha vissuto per quarant’anni e dove ha lavorato incessantemente, costruendo e producendo. La ricerca della giustizia sembra essere il tema principale dell’intero racconto, che si interseca poi con il concetto di proprietà privata, elemento fondamentale nella filosofia ottocentesca dell’Europa dell’Est, in contrasto a ciò che avveniva, invece, nella letteratura e nel teatro dell’Europa occidentale, ancora fortemente legati al Romanticismo, all’effetto larmoyant del melodramma e al nuovo dramma borghese. La semplicità di questa storia viene riprodotta in scena attraverso un’unica attrice che racconta, nei panni di Jernej, il viaggio del povero vecchio alla ricerca della giustizia, interrogando non solo le Istituzioni del villaggio, ma arrivando fino all’Imperatore, ritornando, senza successo, al luogo di partenza, ponendo la sua ultima richiesta di giustizia a Dio. Il racconto sembra collocarsi in un ambito culturale vicino al protestantesimo, soprattutto perché si ripete costantemente il concetto di lavoro legato al raggiungimento della grazia divina, anche se probabilmente non è questo l’ambito culturale di provenienza, piuttosto aderente, forse, al primo marxismo. Ma ciò che colpisce maggioramente è l’allestimento scenico che persegue il concetto di semplicità caratterizzante il testo. L’attrice, infatti, gestisce la scena da sola, attraverso l’utilizzo di tre panche di legno che, alternativamente, sono utili non solo come oggetti atti alla seduta, ma vengono trasformate in base all’esigenza dello spettacolo: diventanto porte del palazzo dell’Imperatore, sedile e portabagagli di una carrozza in viaggio, culla-letto per il vecchio che dorme all’aperto. Inoltre, il discorso dell’interpretazione di tutti i personaggi da parte della stessa attrice, come quelli seduti in un ipotetico Consiglio Comunale o presso la Corte di un tribunale, luoghi in cui il vecchio Jernej viene incessantemente giudicato e condannato, conduce ad un discorso sul’utilizzo della voce e del corpo. La lingua utilizzata, infatti, è l’italiano per il racconto ed il dialogo espresso da Jernej, ma per quanto riguarda gli altri personaggi, essi vengono caratterizzati da movenze o da suoni linguistici, più che da una lingua vera e propria. La trasformazione dell’attrice da un personaggio all’altro, è semplicemente resa scenicamente attraverso un movimento avvolgente delle mani sulla testa. La ricerca della giustizia è un viaggio metaforico in cui il vecchio servo rappresenta l’uomo errante, comune in numerose letterature e riconducibile ai personaggi biblici o inseriti nelle parabole. Accanto al protagonista compare una marionetta, tipica del teatrino dei burattini, dal volto raggrinzito ed anziano: questo escamotage spinge all’immaginazione lo spettatore, che riesce, così, a distinguere l’immagine del vecchio da quella della giovane attrice. Il grillo parlante di memoria collodiana, emerge qui attraverso una marionetta che consiglia, accompagna e fa riflettere il vecchio servo in viaggio. Anche questa è un’immagine profondamente simbolica e delicata che rappresenta il nostro vivere. Il protagonista porta con sé una valigetta di legno e l’attrice recita, danza e mima, indossando sulle spalle questa valigia-memoria: come la casa delle lumache, la valigetta si apre e mostra dentro il letto di Jernej-marionetta o la facciata della casa doveva aveva vissuto fino a poco tempo prima. Il senso del gioco, o del giocattolo antico, rende questo spettacolo parabola della vita intera, riconducendo lo spettatore ad un’osservazione infantile affinchè possa recuperare la purezza degli ideali e dei valori. L’ottima interpretazione dell’attrice, che dimostra doti attoriali e fisiche – basti pensare al cammino di Jernej rappresentato dalla stessa, appesa con le braccia alle due panche poste in verticale, mentre i suoi piedi camminano nell’aria- , è affiancata dall’ottimo lavoro di regia e di training di Simone Giannatiempo, attraverso il testo di un autore sconosciuto, curato dallo stesso Giannatiempo e da Maria Teresa Rovitto. Gli oggetti di scena, compresa la valigetta-casa-memoria sono stati realizzati da Monica Costigliola, Emanuele Palmisano e Luigi Schiattarella. La produzione del Teatro dei Colpevoli, che in parte confluisce con il Teatro del Baule, proviene da Napoli e concentra in un piccolo spettacolo le tendenze che abbiamo ritrovato sparse all’interno di questo Festival e che abbiamo rilevato come maggiormente apprezzate dal pubblico: il mimo, la clownerie, la musica, la danza, e soprattutto il racconto semplice che mette in luce l’uomo e la vita stessa. Il racconto di Jernej si conclude con una vendetta: la casa si colora di rosso e brucia. Ecco perché non possiamo considerare questo racconto legato ad una tradizione prettamente cristiano cattolica, bensì ad una cultura diversa che rivendica il concetto di proprietà privata, analizzandola sotto punti di vista diversi ed in relazione a situazioni particolari. Il Fringe Festival ci presenta un altro spettacolo, legato ad uno dei testi più importanti della letteratura europa: parliamo de “I demoni” di Dostoevskij. Il Progetto Demoni realizza uno spettacolo che viene presentato a Napoli con il titolo FINE DI UN ROMANZO, ma che in realtà deriva da un percorso più complesso in cui il romanzo viene de-costruito attraverso frammenti. Il progetto, quindi, è duplice: da un lato FRAMMENTI, destinato a pochi spettatori ed in luoghi non teatrali, dall’altro lo spettacolo FINE DI UN ROMANZO. Al Fringe Festival, dunque, si presenta in scena la conclusione del romanzo, cioè il momento in cui tutti i nodi si sciolgono ed i numerosi personaggi decadono, attraverso l’immagine di un muro che crolla ferocemente sciogliendosi in fango. Lo spettacolo DEMONI è stato ideato da Alessandra Crocco e Alessandro Miele, in scena nei panni di Marija e di Stravogin, coppia “simbolo” che ingloba in sé il senso del disfacimento, oltre alla presenza delle ottime attrici Mariarosaria Ponzetta e Rita Felicetti, e Giovanni De Monte. La creazione di questo lavoro non presume nessuna volontà di allestire l’intero romanzo, bensì prevale la tendenza alla frammentazione che però non rivela una descrizione- mosaico dei vari personaggi e di tutte le vicende collegate ma piuttosto presenta un’idea innovativa. Il romanzo si è concluso e la trama è letteralmente esplosa: cosa succede nella vita di tutti questi personaggi, pervasi da volontà ferree, da clamori, animosità, esistenze peccaminose che li trasformano in corpi invasati da demoni metaforici? Ma soprattutto, cosa resta di tutto questo? Difficile seguire la trama di un lungo romanzo i cui protagonisti sono molteplici e tutti indispensabili, e forse questa è la pecca di uno spettacolo che presume inevitabilmente la conoscenza dell’autore e del romanzo da parte dello spettatore, per comprendere a fondo chi siano i personaggi in scena, quali caratteristiche abbiano all’interno del romanzo e, soprattutto, quale sia il loro ruolo determinante. Nonostante la difficoltà di comprensione iniziale, lo spettatore comunque riesce a collocare l’dentità ed i rapporti di questi personaggi, alcuni di essi esclusi visivamente e scenicamente da questo lavoro, ma citati. Il senso del racconto post quem, della narrazione a ritroso quando tutto è già avvenuto, è un ruolo che viene assunto da tre dei personaggi in scena, membri del gruppo di giovani rivoluzionari o, aleternativamente, nei panni di altri personaggi descritti nel romanzo, interpretati da Rita Felicetti, Maria Rosaria Ponzetta, Giovanni Del Monte. Ognuno di loro è caratterizzato da una specifica fisicità e movimento, e soprattutto da una specifica indole. Ergendo Stravogin a capo di un gruppo rivoluzionario, i giovani seguaci osservano il personaggio come una divinità, irraggiungibile soprattutto perché oscura e silenziosa. E infatti egli attraversa la scena lentamente e silenziosamente, come durante una parata o un corteo funebre, mentre i tre rivoluzionari attendono un cenno. L’intero spettacolo è evidentemente presentato sottoforma di studio, poiché i “Frammenti” di cui parlavamo prima e che andranno in scena nei prossimi mesi ed in altri luoghi, si soffermano invece sui singoli personaggi. Questo lavoro sembra, dunque, assumere le sembianze di un trailer cinematografico che mostra ambientazioni, personaggi, tendenze del lavoro artistico ma che non svela tutto. Scene ridotte in cui vengono focalizzati alcuni personaggi e la loro indole, attraverso veri e proprio frammenti di testo, rielaborati e spesso non estrapolati fedelmente dal romanzo. Reiterati effetti di buio e di luce frammentano maggiormente l’allestimento scenico, mostrando al pubblico immagini-flashback, come se fossero i ricordi di un uomo in coma che riavvolge, nella sua mente, il nastro della vita passata. La rivoluzione ed il turbinio sociale e culturale che pervadono la vita di questi personaggi, sono elementi che identificano un determinato periodo storico ed un determinato luogo geografico: la coppia di innamorati rappresenta, dunque, l’unione pericolosa tra due ideologie e due classi sociali in eterno contrasto. Il momento di sconvolgimento storico-sociale viene rappresentato in scena attraverso una trasposizione verso il contemporaneo, che accenna a quella decadenza storica, politica ed intima, che persiste all’interno del romanzo russo. In questo modo si ironizza sul nostro stesso Paese, ai giorni nostri, e soprattutto si identificano i momenti di sconvoglimento, pubblico e privato, attraverso movimenti “tarantati” che seguono, però, le musiche dei più famosi e commerciali balli di gruppo latino-americani. L’ironia che pervade l’intero spettacolo, in realtà crea un’atmosfera di inquietudine costante che fa ripiombare lo spettatore, frequentemente, nella riflessione, sconcertato dai continui cambi di scena, dalle immagini frammentarie, nel tentativo ricorrente di chiudere gli occhi in ogni passaggio al buio, per riaprirli come davanti ad uno schermo cinematografico o televisivo, o davanti ad un ricordo riaffiorato nelle nostre menti. Il tempo ormai andato ed il testo classico vengono violati e spezzettati, per rendere innovativa la messinscena di questo studio, di cui aspettiamo, però, gli esiti e le successive evoluzioni.
Il Fringe Festival ci presenta un altro spettacolo, legato ad uno dei testi più importanti della letteratura europa: parliamo de “I demoni” di Dostoevskij. Il Progetto Demoni realizza uno spettacolo che viene presentato a Napoli con il titolo FINE DI UN ROMANZO, ma che in realtà deriva da un percorso più complesso in cui il romanzo viene de-costruito attraverso frammenti. Il progetto, quindi, è duplice: da un lato FRAMMENTI, destinato a pochi spettatori ed in luoghi non teatrali, dall’altro lo spettacolo FINE DI UN ROMANZO. Al Fringe Festival, dunque, si presenta in scena la conclusione del romanzo, cioè il momento in cui tutti i nodi si sciolgono ed i numerosi personaggi decadono, attraverso l’immagine di un muro che crolla ferocemente sciogliendosi in fango. Lo spettacolo DEMONI è stato ideato da Alessandra Crocco e Alessandro Miele, in scena nei panni di Marija e di Stravogin, coppia “simbolo” che ingloba in sé il senso del disfacimento, oltre alla presenza delle ottime attrici Mariarosaria Ponzetta e Rita Felicetti, e Giovanni De Monte. La creazione di questo lavoro non presume nessuna volontà di allestire l’intero romanzo, bensì prevale la tendenza alla frammentazione che però non rivela una descrizione- mosaico dei vari personaggi e di tutte le vicende collegate ma piuttosto presenta un’idea innovativa. Il romanzo si è concluso e la trama è letteralmente esplosa: cosa succede nella vita di tutti questi personaggi, pervasi da volontà ferree, da clamori, animosità, esistenze peccaminose che li trasformano in corpi invasati da demoni metaforici? Ma soprattutto, cosa resta di tutto questo? Difficile seguire la trama di un lungo romanzo i cui protagonisti sono molteplici e tutti indispensabili, e forse questa è la pecca di uno spettacolo che presume inevitabilmente la conoscenza dell’autore e del romanzo da parte dello spettatore, per comprendere a fondo chi siano i personaggi in scena, quali caratteristiche abbiano all’interno del romanzo e, soprattutto, quale sia il loro ruolo determinante. Nonostante la difficoltà di comprensione iniziale, lo spettatore comunque riesce a collocare l’dentità ed i rapporti di questi personaggi, alcuni di essi esclusi visivamente e scenicamente da questo lavoro, ma citati. Il senso del racconto post quem, della narrazione a ritroso quando tutto è già avvenuto, è un ruolo che viene assunto da tre dei personaggi in scena, membri del gruppo di giovani rivoluzionari o, aleternativamente, nei panni di altri personaggi descritti nel romanzo, interpretati da Rita Felicetti, Maria Rosaria Ponzetta, Giovanni Del Monte. Ognuno di loro è caratterizzato da una specifica fisicità e movimento, e soprattutto da una specifica indole. Ergendo Stravogin a capo di un gruppo rivoluzionario, i giovani seguaci osservano il personaggio come una divinità, irraggiungibile soprattutto perché oscura e silenziosa. E infatti egli attraversa la scena lentamente e silenziosamente, come durante una parata o un corteo funebre, mentre i tre rivoluzionari attendono un cenno. L’intero spettacolo è evidentemente presentato sottoforma di studio, poiché i “Frammenti” di cui parlavamo prima e che andranno in scena nei prossimi mesi ed in altri luoghi, si soffermano invece sui singoli personaggi. Questo lavoro sembra, dunque, assumere le sembianze di un trailer cinematografico che mostra ambientazioni, personaggi, tendenze del lavoro artistico ma che non svela tutto. Scene ridotte in cui vengono focalizzati alcuni personaggi e la loro indole, attraverso veri e proprio frammenti di testo, rielaborati e spesso non estrapolati fedelmente dal romanzo. Reiterati effetti di buio e di luce frammentano maggiormente l’allestimento scenico, mostrando al pubblico immagini-flashback, come se fossero i ricordi di un uomo in coma che riavvolge, nella sua mente, il nastro della vita passata. La rivoluzione ed il turbinio sociale e culturale che pervadono la vita di questi personaggi, sono elementi che identificano un determinato periodo storico ed un determinato luogo geografico: la coppia di innamorati rappresenta, dunque, l’unione pericolosa tra due ideologie e due classi sociali in eterno contrasto. Il momento di sconvolgimento storico-sociale viene rappresentato in scena attraverso una trasposizione verso il contemporaneo, che accenna a quella decadenza storica, politica ed intima, che persiste all’interno del romanzo russo. In questo modo si ironizza sul nostro stesso Paese, ai giorni nostri, e soprattutto si identificano i momenti di sconvoglimento, pubblico e privato, attraverso movimenti “tarantati” che seguono, però, le musiche dei più famosi e commerciali balli di gruppo latino-americani. L’ironia che pervade l’intero spettacolo, in realtà crea un’atmosfera di inquietudine costante che fa ripiombare lo spettatore, frequentemente, nella riflessione, sconcertato dai continui cambi di scena, dalle immagini frammentarie, nel tentativo ricorrente di chiudere gli occhi in ogni passaggio al buio, per riaprirli come davanti ad uno schermo cinematografico o televisivo, o davanti ad un ricordo riaffiorato nelle nostre menti. Il tempo ormai andato ed il testo classico vengono violati e spezzettati, per rendere innovativa la messinscena di questo studio, di cui aspettiamo, però, gli esiti e le successive evoluzioni. L’ultimo spettacolo, analizzato all’intenro di questa V parte del diario del Festival, è inserito nel programma del NTFI 2015 ed è una produzione internazionale. Prima di concludere, dunque, il nostro percorso all’interno del Festival napoletano con una successiva VI parte finale dedicata a due spettacoli provenienti dalla Sicilia, parleremo anche di DINAMO, produzione TEATRO TIMBRE 4, ma in coproduzione con alcuni dei maggiori festival e teatri internazionali: oltre alla Fondazione Campania dei Festival, anche il Festival d’Avignon, la Maison Des Arts de Crétel Scéne Nationale, la Fundación Teatro a Mil ( Santiago Du Chili), il Teatro La Plaza (Lima), il Centro Cultural Sant Martìin ( Buenos Aires), e il Sesc So Paulo, con il sostegno del Ministero della Cultura di Buenos Aires e di Théatre National De Bordeaux En Aquitaine. La regia di Claudio Tolcachir ritorna sul palcoscenico napoletano, attraverso un testo realizzato dallo stesso regista, con Melisa Hermida e Lautaro Perotti. In scena Daniela Pal, Marta Lubos, Paula Ransenberg. La storia di Ada, settantenne ex cantante che vive in una roulotte, ferma in un luogo non identificato. La donna vive ricordando i tempi passati, indossando abiti anni ’80, ripensando ad un suo amore, probabilmente donna, che cantava con lei durante i tempi d’oro del successo. Come in ogni struttura dramamturgica, sin dai tempi più antichu, la routine della vita della donna viene destabilizzata dall’arrivo di un personaggio esterno, una lontana nipote, Marisa, vissuta per anni in un ospedale psichiatrico, dopo la morte dei genitori per un incidente stradale. Marisa, ormai donna, sembra essersi bloccata ad un’età adolescenziale o pre adolescenziale, quando, cioè, dopo una partita di tennis conclusasi negativamente, i genitori muoiono tragicamente. La donna si convince della sua colpevolezza, cioè della volontà suicida dei genitori in seguito al fallimento sportivo della figlia. Tutti i personaggi sono descritti in maniera grottesca, non solo per gli atteggiamenti ed il linguaggio, ma anche attraverso i colori sgargianti che ricordano i cartoni animati o gli abiti delle soap opera. Certamente il riferimento alla televisione è evidente, non solo nella gestualità, nell’ambientazione – basti pensare all’interno della roulotte la cui sagoma ricorda la finzione dei set degli studi televisivi – ma anche nell’intreccio, nel linguaggio e nei dialoghi. La nipote utilizza la lingua latino-americana, in parte anche l’anziana Ada, che per lo più si esprime con la musica e attraverso vocalizzi disperati, ed infine un terzo personaggio, inaspettato e sorprendente, cioè una donna clandestina che vive all’interno dei mobili della roulotte, utilizza una lingua inventata ma dalle sonorità slave e medio orientali. Insomma, una sorta di spirito della casa che raccatta, raccoglie, pulisce e che diventerà elemento cardine tra zia e nipote. La descrizione della vita delle tre donne è caratterizzata dalla profonda solitudine. I tre personaggi, macchiette ben caratterizzate che strappano numerosi sorrisi al pubblico, guardano costantemente al passato, costretti a convivere con il presente. Una sorta di regressione quotidiana, attraverso cui è impossibile vivere a fondo ogni giorno. I tre personaggi, dunque, sembrano ancora dolorosamente legati al passato, ed in effetti, in alcuni momenti, la vicenda decade nella commozione e nella malinconia, soprattutto quando Harima, il personaggio clandestino, raccoglie alcuni abitini da inviare al suo piccolo bambino, probabilmente un neonato, viste le dimensioni del vestiario ed il latte materno che fuoriesce dai seni della donna. Quest’ultima riesce a comunicare con la famiglia, rimasta nel Paese d’origine, attraverso il pc di Ada; simulando una videochiamata con Skype, la donna commuove il pubblico attraverso la sua conversazione con il piccolo, rimasto con i nonni. Oltre alla solitudine dei tre personaggi – quella di Ada per un po’ si affievolisce quando Harima esce per caso allo scoperto e la nipote ritorna a vivere in roulotte, considerando la clandestina un’immagine della sua mente malata o di qualche morto, come gli accadeva di solito - , è predominante un altro elemento. I tre personaggi fingono di vivere il tempo presente attraverso il travestimento, indossando l’abito di un ruolo che non è veritiero. La vecchia Ada pensa di essere ancora una cantante rock, la nipote pensa di essere ancora una tennista, Harima si straveste da fantasma, riuscendo a vivere per lungo tempo all’interno della roulotte, come se fosse invisibile. Solitudine ed invisibilità sembrano attenuarsi quando Harima diventa visibile e viene scoperta. La vita a tre sembra essere migliore, ma lo spettacolo gira attorno ad un cricolo vizioso poiché nulla cambia e nulla si trasforma. Le tre donne continueranno ad attendere che qualcosa cambi, e nessun uomo viene menzionato o compare all’interno dello spettacolo. Una storia che certamente non propone agli spettatori una trama innovativa, rivelando peraltro un pubblico diveso al momento degli applausi, tra chi non conosce Tolcachir e non sembra convinto fino in fondo, ed invece chi conosce il suo stile ed il suo lavoro, ed applaude con grande foga, soprattutto tra gli artisti e gli attori presenti in teatro, tra il pubblico. La tendenza all’ironia ed al grottesco porta in scena il racconto semplice che tanto amano oggi gli spettatori. Nessuna elucubrazione mentale, nessuna caratterizzazione filosofica, politica o culturale. Un racconto commerciale sulla falsariga degli intrecci televisivi. Perché il titolo DINAMO? Forse per indicare la forza di volontà che imprimiamo ogni giorno a noi stessi coinvincendoci di poter continuare a vivere, nonostante una forza opposta e contraria ci riporti costantemente indietro nel tempo.
L’ultimo spettacolo, analizzato all’intenro di questa V parte del diario del Festival, è inserito nel programma del NTFI 2015 ed è una produzione internazionale. Prima di concludere, dunque, il nostro percorso all’interno del Festival napoletano con una successiva VI parte finale dedicata a due spettacoli provenienti dalla Sicilia, parleremo anche di DINAMO, produzione TEATRO TIMBRE 4, ma in coproduzione con alcuni dei maggiori festival e teatri internazionali: oltre alla Fondazione Campania dei Festival, anche il Festival d’Avignon, la Maison Des Arts de Crétel Scéne Nationale, la Fundación Teatro a Mil ( Santiago Du Chili), il Teatro La Plaza (Lima), il Centro Cultural Sant Martìin ( Buenos Aires), e il Sesc So Paulo, con il sostegno del Ministero della Cultura di Buenos Aires e di Théatre National De Bordeaux En Aquitaine. La regia di Claudio Tolcachir ritorna sul palcoscenico napoletano, attraverso un testo realizzato dallo stesso regista, con Melisa Hermida e Lautaro Perotti. In scena Daniela Pal, Marta Lubos, Paula Ransenberg. La storia di Ada, settantenne ex cantante che vive in una roulotte, ferma in un luogo non identificato. La donna vive ricordando i tempi passati, indossando abiti anni ’80, ripensando ad un suo amore, probabilmente donna, che cantava con lei durante i tempi d’oro del successo. Come in ogni struttura dramamturgica, sin dai tempi più antichu, la routine della vita della donna viene destabilizzata dall’arrivo di un personaggio esterno, una lontana nipote, Marisa, vissuta per anni in un ospedale psichiatrico, dopo la morte dei genitori per un incidente stradale. Marisa, ormai donna, sembra essersi bloccata ad un’età adolescenziale o pre adolescenziale, quando, cioè, dopo una partita di tennis conclusasi negativamente, i genitori muoiono tragicamente. La donna si convince della sua colpevolezza, cioè della volontà suicida dei genitori in seguito al fallimento sportivo della figlia. Tutti i personaggi sono descritti in maniera grottesca, non solo per gli atteggiamenti ed il linguaggio, ma anche attraverso i colori sgargianti che ricordano i cartoni animati o gli abiti delle soap opera. Certamente il riferimento alla televisione è evidente, non solo nella gestualità, nell’ambientazione – basti pensare all’interno della roulotte la cui sagoma ricorda la finzione dei set degli studi televisivi – ma anche nell’intreccio, nel linguaggio e nei dialoghi. La nipote utilizza la lingua latino-americana, in parte anche l’anziana Ada, che per lo più si esprime con la musica e attraverso vocalizzi disperati, ed infine un terzo personaggio, inaspettato e sorprendente, cioè una donna clandestina che vive all’interno dei mobili della roulotte, utilizza una lingua inventata ma dalle sonorità slave e medio orientali. Insomma, una sorta di spirito della casa che raccatta, raccoglie, pulisce e che diventerà elemento cardine tra zia e nipote. La descrizione della vita delle tre donne è caratterizzata dalla profonda solitudine. I tre personaggi, macchiette ben caratterizzate che strappano numerosi sorrisi al pubblico, guardano costantemente al passato, costretti a convivere con il presente. Una sorta di regressione quotidiana, attraverso cui è impossibile vivere a fondo ogni giorno. I tre personaggi, dunque, sembrano ancora dolorosamente legati al passato, ed in effetti, in alcuni momenti, la vicenda decade nella commozione e nella malinconia, soprattutto quando Harima, il personaggio clandestino, raccoglie alcuni abitini da inviare al suo piccolo bambino, probabilmente un neonato, viste le dimensioni del vestiario ed il latte materno che fuoriesce dai seni della donna. Quest’ultima riesce a comunicare con la famiglia, rimasta nel Paese d’origine, attraverso il pc di Ada; simulando una videochiamata con Skype, la donna commuove il pubblico attraverso la sua conversazione con il piccolo, rimasto con i nonni. Oltre alla solitudine dei tre personaggi – quella di Ada per un po’ si affievolisce quando Harima esce per caso allo scoperto e la nipote ritorna a vivere in roulotte, considerando la clandestina un’immagine della sua mente malata o di qualche morto, come gli accadeva di solito - , è predominante un altro elemento. I tre personaggi fingono di vivere il tempo presente attraverso il travestimento, indossando l’abito di un ruolo che non è veritiero. La vecchia Ada pensa di essere ancora una cantante rock, la nipote pensa di essere ancora una tennista, Harima si straveste da fantasma, riuscendo a vivere per lungo tempo all’interno della roulotte, come se fosse invisibile. Solitudine ed invisibilità sembrano attenuarsi quando Harima diventa visibile e viene scoperta. La vita a tre sembra essere migliore, ma lo spettacolo gira attorno ad un cricolo vizioso poiché nulla cambia e nulla si trasforma. Le tre donne continueranno ad attendere che qualcosa cambi, e nessun uomo viene menzionato o compare all’interno dello spettacolo. Una storia che certamente non propone agli spettatori una trama innovativa, rivelando peraltro un pubblico diveso al momento degli applausi, tra chi non conosce Tolcachir e non sembra convinto fino in fondo, ed invece chi conosce il suo stile ed il suo lavoro, ed applaude con grande foga, soprattutto tra gli artisti e gli attori presenti in teatro, tra il pubblico. La tendenza all’ironia ed al grottesco porta in scena il racconto semplice che tanto amano oggi gli spettatori. Nessuna elucubrazione mentale, nessuna caratterizzazione filosofica, politica o culturale. Un racconto commerciale sulla falsariga degli intrecci televisivi. Perché il titolo DINAMO? Forse per indicare la forza di volontà che imprimiamo ogni giorno a noi stessi coinvincendoci di poter continuare a vivere, nonostante una forza opposta e contraria ci riporti costantemente indietro nel tempo.