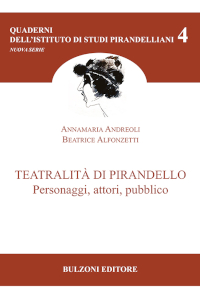Nel contesto del teatro contemporaneo europeo Thomas Bernhard è credo uno dei primi, magari solo il più consapevole, drammaturgo che agisce un ribaltamento del canone aristotelico del teatro, in base al quale il teatro stesso è “imitazione della realtà” e quindi, in sostanza una finzione della vita.
In un mondo, quale quello moderno e poi contemporaneo della civiltà borghese, in cui la vita è di per sé stessa “finzione” e bugia, impastata di maschere e stereotipi, il teatro può diventare al contrario con Thomas Bernhard funzione di verità e sincerità che smaschera la vita, non la imita, e per questo non può che essere di per sé “provocatorio”.
Il Teatro Stabile di Genova inizia la sua stagione proprio con questa drammaturgia dello scrittore austriaco, scritta nel 1976, nella traduzione
di Umberto Gandini e per la regia di Marco Sciaccaluga, in cartellone al teatro Duse dal 13 ottobre al 1° novembre.
Narrazione intensa sull’attore, il testo di Bernhard, compatto e spigoloso come nelle sue corde, ne indaga il tramonto e attraverso di questo il senso del suo recitare e del recitare in quanto tale, restando pervicacemente lontano da ogni tentazione biografica, priva di interesse per il drammaturgo, e utilizzando la sua vita sulla scena proprio per smascherane la perfetta finzione esistenziale.
Ne fa, come ha sottolineato gran parte della critica italiana sin dalla prima rappresentazione del 1984 sempre nella traduzione di Gandini, una sorta di denunzia della humanitas, esempio cioè del difficile esistere quale tutti ci accomuna, esistere che proprio nel confronto/contrasto con la perfezione della scena si manifesta in tutti i suoi limiti. In effetti, scrisse a suo tempo il critico Maurizio Grande, “La morte è vista da Bernhard come una vittoria della precisione su quella imperfezione che è la vita”.
La regia di Sciaccaluga d’altra parte, molto concentrata sulla figura del protagonista in cui si confondono l’attore presente e il suo personaggio, ne accentua così le suggestioni esistenziali e psicologiche che enfatizzano una coloritura patetica talora in frizione con la secchezza significativa e essenziale del testo.
È forse il risultato di una sovrapposizione, già notata nella ricezione critica della drammaturgia, della funzione dell’attore con il ruolo molto italiano del “mattatore” che tende a sovrapporre e mitigare, imponendogli una sorta di sordina, la intrinseca contraddizione tra verità e menzogna, ribaltate reciprocamente, proprie dello scrittore austriaco.
Contribuisce in certo senso anche la traduzione che, come scrisse Benjamin citando la legge della tangente, “tocca l’originale di sfuggita e solo nel punto infinitamente piccolo del senso, per continuare, secondo la legge della fedeltà, nella libertà del movimento linguistico, la sua propria vita”.
Un testo dunque vissuto più come prova di grande recitazione, anche dal comunque bravo Eros Pagni, che come spaccato della perdita di senso di un mestiere attorno a cui provocatoriamente interrogarsi sul senso, ove ci sia ancora, dello stesso fare teatro.
Attorno a lui si agitano, comparendo e scomparendo, figure alla ricerca di una identità spesso pescata a piene mani, appunto, da maschere e stereotipi del passato e del presente. Sono i giovani Federica Granata, Marco Avogadro, Nicolò Giacalone, Giovanni Annaloro, Mario Cangiano, Marco De Gaudio, Roxana Doran, Daniela Duchi, Michele Maccaroni, Daniele Madeddu, Sarah Paone, Francesco Russo e Emanuele Vito.
Le scene e i costumi sono di Catherine Rankl, le musiche di Andrea Nicolini e le luci di Sandro Sussi. Una produzione del Teatro Stabile di Genova apprezzata alla prima che recupera un autore difficile ma essenziale nel panorama del teatro europeo. Per chi avesse poi interesse alla figura di Thomas Minetti come attore segnaliamo il film “La donna mancina” da un testo e con la regia di Peter Handke ove interpreta il ruolo del padre della protagonista.