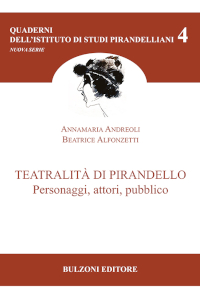Ha esordito il 15 dicembre al teatro della Corte di Genova, tra le compagnie ospiti dello Stabile, e resterà in cartellone fino al 20 questa interessante e, per certi versi inquietante, drammaturgia del francese Eric-Emmanuel Schmitt, scritta agli inizi degli anni 90 del novecento. È a mio avviso una ulteriore dimostrazione della curiosità e della capacità di Valerio Binasco, che ne è traduttore, adattatore e regista (quindi dramaturg in senso pieno), di accostarsi e indagare testi di spessore intellettuale e capaci di sprigionare in scena potenzialità significanti talora inespressi. Berggasse 19, Sigmund Freud nella Vienna del 1938 ormai assorbita dal nazismo, sulla soglia dell’esilio e, di lì a poco, della morte, fa, insieme alla figlia Anna, gli ultimi conti con la Gestapo e insieme a questi, quasi inevitabilmente, con la sua vita al tramonto. Ad aiutarlo, o forse a scompigliargli le carte,
una visita inattesa reale o solo sognata che sia, quella di Dio. O forse è solo l’intrusione di un matto che si crede Dio, ma poco cambia perché quella visita diventa una sorta di discrimine, un cartina al tornasole delle difficoltà dell’uomo Freud e dunque dell’uomo in generale, quando si sporge sull’orlo scivoloso del mistero.
È lo stesso ospite che rivendica con forza e originalità questo suo ruolo nei confronti dell’umanità che ha creato (e che dunque lo ha creato), quello di costringerla a mettersi di fronte, come in uno specchio, le sue avvilenti mancanze, i suoi peccati, e anche la sua forza, la sua possibile redenzione.
Dice infatti ad un perplesso Freud, tentato di credere e insieme incapace di farlo, “ti ho fatto capire che la vita non è oscurità ma mistero”. Ed il mistero è la via per una possibile comprensione, è la via essenziale per una ricerca del senso del nostro esserci.
Scritta con sintassi volutamente brillante, da commedia, la drammaturgia inevitabilmente declina nella riflessione filosofica e anche religiosa, ruotando sul paradosso che l’aver eliminato Dio dal suo orizzonte non sembra una vittoria dell’uomo ma una sua sconfitta. Se l’uomo resta solo come il bambino Sigmund, in fondo anche l’incubo finale del nazismo diventa possibile.
Un testo dunque che è una acuta riflessione attraverso il dialogo, attraverso la parola che costruisce i personaggi prima di essere pronunciata da loro. Una riflessione coinvolgente, quasi una “trappola” nelle sue improvvise digressioni anche comiche, che riesce a condurci fino alle soglie dell’inaspettato.
In scena Alessandro Haber e Alessio Boni, rispettivamente Freud e l’ospite, danno presenza e concretezza a questa riflessione, traslando nella mimica e nella gestione naturalistica del corpo l’incertezza e la perplessità che permea il dialogo, con una sovrapposizione tra attore e personaggio mai oltre le righe e che lascia la giusta distanza recitativa. Assieme a loro Nicoletta Robello Bracciforti, una Anna Freud molto vitalistica, e Alessandro Tedeschi, il nazista dalle tonalità felicemente caricaturali.
Le belle scene sono di Carlo De Marino, i costumi efficaci di Sandra Cardini e le intense musiche di Arturo Annecchino. Coerente la scenografia luci di Umile Vainieri. Una produzione Goldenart.
Il grande teatro era praticamente pieno e il pubblico ha applaudito con convinzione.