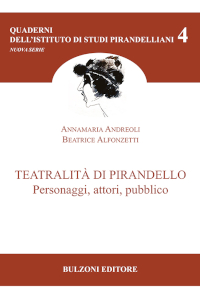Il Secolo detto “breve”, il tragico secolo che ci ha preceduto, quel novecento del doppio “massacro” mondiale, il secolo dei fascismi e dei totalitarismi, il secolo della shoah, ma anche il secolo che sembrava avviato, al suo tramonto, verso il trionfo della libertà. A questo secolo, e anche alla delusione della nostra contemporaneità, ci riporta la narrazione del noto romanzo di Arthur Koestler, che ne era stato se non protagonista di prima fila un comprimario di rilievo, e a questo secolo volge il suo sguardo questa omonima e bella drammaturgia di Laura Sicignano, che cura anche la regia, in scena al “Cantiere Campana” del Teatro della Tosse di Genova dall’8 al 20 marzo. Una drammaturgia che, grazie anche alla prospettiva del tempo che attenua le spine più accese di un confronto ideologico che sembra, appunto, di un altro secolo, riesce a concentrare il suo sguardo su una
sorta di male interiore dell’uomo e della Società, che corre quasi nelle sue vene e nello spirito di ogni tempo, e rispetto al quale gli eventi della Storia appaiono come manifestazioni metaforiche oltre ogni steccato e nonostante ogni deformazione ideologica, steccati e deformazioni che pure persistono come un rumore di fondo.
Certamente non si possono qui non richiamare le suggestioni delle riflessioni di Hannah Arendt, forse le più lucide sugli eventi di quei tempi e per questo ormai imprescindibili in ogni orizzonte storico, sociale e anche esistenziale e riassunte nell’ormai universale concetto della “banalità del male”, riflessioni certo successive ma già percepibili, oltre le asperità in parte propagandistiche, nel testo e di cui la riscrittura scenica della Sicignano a mio avviso si sforza, riuscendovi, di dare più palese ragione.
Il rivoluzionario della prima ora (forse ispirato a Bucharin di cui riecheggia e ripropone anche nei tempi la vicenda) che diventato dirigente è vittima di quella stessa de-umanizzazione di cui, in nome della difesa del partito e dei suoi ideali, lui stesso si era fatto promotore.
Incarcerato, torturato psicologicamente e fisicamente, vittima di testimonianze false estorte con la violenza, alla fine quell’uomo di partito sembra accettare e quasi assecondare su di sé il giudizio che il partito gli propone/impone, privo ormai di una alternativa intima od esteriore e ormai al centro di una desolata terra in cui ogni umanesimo sembra bandito.
Una sorta di auto-condanna di fronte all’alternativa di passare effettivamente dalla parte dei nemici della causa, fatta propria tanto da rendere colpevole il solo desiderio di opporsi. Lo stesso Koestler, in una sorta di interferenza esistenziale con la sua narrazione, tentò il suicidio di fronte all’ostracismo che gli fu opposto da tanta intellighenzia di sinistra e comunista di allora.
La messa in scena dunque, assecondata dalle “intelligenti” scenografie di Emanuele Conte che crea una sorta di continuum spazio temporale del carcere traslato a condizione umana, scava il testo per rintracciarne quasi barlumi (della memoria e della speranza) di quella umanità denegata così da poter riaccendere nella conoscenza e consapevolezza che ora può appartenerci un orizzonte e una via di uscita.
La forza del testo e della sua resa scenica sta appunto nell’essere agganciata alla storia, oltre le trasfigurazioni allegoriche ad esempio di un ben più cupo “1984”, ed insieme di enfatizzare la presenza e l’essenza di una umanità abbattuta forse ma non ancora interamente sconfitta, allora ma anche oggi.
Un discorso dunque sul potere (ricordiamo qui anche la trilogia sul “potere” di Emanuele Conte) e sulle sue trasfigurazioni nel fluire della storia, contingenti e diverse ma con una maschera in fondo sempre riconoscibile, se la si vuole riconoscere, nella sue svariate forme politiche, sociali, e di genere, imposte o introiettate che siano. Un discorso su un potere che anche qui prende prepotentemente corpo nel maschile come segno in fondo ripetuto e ribadito di “sopraffazione”.
Una scrittura scenica giocata sulla “banalità” e in una tonalità sotto-traccia che recide ogni tentazione melo-drammatica per restare lucida testimone attraverso i suoi testimoni in scena.
In scena un intenso e anche misurato, nella profonda sofferenza che incarna, Aldo Ottobrino con gli altrettanto bravi Pietro Fabbri, Gianmaria Martini, Massimiliano Caretta e Matteo Sintucci, vittime, testimoni e torturatori. Le musiche originali sono di Edmondo Romano.
Una produzione Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse in collaborazione con il Teatro Cargo di Genova. Molto e giustamente applaudita alla prima nazionale e alla presenza di un pubblico in larga parte giovane.
foto donato aquaro