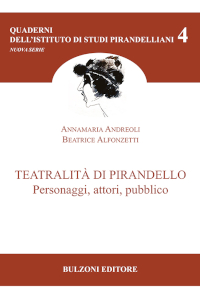Giornata intensa ed interessante quella di sabato 16 aprile al Festival “Testimonianze ricerca azioni” organizzato da Teatro Akropolis negli spazi di Genova Sestri Ponente, giornata intensa nel segno di due spettacoli dal respiro internazionale che sembrano, come comune denominatore, voler rileggere nell’alfabeto del corpo danzante ferite aperte nel corpo e nel cuore della contemporaneità, quasi a sciogliere nella coreografia drammaturgica quei grumi di sofferenza che in Europa e nel mondo sono sotto i nostri occhi mentre i nostri occhi spesso guardano altrove. Nel pomeriggio lo svizzero Imre Thormann, danzatore butho tra i più noti al mondo, ha presentato il suo “Enduring Freedom”
all’interno di Villa Rossi Martini. Un limitato numero di spettatori si raccoglie in cerchio attorno ad un luminoso rettangolo di neon e attende l’ingresso del danzatore che entrato in abiti borghesi si spoglia lentamente di ogni sua identità fittizia e mascherante per offrire attraverso la nudità del suo corpo la percezione immediata della essenzialità dell’esistere. I movimenti rituali della danza butho si fanno così parti e segnali di un emergere dalle profondità dell’essere di una identità nuova e autentica che vive la sua singolarità nell’essere paradossalmente segno di una comunanza, di una collettività. Una collettività e una comunanza che vivono e scorrono al di sotto di quelle stesse maschere che abbiamo paura di toglierci. Thormann avrebbe tratto ispirazione dalla visione, nella metropolitana di Tokio, di una donna anziana caricata sulle sue spalle del peso di una figlia evidentemente sofferente e minorata che sale sulla vettura mentre intorno a lei tutti si scostano. È lo stesso desiderio di aiuto di cui si fa carico il suo corpo contratto e sofferente nella danza e che la danza trasforma in attesa di una vita che può nascere anche dal dolore e dalle doglie della morte vicina.
A sera al teatro Akropolis è stato invece il turno di Qudus Onikeku, danzatore nigeriano formatosi presso il Centre National des Art du Cirque di Parigi, che ha presentato una coreografia drammaturgica che si evolve, per così dire, da un suo assolo già premiato al “Danse L’Afrique Danse” nel 2010. Una performance spettacolare che unisce alla indubbia tecnica una forza interiore non comune, una forza che sembra guidare i movimenti anche oltre la volontà consapevole, anche oltre la costruzione e l’occupazione di uno spazio condiviso. Il tema è l’esilio come metafora della più generale condizione umana e quindi quello attualissimo della migrazione che attiva e provoca, infine, una progressiva dispersione di identità cui solo il corpo sembra offrire limite e costituire una difesa efficace. È il corpo che dunque custodisce la nostra casa, mentale, psicologica ma anche, sembra dirci il danzatore, potentemente fisica, e solo la morte può dunque esiliarci da essa. Una coreografia contaminata da suggestioni diverse che pescano nella tradizione della danza colta e negli stimoli della danza popolare. Come detto l’assolo si evolve alla fine nella parola, una parola che quasi sgorga dalla danza e che accompagna l’ingresso in scena di una attrice, Ese Brume, ad articolare il monologo fisico in un malinconico dialogo lirico su testo di Zena Edwards. È una modalità questa fatta ormai propria da molti danzatori europei, quasi ad esprimere un disagio di comunicazione ed un desiderio di oltrepassare i limiti del magico cerchio della danza in direzione dello spettatore, ma è anche una modalità che talora attenua e contraddice la percezione e anche la soddisfazione fisica che la danza spesso riesce a produrre e a comunicare.
Due occasioni comunque che il festival ha offerto per guardare oltre i nostri confini, confini non tanto geografici quanto mentali.
Foto Giusi Lorelli