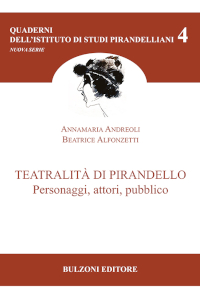Friedrich Durrenmatt “gioca” con Strindberg e ne rilegge (e riscrive) Danza di Morte travestendola dentro ad un ring di pugilato (recitare, giocare, esercitare uno sport ovvero suonare tutte azioni, dunque, che in inglese possono essere declinate con l’espressione “play”) e quindi rendendo esplicito nel transito scenico il senso intrinseco della narrazione strindberghiana e della stessa sua rappresentazione. Atto di accusa feroce contro il matrimonio, come summa e sintesi di ogni istituzione (borghese) che opprime l’autenticità dell’essere e dell’esistere, non sembra mostrare vie d’uscita se non quella della reciproca distruzione. Immagine dunque e visione di sé stesso che lo stesso Strindberg riassume con queste aspre parole: “Dopo aver vissuto quattro anni con i miei figli e mia moglie in un esilio quasi volontario, rintanato in un villaggio della Baviera, stremato, condotto davanti
ai tribunali, imprigionato esiliato, messo alla gogna, un solo sentimento mi ossessionava nei giorni in cui caddi ammalato a letto: la vendetta”.
Qui il testo è in un certo qual modo sezionato al fine di renderlo compatibile con il nuovo suo contenitore narrativo e questo accentua un processo di alienazione che è un distacco dal proprio sé sofferente e medicato di ipocrisia.
Il ring contiene materialmente la sofferenza dei tre personaggi, nel senso non solo di custodirla ma anche in quello ben più ampio di poterle dare “contenimento” psichico, mentre la divisione in quadri (dodici round pugilistici) oltre a dare sollievo alla inesauribile lotta dei sessi, è come se rendesse esplicito che ciascuno, lì, recita la sua parte “istituzionale” su una scena in cui l’odio è presente nell’aria che si respira (è la modalità stessa della vita e della società), ma può non esserlo nel cuore che ci batte in petto.
Così anche attraverso il setaccio dell’ironia Durrenmatt sembra riuscire, proprio nella sua particolare revisione, a rintracciare barlumi di sollievo come se, al pari della scena, anche nella vita potesse esistere qualcosa fuori da quel ring.
D’altra parte che August Strindberg fosse mentalmente sofferente è noto, ma proprio attraverso la messa in scena delle sue drammaturgie, così segnate da una sorta di pervicace volontà di autoanalisi, può realizzarsi il distacco della percezione di sé e quindi l’approdo alla conoscenza che (forse) riscatta.
La pièce utilizza la traduzione di Luciano Codignola, assai moderna nel suo articolarsi dialogico, ed è ben diretta da Franco Però. I protagonisti, Maria Paiato, Franco Castellano e Maurizio Donadoni danno corpo e voce con coerenza ai sofferti personaggi, attenuandone le originarie caratterizzazioni fantasmatiche in variazioni, a mio avviso, assai più vitali.
Ottima la scena di Antonio Fiorentino e efficaci i costumi di Andrea Viotti. Musiche di Antonio di Poli e luci di Luca Bronzo.
Una produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia/Artisti Riuniti, tra le compagnie ospiti dello stabile di Genova dal 25 al 30 aprile al teatro Della Corte.