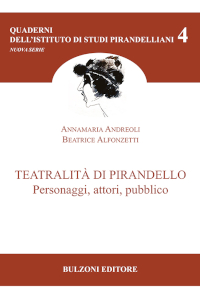Della forza metaforica del calcio, e dei suoi sottili legami con la letteratura ed il teatro e talora soprattutto con i poeti, si discute e si è discusso molto, da Paolini a Eduardo Galeano, anche quando a prevalere è stato il rifiuto o una altrettanto snobistica incondizionata accettazione. Qui in realtà l’irlandese Robert Farquhar di tutto questo non sembra darsi gran che peso, ed utilizza l’argomento calcistico in forma per così dire “traversa”, intendendo il calcio, ricco comunque di elementi metaforici come gran parte dei giochi che ripropongono in forma mediata strutture e relazioni di ogni singola comunità, come una occasione tra le altre per attivare una peripezia interiore che con il calcio ha poco a che fare. Ha a che fare invece, a mio avviso, con i fallimenti di una società precaria e distruttiva che trascina in basso sempre di più i deboli, quelli che non ce la fanno e spesso proprio nel pallone trovano
un paravento per nascondere ed esorcizzare anche con la violenza la propria personale sconfitta.
Così più che metafora il calcio, e con quello la cosiddetta “squadra del cuore”, diventano una sorta di strumento di falsa coscienza, una macchina di identificazione tale e così forte da far quasi sovrapporre nella percezione del protagonista la retrocessione con l’abbandono della donna amata.
Per riscattare l’una e riavere l’altra, dunque, Degsy, uomo dalla fragilità violenta e quasi infantile, rapisce l’arbitro che ha negato il gol salvezza e coinvolge l’amico Cliff in una grottesca peripezia giocata più sul piano dell’irrealtà e del sogno, che su quello della sociologia, fino all’inevitabile e altrettanto grottesco finale.
In più il drammaturgo, proprio attraverso la figura dell’arbitro compie una ulteriore ironica sovrapposizione, quella della fede calcistica con quella religiosa, fedi entrambe destinate in questa nostra liquida società ad affacciarsi sul vuoto della nostra coscienza.
Nella versione italiana di Carlo Sciaccaluga, ricca di rimandi a realtà vicine al pubblico, Alberto Giusta ha curata una regia fatta di sottrazioni e giochi di luce che asseconda la mobilità, talora ossessionante, di un testo giocato molto sulle ripetizioni. I tre protagonisti, Andrea di Casa, Massimo Rigo e Marco Zanutto tengono efficacemente la scena.
Primo appuntamento della nuova edizione della “Rassegna di Drammaturgia Contemporanea” del Teatro Stabile di Genova, ormai da più di vent’anni quasi un Festival di fine primavera. Un esordio convincente che ha infatti convinto il pubblico numeroso che ha a lungo applaudito.