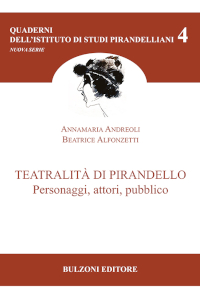La scrittura di Ibsen, credo sia universalmente conosciuto, è una specie di sonda quasi eterodiretta ovvero involontaria che percorre una strada tutta sua all'interno dall'anima dell'umanità, anzi è una sorta di scandaglio che talora intercetta, oltre ogni barriera difensiva soggettiva o collettiva, il fondo limaccioso di quella stessa anima e delle mille e singolari vite che da essa si distaccano per farvi inevitabile ritorno. Scrisse infatti lo stesso Ibsen: “Farò posare i miei contemporanei, uno per uno, davanti al mio obiettivo. Ogni volta che mi batterò in un'anima degna di essere riprodotta, non risparmierò né un pensiero, né una fuggevole intenzione, appena mascherata dalla parola.” Non fa eccezione questo John Gabriel Borgman, uomo singolare e drammaturgia tra le più conosciute e
'usate' del norvegese, il quale getta il suo scandaglio in una narrazione se vogliamo ordinaria, la storia di un banchiere bancarottiere e delle sue due donne sorelle gemelle e tra loro avverse, e incontra i lati oscuri di una esistenza che non si dà pace perché non si dà alcuna ragione di quello che le è successo.
È una narrazione conosciuta su cui non devo soffermarmi, incisa da una scelta iniziale che la coinvolge fino al suo tramonto, una scelta tra affettività e denaro/potere che non matura e che, non elaborata, conduce al fallimento sociale e a quello esistenziale.
Nel semplice strutturarsi e dipanarsi del racconto drammaturgico, solidamente ancorato in un processo di conoscenza che si assimila all'autoanalisi, dunque si intersecano il piano sociologico e politico, il piano etico del rigido luteranesimo nordico, e infine quello esistenziale di vite trascinate tra desiderio e delusione.
Il segno estetico di questo transito narrativo appare dunque l'inadeguatezza, quella soggettiva di John Gabriel incapace di reggere e articolare le sue confuse ambizioni prometeiche, e l'inadeguatezza di una umanità e di una società in transito, tra pulsioni pre-capitaliste e totale sottomissione al denaro e alla strutturazione sociale che ne consegue. Da qui la sua paradossale e persistente modernità.
La regia di Marco Sciaccaluga sceglie di enfatizzare il lato oscuro del racconto optando per atmosfere claustrofobiche dominate da porte quasi perennemente chiuse (emblema di ciò che i “salotti borghesi” nascondevano), atmosfere che le scenografie ispirate a Edvard Munch, che a suo tempo disegnò vari bozzetti per le opere del suo connazionale, sottolineano accompagnando protagonisti e spettatori in una sorta di caduta verso il profondo, o meglio verso il basso, verso la palude che sta tra la follia e il riscatto improbabile.
In tutto questo anche la fuga del figlio Erhart con la colorata Fanny Wilton, e con la giovane Frida Foldal sembra poter rappresentare quasi solo l'ultimo abbaglio di un inevitabile gelido tramonto invernale.
Una buona edizione questa, forse con qualche occasionale slittamento nell'enfatico, in cui Gabriele Lavia è un Borkman convincente e ben affiancato da Laura Marinoni e Federica Di Martino, le due gemelle Rentheim. Insieme a loro in scena Francesco Sferrazza Papa, Giorgia Salari, Roberto Alinghieri e Roxana Doran.
La regia, come detto dal taglio consapevolmente 'classico', è di Marco Sciaccaluga, le scene coerenti e i costumi di Guido Fiorato, le musiche di Andrea Nicolini e infine le luci di Marco D'Andrea.
Una produzione comune dei tre Teatri Nazionali di Genova, di Napoli e della Toscana, in scena al teatro della Corte di Genova dal 6 al 17 novembre, molto ben accolto dal pubblico numeroso.
Foto Pitto