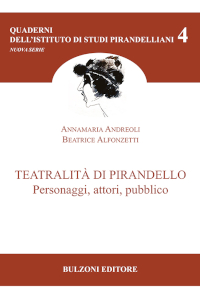Ho conosciuto la Piccola Compagnia della Magnolia qualche anno fa, a Torino, in una piccola stanza ove Giorgia Cerruti aveva ambientato il suo “Zelda – Vita e morte di Zelda Fritzgerald”. Da allora l'ensemble, che aveva già una sua maturità, è cresciuto ulteriormente e ha sviluppato una estetica teatrale complessa ed insieme illuminante, che raccoglie ed elabora i diversi contributi di studio e approfondimento che il gruppo ha accolto ovvero promosso nel corso della sua vita artistica. Giorgia e con lei Davide Giglio sono l'ossatura di questa esperienza, molto particolare e anche unica, e con loro nasce questa conversazione sui temi del passato, del presente e anche del futuro che sembra attenderci. Come tante realtà analoghe, “Magnolia” sta vivendo un passaggio difficile. Possiamo permetterci, come cultura, arte e teatro italiano, di perdere una realtà così ricca e soprattutto così 'utile', alla mente, all'anima e anche alla comunità? La domanda è retorica, la risposta una sola.
MDP: la Piccola Compagnia della Magnolia ha ormai superato i 15 anni di vita. In proposito la vostra storia artistica e l'esperienza sviluppata con la Compagnia mi sembrano indicare una visione del teatro basata non solo sulla scrittura ma soprattutto sull'attore, anzi sull'indagine e sulla liberazione della scrittura attraverso l'attore. Ricordando Antonin Artuad, Jerzy Grotowski, e anche la Mnouchkine, la ritenete una percezione corretta?
GC: I maestri che hai indicato sono effettivamente e assolutamente il filtro attraverso il quale noi indaghiamo sul palco la materia parola. Infatti, lungi dal considerare la parola come mero significato, sempre, nel lavoro che facciamo, tentiamo di prenderne l'elemento granitico, l'elemento solido, e di capire come questo impatta sul corpo dell'attore, sulle sue cellule. Tra gli altri Eugenio Barba, in proposito, parlava di impulsi che si appoggiano sul corpo. Così anche i testi rimandano impulsi che definisco 'scientifici' su quei corpi in scena. Quindi direi che hai centrato in pieno il nostro interesse, che non è solo quello di vivere vite altrui, incontrando tante persone che vivono nei testi che affrontiamo, quanto soprattutto quello di fare un viaggio che di nuovo chiamerei scientifico. Infatti io do tanto valore a questa definizione, e così come essa mi spaventa nel suo ambito, in ambito artistico mi sembra dia quella giusta chimica di viaggio, di competenza, di esplorazione. Nel nostro caso, dunque, la materia corpo e la materia suono sono l'involucro, lo strumento per far breccia, per fare uscire dall'anima, appunto verso l'involucro, qualcosa. Penso infatti sempre a noi attori come dei vasi risonanti, più che come delle figure di per sé dotate di qualcosa da donare in scena. Siamo vasi risonanti e qualcosa ci attraversa, o non ci attraversa, e calcando la scena cerchiamo di tradurla.
DG: Infatti la Mnouchkine definisce i suoi attori come medium. Siamo medium, quindi incanaliamo attraverso di noi sia l'arrivo della persona che interpretiamo, sia la sua capacità di parlare attraverso la matematica del cuore, come dice Brook,
GC: Ci sono pertanto una serie di grandissimi sulle cui orme tutti navighiamo. Alcuni di questi poggiano il lavoro dell'attore su competenze di origine orientale, di biomeccanica che a noi parlano molto. Artuad per primo, e Grotowski. Competenze per le quali la forma è etica, la forma è sostanza e la superficie dei corpi non è superficiale.
MDP: non è certo tempo di bilanci, ma la vostra ricerca è, a mio avviso, un continuo e dinamico farsi estetico che incontra, più che utilizzare, le singole drammaturgie e le trasfigura in occasioni di presenza in scena quasi a prescindere dai contenuti, come elementi della ineludibile relazione con il pubblico. Il tuo e il vostro è dunque un percorso estetico che si legittima mentre accade?
GC: completamente. Tieni conto che quando iniziamo un lavoro non partiamo mai con il dire scegliamo un testo e vediamo cosa succede. Partiamo invece da un tema, una sensazione, un inciampo. Da un coacervo, come dire, di problematiche anche umane, quelle che magari stiamo vivendo in quello stesso momento. Anche qualcosa che scatena dolori, qualcosa che qualcuno di noi sta vivendo, e ci piace capire come i grandi hanno tradotto tutto questo in un testo mentre tentiamo di intercettare in essi quel nostro attimo. Ad esempio, se nel dolore di Agamennone per la propria figlia Ifigenia ci sia qualcosa che esprima e porti su di sé un taglio delle radici vissuto da un nostro compagno. I testi è come se fossero delle sezioni di avvicinamento tra i vivi e i morti, dei rounds. Andiamo così a capire quali di questi autori abbiano attraversato quella specifica sensazione o sentimento. Nasce dunque, in quel momento, l'occasione per fare un viaggio. Al riguardo, però, ti voglio dire che noi non lavoriamo mai a tavolino. Sin dalla prima prova siamo sul palco ad agire qualcosa, innanzitutto come corpi in scena. Paradossalmente una compagnia come la nostra quasi maniacale nel lavoro sul fraseggio e sulla metrica, la prima cosa che agisce sono i corpi. Siamo sempre in movimento, in allenamento.
MDP: come del resto diceva Sanguineti, che definiva la parola come corpo: la parola è corpo.
GC: certo, la parola è corpo, è materia e come tale va trattata. La parola è materia che risuona.
DG: in proposito, mi capita, nel mentre che preparo uno spettacolo, in quella fase iniziale in cui ancora non utilizziamo il testo ma lavoriamo sul corpo, mi capita, dicevo, che quando poi vado incontro al testo allora, quelle parole che incontro, mi fanno addirittura paura, come fossero tracce che riconosco, come lasciassero piccole cicatrici sul corpo, che tu riconosci. Allora diventa diffcile e faticoso reinventare quelle parole.
GC: aggiungo che il vero terrore di ogni attore è quello di sentirsi in scena, di non riuscire a dimenticarsi di sé in qualcun'altro. Riuscirci è una benedizione, dimenticarsi cioè di una parte di sé in qualcun'altro, che si chiami Giulietta oppure Edda. Spesso c'è una ingerenza del proprio sé che impedisce di fare viaggi astrali. Ma quando questo non accade allora quello dell'attore, il suo viaggio attraverso la scena, è veramente il più bel lavoro del mondo. Quando poi incontriamo gli spettatori è come agire in un tempo sospeso, in un tempo non quotidiano, ma rimango convinta che il momento primario del nostro lavoro siano comunque le prove. Nelle prove il gruppo testa la propria resistenza all'atto scenico, a quello che lo spettacolo comporterà. Per questo non possono farsi, per noi, prove con i tempi produttivi di uno Stabile, è impossibile, è impossibile perché smarriamo il piacere, quel piacere per cui quindici anni fa volevamo far teatro. Per capirci meglio, per capire meglio le persone, per capire meglio ciò che è umano, il perché siamo qua, il perché a volte siamo degli orsacchiotti spelacchiati e impauriti, e a volte invece ci sentiamo degli Agamennone. Per tutto questo ci vuole tempo, coesione e lealtà. Quando poi si va a passare quell'ora, ora e un quarto, con il pubblico, essa è un'ora accidentata in ogni suo secondo e deve esserci forte la volontà di sincerità. Ogni due minuti può esserci un momento in cui l'io scolla, stacca e poi rientra. È una lotta costante quella per tentare in quel tempo specifico di costruire una comunicazione con il pubblico, che però non deve essere attraverso canali psicologici, bensì per canali prettamente sensoriali. Poi questi sensi scendono giù, vanno alla radice di noi, al suo significato, oppure non ci arrivano in quella sera. Tutto è passibile di errore in quell'ora e dieci minuti.
DG: aggiungo però che con il tempo, ad esempio quando mi penso, quando penso me Davide nel Balcone di Genet, il nostro primo spettacolo, o in Mater Dei in cui praticamente non parlo, non faccio nulla, è vero che c'è il rischio di scollare, ma trovo sempre il codice per ritornare, per essere presente, trovo le chiavi per rientrare a casa.
GC: c'è dunque, per noi, un rapporto con il pubblico particolare. Noi siamo grandi frequentatori di teatro, come spettatori. Ci piace molto andare, è la nostra serata ideale, e non è una cosa scontata, ma talora abbiamo il rammarico di assistere a spettacoli che non vogliono stabilire con noi un rapporto ambizioso. Un rapporto ambizioso cioè oltre l'atteso, fuori dal consueto e fuori anche dal consono ai tempi, al pop ora imperante. Allora mi tocca andare a vedere, ad esempio, maestri come Romeo Castellucci, pur lontanissimo dalla mia visione estetica. Da spettatrice, però, ringrazio i suoi azzardi, così alteri, così ambiziosi, e anche eretici rispetto alla smania di consenso che va uccidendoci. Credo dunque sia importante tentare di stabilire con gli spettatori un rapporto di sospensione del tempo, in quanto, fuori, tutto viene triturato in una conoscenza così eccessiva che è quasi pornografica. Invece lasciare qualcosa di più ruvido, di più ancestrale, è il dovere, io credo, del teatro. Più andiamo avanti in questi tempi di media pervasivi, e la pandemia ancora più ce lo insegna, io credo che il teatro debba rivendicare la propria 'selvaticità', deve rivendicare di essere primitivo nelle sue ambizioni, e lo dico citando Castellucci che, a mio avviso, è uno degli spiriti più arcaici e primitivi che abbiamo. Poi ognuno può utilizzare i mezzi o le macchine che preferisce, o anche nulla, è secondario il modo con cui ti traduci, ma comunque io sto con Manfredini, con Castellucci e con Morganti, perché da spettatrice sento che tentano di portarmi all'origine di qualcosa.
MDP: venendo alle ormai numerose vostre rappresentazioni, queste spaziano da un tempo pre-mitico e mitico, ai classici fino a visioni contemporanee. Tutte però sono l'esito di una riscrittura metamorfica che riconduce al qui e ora di ognuno di noi il loro senso ultimo ed essenziale, quello veramente necessario dunque. C'è in tutto questo un prendere posizione sulla condizione umana in generale e su quella contemporanea in particolare?
GC: sì. Innanzitutto quando parli di riscritture metamorfiche ho l'impressione che la compagnia sia nata insieme a te. Riguardo al tema del contemporaneo, però, ritengo che su questo termine e sul suo abuso ci sia oggi un grosso fraintendimento, rispetto e in riferimento alla parola temporaneo. C'è una tale paura di scomparire dal sistema teatrale, ahinoi, che rischia di rendere tutti nostri tentativi delle cartucce temporanee. Anche noi non ne siamo esenti, ne discuto e ne parlo ma questo rischio lo percepisco Ora mi sembra che si debba pensare di poggiare uno sguardo sul contemporaneo che porti con sé una lezione vecchia come i greci, e mi sembra anche che questa lezione debba necessariamente relazionarsi con i vuoti dell'uomo di oggi. L'uomo di oggi, infatti, ha determinate paure e ferite che credo siano molto simili a quelle che poteva avere, come essere umano, ad esempio Giordano Bruno. Credo che l'orizzonte geografico e di pensiero di oggi permetta di fare un addizione di sensi che allora non era possibile. Abbiamo oggi un'arma eccezionale a disposizione: l'addizione di linguaggi. Oggi i media, qualunque essi siano, dalla video arte al lavoro sui suoni, possono ciascuno essere una addizione di sensi che concorrono ad una idea più grande, alla grande opera. In questo senso mi sembra oggi si debba ragionare ad una idea unificata delle arti. Quando parlo di idea unificata, però, non intendo dire che il teatro debba tradire il suo specifico linguaggio. Il teatro infatti è, per me l'attore, non è la macchina. Se nel prossimo spettacolo utilizzo degli schermi, questi devono servire a tradurre un lavoro dell'attore e una idea di una grande opera che la compagnia in quel momento sta condividendo. Tutti questi sono mezzi, per cui io credo che anche le riscritture debbano andare verso una sorta di post-modernità che tiene insieme l'antico ed il nuovo. È difficile e spesso, nel nostro tempo, ci sono delle regie che sono vecchie e stantie ma che improvvisamente, come dire, aprono una breccia in qualcosa di apparentemente strano, performativo, e solo per questo si ritengono contemporanee. Ma io non lo credo. Al contrario io ritengo che, oggi, ciò che è contemporaneo sia o debba essere un azzardo rispetto alle aspettative consuete, nei linguaggi e nelle tecniche. Soprattutto vorrei evitare l'ansia di dover fare per forza qualcosa di nuovo, perchè vorrei semplicemente tentare una comunione sincera e di finzione, i due termini vivono assieme, con il pubblico attraverso un linguaggio cui possiamo ambire, oltre. La televisione ci ha rovinato, Pasolini lo aveva capito fin troppo bene, la televisione sta distruggendo la percezione del bello, del sublime che è nelle persone, inoltre la velocità che impone la televisione sta rovinando la capacità di recitare di noi attori. Di molti, moltissimi attori, perchè per sopravvivere sei costretto a fare mille cose, perchè alcune di queste cose ti intossicano, perchè se lavori per mesi in brutti spettacoli qualcosa inevitabilmente ti rimane addosso. I no, al riguardo, sono importanti come i sì, come dice Creonte. Mi sembra che ciò che oggi può essere definito contemporaneo sia qualcosa che tenga insieme il passato con il futuro, e dunque si tenga ben lontano dal presente, poiché il presente muore nel momento in cui ne parli. Qualcosa che guardi al futuro e abbracci il passato ha dentro una ambizione commovente. Poi comunque siamo nel presente e me ne occupo, in quanto ne sono parte.
DG: anche quando proviamo, almeno per me, ed è questa una sensazione meravigliosa. Andare in scena è un po' come un inciampo. Ricordo che in una tua recensione hai usato questa parola, inciampo, che io trovo meravigliosa innanzitutto perché ti mette nella condizione di poter sbagliare ma soprattutto ha in sé la radice del cambiamento ed io, quando sono in prova, voglio cambiare, ma cambiare avendo le spalle coperte dal passato per lanciarmi verso il futuro.
MDP: un po' come sentirsi sempre sul filo, come il funambolo che sa che l'errore può essere fatale. Una tale condizione fa sì che tutto quello che si è venga messo in gioco in quello stesso attimo. È questo che richiama il termine inciampo, che tu ci sei, sei in scena con tutto quello che sei, e che ti serve a mantenere quell'equilibrio essenziale, a rintracciare l'umano. Per questo amo il teatro, poiché nel teatro posso incontrare un briciolo di verità, mentre nella vita di ogni giorno è la recita, la finzione, che sembra predominare. A teatro incontro la maschera che svela, mentre la maschera che cela la incontro nella vita comune, migliaia di volte, ed è quella la maschera di cui mi voglio liberare. L'inciampo dunque come modo per far cadere tutte queste sovrastrutture per trovare qualcosa di autentico di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. In questo il teatro è vitale e necessario e non morirà.
GC: vitale e che dà un senso alla comunità. C'è comunità nei teatri, anche se siamo ciascuno nelle proprie sedi, comunità e condivisione soprattutto in quelli piccoli.
MDP: Ora vorrei soffermarmi sulla vostra trilogia shakespeariana, in cui la fedeltà al testo, pur trasfigurato e travestito, mi sembra il mezzo per penetrare alcuni snodi essenziali dell'umanità dell'uomo, oltre il tempo, la storia e la stessa irrinunciabile narrazione del Bardo. Condividete questa valutazione?
GC : la condivido pienamente. La scelta di questa trilogia infatti non è nata da Shakespeare, quanto da vuoti esistenziali che stavamo vivendo in quei tre anni in cui la trilogia è nata, vuoti derivanti da lutti, perdite, recisioni ovvero da rapporti familiari non equilibrati. Questi vuoti si sono innestati nell'amore per Shakespeare, per le sue parole, le sue tecniche, la sua vicinanza al lavoro di metrica e melodia che stiamo portando avanti, facendo partiture orizzontali e verticali sulle parole e sui testi. Poi ci siamo accorti che anche altri sguardi autorevoli potevano raccontare, ad esempio in Hamlet, il triangolo amoroso tra Amleto, Gertrude ed Ofelia. Quindi abbiamo preso altri apporti oltre a Shekespeare, da Laforgue a Moscato e a Heiner Muller. Ma anche per quanto riguarda Shakespeare e il suo testo, io comprai allora tutte le traduzioni di Shakespeare, in italiano e francese, oltre al testo inglese, e ho passato cinque mesi a selezionare per ogni battuta, dalle diverse edizioni che avevo sotto mano, la parola più coerente. Infatti quando tu lavori sulla parola, non solo come significato, ma come corpo e materia, quel lavoro lo devi necessariamente fare, perchè in scena la dovrai in qualche modo incarnare, quella parola. Ad esempio sapevo che Davide avrebbe detto certe cose piuttosto che altre in quanto ci sono sonorità che lui ama in particolare. Tutto ciò, la scelta delle parole e tra i vari autori, contribuiva dunque a costruire una visione di questo lavoro. Per quanto riguarda l'Otello, che ha girato poco perchè forse scenotecnicamente al limite delle nostre possibilità dell'epoca, il lavoro intercettava “Il Paradiso perduto” di Milton, insieme a Shakespeare. Ho voluto infatti capire se Otello poteva essere Lucifero, cioè un angelo caduto, preda più dell'ansia di non essere amato che di quella di non riuscire ad amare, mentre Desdemona assumeva il ruolo di un “disdemonio”, che scatena il putiferio, che scatena l'inferno. Partendo da questo è nato, tra Milton e Shakespeare, ma anche da semi di William Blake, una sorta di viaggio misterico, un viaggio oscuro con soli tre personaggi (Iago, Otello e Desdemona) e in scena solo una mano a forma di ragno con in cima una seggiolina su cui ero seduta io, che facevo Iago, mentre all'interno delle gambe, che erano percorribili, agivano Otello e Desdemona. Un ragno medioevale di quasi sei metri, di legno e placche di ferro, quasi una macchina da tortura. Quindi anche con quello spettacolo non abbiamo pensato a come mettere in scena Otello, ma a come possiamo raccontare la caduta di un passero, la dissoluzione di un uomo. Così ci è venuto in mente di innestare Milton, che è parte del nostro background, in Shakespeare, ed è nato uno sposalizio esoterico, veramente pazzesco. Il Titus invece è un lavoro piuttosto diverso, in quanto figlio soprattutto delle improvvisazioni di Davide. In esso abbiamo fatto, per la prima volta, un lavoro molto interessante e curioso. Io due volte alla settimana dicevo a Davide: <<la settimana che verrà vorrei lavorassimo sulle prime dieci pagine del Titus. Non voglio però che lo impari a memoria, vorrei invece che tu lo leggessi tanto da diventarne impregnato e da conoscere ogni anfratto di quelle pagine. Quando ci vedremo la settimana prossima a teatro io ti suggerirò dei nuclei drammatici (Lavinia nel bosco ad esempio, oppure l'incontro di te uomo saggio e benvoluto con la tua maschera di orrore e violenza, con cui ti devi confrontare). Il testo ce l'hai nel corpo per cui lavora a crearmi delle sequenze improvvisative>>. Io lo lasciavo lavorare per alcune ore. Eravamo presenti io e Fabricja, la mia assistente alla regia, che registrava queste sequenze. Poi, il giorno dopo, provavamo a trattenere qualcuna di queste sequenze, qualcosa di meraviglioso e così, man mano, sono nati il testo drammaturgico ed insieme il lavoro dell'attore. Il testo di Shakesperare, con sedici personaggi, è diventato un monologo tra Davide, due carciofi e un pomodoro e via dicendo. Riguardo a tutto questo, però, devo raccontarti un episodio. Quando mia nonna, che mi ha cresciuto insieme a mia madre ed è stata una presenza meravigliosa nella mia esistenza, morì non riuscimmo a mettere nella sua bara una piccola lettera, che le avevo dato come mio regalino il Natale precedente. Infatti solo dopo il funerale, a bara già chiusa quando apriamo il cassettino della sua camera da letto, troviamo questa lettera con scritto sopra: “questa lettera deve venire con me nella bara”. Quella lettera è esattamente quella che Davide utilizza quando lascia il suo ultimo saluto a Lavinia, su quel piccolo vasetto di fiori che è il ricordo e l'omaggio alla tomba di lei. Io rammento che decidemmo di fare lo spettacolo proprio a partire da quella lettera, che non ero riuscita a mettere nella bara di mia nonna. Non dal Titus di Shakespeare ma da una recisione anzitempo.
MDP: mi torna alla mente il Principe Costante e il racconto della sua genesi che ne fa Grotowski. Ma andiamo per un momento ad altri problemi. La Piccola Compagnia della Magnolia è una compagnia di ricerca che ha fatto della sua continuità interna un valore. Siete dunque una sorta di compagnia stabile, ovvero, secondo la tradizione francese cui siete molto legati, quasi un atelier nell'insegnamento di Copeau. Siete integrati e ricevete sostegno, non solo in senso economico, dalla comunità teatrale, piemontese e nazionale?
GC: Assolutamente sì. Devo dire che abbiamo, come compagnia, un ottimo rapporto con il sistema teatrale piemontese. Peraltro il Piemonte, rispetto al resto dello stivale, soffre un pochino il suo essere un po' periferico, questo per quanto attiene i meccanismi nazionali. Invece per quanto riguarda il nostro essere integrati nella nostra regione, questo sì, c'è un bellissimo rapporto sia con le istituzioni che con i colleghi. A livello regionale riceviamo dal 2007 un contributo, peraltro modesto, in quanto compagnia riconosciuta di produzione. Poi abbiamo ora un rapporto più stretto anche con la città di Torino attraverso il Bando “Torino Arti Performative”, una sorta di braccio operativo della municipalità e del Teatro Stabile per sostenere i progetti delle compagnie cittadine, tra cui la nostra. Ma per le compagnie indipendenti il problema non è tanto il riconoscimento delle istituzioni, quanto è quello della distribuzione, poiché il Ministero preme per avere soprattutto, se non solo, scambi tra i teatri istituzionali. In questo sembra esserci un disegno preciso, quello di far sparire le tournée di giro, e dunque le Compagnie indipendenti, e ciò è molto grave. È questo il vero problema dell'oggi, ed è questo il motivo delle gravi difficoltà economiche e di sopravvivenza delle compagnie come la nostra.
MDP: così si uccide però anche lo studio e la ricerca nel teatro italiano.
GC: è esattamente così. Fino al 2012/13, almeno per quanto riguarda noi, le annate erano molto ricche ed eravamo sempre in movimento tra Italia e Francia. Poi, via via, c'è stata una diminuzione, e si è creata una stuazione difficile che ha impattato sulla economia e sulla gestione, per cui ora siamo una Compagnia molto ridotta, in quanto non riusciamo più a garantire a tutti i suoi membri uno stipendio esclusivo. Fino al 2013 avevamo cinque persone che lavoravano esclusivamente per la Compagnia, senza che avessero altre collaborazioni esterne, persone che potevo stipendiare dunque, cosa che non era usuale per un ensemble giovane. Ora non è più così e quelle situazioni sono un bel ricordo. Quasi tutti sono diventati collaboratori, che chiamo dunque solo quando si collabora. Con il fisso siamo rimasti solo io e Davide. Però, ci tengo a dirlo ed è una cosa bella, da quando è nata la compagnia i compagni, prima fissi ora solo collaboratori di volta in volta, sono sempre gli stessi. Nonostante tutto dunque siamo una famiglia, di grandi relazioni, di affetti e anche di cambiamenti.
MDP: conosciamo tutti il periodo che, purtroppo, stiamo attraversando. Volete ora parlarci di come avete affrontato la chiusura per COVID ed in particolare del nuovo progetto che avete chiamato “Favola Eretica” e di cui il docu-film “I registri del sonno” è una anticipazione-introito?
GC: l'idea di “Favola Eretica” nasce a fine 2018 inizi 2019. e nasce dalla voglia di lavorare il tema della possibilità di essere qualcun'altro. Questo tema l'abbiamo avvicinato e sovrapposto all'atto dell'addormentarsi e del risvegliarsi, interpretando addormentamenti e risvegli come movimenti dai quali si esce diversi. È come se ciascuno di noi, attraverso quel movimento, potesse essere man mano persone diverse, in nuovi corpi o in nuove ere, un po' come l'Orlando di Virginia Woolf, romanzo questo che ha aperto alla riflessione sul tema specifico, concretizzatasi poi nel Calderon di Pasolini. Il Calderon di Pasolini, infatti, ha costituito per noi una ispirazione, a partire dall'addormentamento e dal risveglio che accompagnano l'esistenza di Rosaura per tutto lo sviluppo dell'opera, anche se ne abbiamo in seguito abbandonato l'ossatura, in quanto la nostra sarà un opera originale scritta da Fabrizio Sinisi su mio progetto, pur a partire da quel dono ispirativo iniziale. Quindi il tema del lavoro è la possibilità di essere qualcun'altro, come in un sogno o anche per una eresia, di essere ad esempio una prostituta che sogna di svegliarsi e di andare in un confessionale a raccontare al sacerdote che cosa è l'amore. Questa è, per noi, una utopia eretica, una possibilità. Oppure come un cadavere che racconta da una ipotetica Radio Universo come ci vede lui da lassù. Possibilità surreali ma capaci di raccontare in che modo ci coinvolge un cambiamento, un essere qualcosa d'altro. Favola Eretica nasce in questo modo e subito si incunea ne “l'Atelier sul Mare” di Tusa, un piccolo paesino di pescatori in Sicilia che abbiamo scoperto nel 2018. Varie stanze dell'Atelier sono state realizzate, su richiesta del mecenate Antonio Presti che lo dirige, da alcuni dei massimi artisti di arte moderna. E' un albergo come altri tranne che in venti stanze, le cui chiavi Presti ha dato appunto ai diversi artisti con il mandato a ciascuno di firmarla con il proprio segno. Quando sono arrivata lì, alcune di esse, in primis quella di Pasolini firmata da Laura Betti, Dario Bellezza e Danielle Mitterand, mi hanno stregato. È un albergo, quindi fatto di stanze dove ci si addormenta e ci si sveglia, e allora ho avuto la consapevolezza che tre o quattro di quelle a me evocavano un mondo di possibilità. Abbiamo deciso così di usarle per situare in ciascuna i due protagonisti di Favola Eretica, che sono Lui e Lei, quando sognano appunto delle utopie eretiche. Mettiamo dunque queste favole in quelle stanze attraverso un dialogo tra teatro d'attore di palco e video-arte. Così, quando andremo in scena, vorrei costruire una sorta di palazzo d'Inverno sul palco, un palazzo dove degli specchi diventano proiezioni di sé dentro ad altre stanze, stanze sognate che non sono la tua che hai sul palco ed è la vita reale. Nasce in questo modo Favola Eretica, e in questo ambito stiamo iniziando a lavorare il linguaggio della video art.
MDP: è, come dicevate prima, un vostro tentativo di utilizzare e amalgamare da tutte le arti un creativo pluri-linguismo?
GC: proprio questo. Colui che poi, attraverso tutto ciò, mi interessa è lo spettatore. Se lo spettatore mi guarda sul palco, ha una visione epica che comprende me dentro il rettangolo della scena. Ci incuriosiva dunque capire come può dialogare questa visione brutale, grezza, in cui lo spettatore non può sezionare e selezionare alcun dettaglio di me, con il video che necessariamente soggettiva il soggetto inquadrato e quindi impone a me attore, ma anche a te spettatore, una esperienza in un certo senso anti-democratica di dettaglio veicolato. È il dialogo tra queste due prospettive che adesso ci appassiona e ci interessa. Il punto centrale è sempre il lavoro dell'attore e come slitta tra palco e il quadrato dello schermo. La domanda è cosa scelgo di darti come dettaglio?
DG: è un lavoro, questo dal lato dell'attore, che ci appassiona moltissimo, soprattutto per questa metamorfosi linguistica, poiché sia io che Giorgia interpreteremo, ora in scena, ora sullo schermo, vari personaggi, vari tipi, nel senso della commedia dell'arte (un poeta, una prostituta, un astronauta ecc.), con maschere, trucci, parrucche e quant'altro. Diventa tutto molto affascinante anche perché il cinema ci ha sempre interessato moltissmo e in questo periodo soprattutto.
GC: in effetti stiamo anche facendo come attori delle piccoli incursioni in corsi con autori indipendenti. Tornando al sincretismo tra le arti, se pone al centro il progetto, una visione coerente, e non un caravanserraglio di idee diverse messe insieme alla bell'e meglio, allora diventa una grande ricchezza. Ma tutto ciò deve partire sin dal primo giorno del progetto, come nel caso di Fabrizio Sinisi che lavora su di noi, in apposite sessioni testa lo scritto su di noi per scoprire se e dove modificarlo e a cui affidiamo le parole di questi ultimi spettacoli. Fabrizio e Massimo Sgorbani, (autore della nostra ultima produzione Mater Dei) infatti sono, per conto mio, rimasti con un piede nel rito, e questo li rende due bestie rare. Inoltre Favola Eretica è il primo momento di un progetto complessivo intitolato “Vulnerabili” che vedrà “I cenci” come suo secondo momento e vedrà con “Enrico IV” la sua conclusione. Perchè queste tre cose? Innanzitutto in quanto la vulnerabilità ci tocca, è chiaro e non è un caso che questa idea sia nata proprio adesso, sia in quanto vulnerabilità al tempo che passa tra i mille cambiamenti della persona, e questo è Favola Eretica, sia quale vulnerabilità alla violenza, come ne “I Cenci”, e infine ne l'Enrico IV, come vulnerabilità alle maschere che ci fa assumere il mondo. Rappresentano dunque, questi tre momenti creativi, tre vuoti dell'essere umano, del singolo, dell'individuo. È un progetto che durerà fino al 2024. Infatti avendo deciso di congelare, dal punto di vista produttivo, il 2021, “Favola Eretica” uscirà nel 2022, “I Cenci” l'anno successivo, e “Enrico IV-I cavalli non entrano mai nelle case”, appunto, nel 2024.
MDP: dunque nel 2021, anche per transitare questa difficile situazione, siete concentrati su “I registri del sonno”, un docu-film che, oltre ad essere una sorta di scaturigine ispirativa del ciclo di Favola Eretica, ha una sua autonoma coerenza. Me ne volete parlare?
GC: Esattamente, anche se, nel frattempo, è diventato anche un modo e un mezzo per sapere cosa pensa la gente. Ad esempio su cosa è “eretico”. È solo Giordano Bruno? Oppure anche tu che ad un certo momento hai compiuto delle scelte che hanno sparigliato le carte? Vuoi raccontarla, questa tua scelta corsara nella vita? Eresia ma anche utopia, termini che credo viaggino insieme. In particolare mi sembra che l'Eresia trattenga a terra il rischio di volare in aria, come l'elio, dell'utopia, mentre l'utopia è capace di dare all'eresia una prospettiva di futuro. Dunque metteremo le persone dentro a un letto, le persone che verranno intervistate le metteremo dentro a un letto, proprio come noi in Favola Eretica, e da lì ci regaleranno un risveglio, una sorta di confessione. Ne uscirà un docu-film appunto di 40 o 45 minuti che spero riesca a raccontare come i cittadini di questo paese sono pieni di azioni eretiche compiute nel corso della loro vita, nel loro piccolo storico.
MDP: dunque usate eresia nel suo etimo greco, nel senso di saper prendere una decisione, nel senso di scelta, e anche come una resistenza contro quella violenza del consenso che oggi è così dominante nelle nostre vite vissute. C'anche un aspetto che riguarda l'inconscio?
GC: ti direi di no, almeno non nella nostra volontà cosciente. C'è il letto perchè ci è piaciuta l'idea di realizzare un film con una carrellata di risvegli. Una volta che le persone si sono risvegliate ci regalano un momento di disvelamento di sé. Non credo dunque ci sia una suggestione psicoanalitica. Questo progetto nasce anche dalla nostra decisione, in questo 2021 di chiusure, di non lavorare in streaming, perchè il teatro si fa in palco, ma eventualmente di lavorare con i linguaggi pertinenti al video, come appunto un docu-film, ove continuiamo a fare il nostro lavoro ma con un linguaggio diverso adeguato al mezzo diverso. A settembre 2020 abbiamo, ad esempio, realizzato un esperimento tra teatro e video su “Mater Dei”, un vero e proprio esperimento di video-arte però, non una semplice ripresa video. Un esperimento per chiederci cosa del teatro è bene trattenere e cosa invece nuoce, in video. Ciò che è bene trattenere, per noi, è solo l'attore, che è quello che resta coerente ad ogni mezzo. Il resto del teatro invece non lo si può traslare di mezzo in mezzo come se niente fosse. Ciò che è di palco infatti, ha degli umori e delle sfumature che si smuovono e si accendono solo sul palco. Sto scoprendo infatti che, in ciò che lavora in inquadratura video, bisogna si abbandonino certe affezioni del palco, come ad esempio la compresenza di tanti elementi che ci piace avere in teatro, lasciando poi agli spettatori la scelta di dove far cadere lo sguardo. Invece il video ti obbliga ad un incessante lavoro di setaccio dell'inquadratura, una continua serie di sì o di no, anch'esso d'altra parte interessante. Basta settarsi sul medium e sul linguaggio che devi usare senza 'buttare' il teatro in streaming, con esiti a mio avviso spesso sconcertanti.
MDP: a volte questo è quasi un gesto di disperazione, anche per la paura di essere dimenticati che attanaglia molti artisti di fonte alla scarsa attenzione che c'è verso la cultura da parte di istituzioni piene di pregiudizi, a partire da quello Crociano relativo al testo, e che dimenticano l'efficacia non solo estetica, ma anche economica, del teatro. D'altra parte anche per me il teatro in streaming purtroppo non funziona. A me arriva ad annoiare, diversamente dal vivo ove, a chi vede molto teatro come me, può anche accadere di incontrare qualcosa che non piace, ma ove comunque, nel palco, può sempre intercettare un elemento che coinvolge. Si crea sempre, anche negli spettacoli amatoriali più ingenui, una alchimia non altrimenti distillabile.
GC: hai toccato un punto dolente per il nostro teatro, diversamente a quanto accade altrove in Europa. Del resto anche l'informazione è molto manipolata per cui vengono interpellati solo i referenti dei grossi centri di interesse istituzionale. E i Teatri Stabili, a proposito di pregiudizio crociano, sono la culla mortifera della testo-centricità italiana, tutta e forse solo italiana, se non un po' anche francese. Se guardiamo il nord e l'est europa, lì il teatro è un fatto globale, è la grande opera, non è solo il testo ovvero la messa in scena. Questo è un problema.
MDP: così anche i grandi mezzi di comunicazione e l'industria culturale televisiva canalizzano solo una parte ben precisa del teatro, quella appunto più istituzionalizzata, lasciando ai margini molto del resto di un panoramo ben più vasto e vivace, come il teatro di studio e di ricerca che nella carrellate che vediamo è in gran parte assente. Ne risulta una realtà molto omologata rispetto ad un passato non troppo lontano in cui gli Stabili aprivano anche ad esperienza di innovazione. Così ad esempio al teatro di Genova diretto da Luigi Squarzina poteva capitare di vedere Carmelo Bene o Leo De Berardinis e la Tatò. Anche loro erano in cartellone. Oggi lo sarebbero?
GC: quanto dici io lo condivido. Probabilmente Squarzina, a Genova, pensava non solo allo sbigliettamento ma anche alle generazioni future. Aveva ambizione, nel senso migliore del termine, e l'ambizione, non la presunzione, deve muovere chi gestisce oggi il timone del teatro e della cultura italiana, altrimenti l'orizzonte è oscuro.