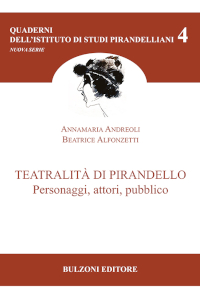È sostanzialmente impossibile recensire degli spettacoli costruiti su testi della drammaturgia classica greco-latina se non si premettono delle considerazioni che afferiscono alla dimensione filosofica o più latamente culturale che queste operazioni teatrali possiedono. Esse implicano e quasi pretendono infatti dei dialoghi con testi che, per quanto pregevoli dal punto di vista letterario, sono indiscutibilmente dei veri e propri relitti di una civiltà rispetto alla quale noi coltiviamo un rapporto di identità e continuità ma, al contempo, anche di alterità e discontinuità. Si tratta inoltre di operazioni complesse di traduzione e non tanto da lingua a lingua e da cultura a cultura, quanto di transcodificazione tra codici espressivi diversi e accostabili solo sul piano della connotazione e di una creatività artistica che necessariamente, per essere viva e feconda, deve volgersi alla contemporaneità. Vi è infine un’ultima considerazione, sempre di tipo filosofico, che riguarda la messa a fuoco temporale dei testi della drammaturgia antica: il passato
non è una terra straniera da riconquistare, non è uno spazio da esplorare, misurare, osservare, ascoltare. Nulla di tutto questo. Il passato non può essere considerato altrimenti che un sedimento culturale, memoriale, storico, psichico spesso vivo e operativo nella realtà e nella quotidianità dei popoli e delle persone, talvolta vivo ma in modo silente e sotterraneo, talvolta ormai inerte ma comunque dotato di una sua operatività passiva per lo spazio (culturale o psichico) che occupa e consuma. Ricapitolando, non si possono comprendere degli spettacoli basati sulla lettura delle opere della drammaturgia greco-latina se non avendo presente che si tratta di operazioni che presuppongono: un’attività di dialogo autentico col testo antico, un lavoro “complesso” di traduzione e transcodificazione, una consapevolezza viva e vigile che il passato e le sue concrete occorrenze non si trova “nel passato” ma nel presente della nostra psiche, della nostra memoria, della nostra cultura e della ricerca storica che la innerva, delle dimensioni spirituale e socio-politica in cui siamo immersi. Se teniamo ben presenti questi tre dati allora sarà possibile porsi abbastanza lucidamente di fronte agli spettacoli tratti dalla drammaturgia classica e darne conto a partire dalla loro onestà intellettuale e autentica necessità artistica. Ulteriore postilla di senso: con tutta evidenza gli spettacoli che ormai da anni si vedono nel teatro greco di Siracusa non sono “di” Eschilo, Sofocle, Euripide, Seneca, Aristofane e Menandro, ma provengono “da” questi autori, con una filiazione più o meno diretta ma legittimamente e giustamente libera. Ormai i tempi sono maturi a Siracusa per accettare, anche nella comunicazione pubblica dell’Inda, questo cambio di preposizione che potrebbe sembrare una semplice, piccolissima innovazione, limitata al piano formale, ma che invece racchiuderebbe la presa d’atto pubblica e “istituzionale” (ovvero da parte dell’Istituto nazionale del Dramma Antico e delle amministrazioni locali) di un radicale cambio di atteggiamento nei confronti del patrimonio della drammaturgia classica. Un cambio di atteggiamento che è già in atto da tempo e spiegherebbe il quadro di senso in cui nascono gli spettacoli che sono in scena a Siracusa anche in questa cinquantaseiesima stagione. Il dittico “Coefore/Eumenidi” costruito e diretto da Davide Livermore, avendolo tratto dalle omonime tragedie di Eschilo è uno spettacolo serio, importante, ben strutturato. In scena, a giorni alterni dal 3 fino al 31 di luglio. Uno spettacolo totalmente e positivamente politico, scavato nel soggetto mitologico ma proiettato ben oltre esso, politico nella sua sostanza più profonda, come è giusto che sia una tragedia. Il regista ha fatto bene e ha saputo onorare sia il compito che gli è stato assegnato, sia l’importanza dello spazio e della tradizione teatrale in cui si è trovato ad operare. L’idea centrale è quella di usare il segmento mitologico della vendetta di Oreste su Clitennestra per l’assassinio del padre e marito Agamennone e del superamento del matricidio imposto da Apollo con l’intervento di Atena e la creazione del tribunale dell’Areopago, come plot di senso per scandagliare un periodo abbastanza recente (e rimosso) della nostra storia nazionale, ovvero negli anni quaranta del secolo scorso l’estrema decadenza e la fine del regime fascista, nella sua cruenta facies repubblichina, e della monarchia collusa con esso, e l’avvento della democrazia e della repubblica ancorata ai valori della resistenza antifascista. Un ancoraggio dovuto alla saggezza politica, prima che giuridica, dei padri e delle madri costituenti. La traduzione del testo euripideo, bella e densa di sensibilità teatrale, è di Walter Lapini, le scene sono dello stesso Livermore, i costumi di Gianluca Falaschi, le musiche di Andrea Chenna e in buona parte eseguite in scena da Diego Mingolla e Stefania Visalli (due pianoforti e un’arpa), il disegno luci è di Antonio Castro. Non è pleonastico ricordare questi nomi oltre a quello del regista, responsabile artistico primo di quanto va in scena: una delle qualità fondamentali di questo lavoro è appunto la sua densità nell’utilizzare magistralmente tutta la scena, nel riempirla d’azione, di colori, di oggetti, nell’innervare di senso ogni minima scelta. Nulla è lasciato al caso e nulla è autonomo rispetto alla lettura che il regista vuol offrire del testo eschileo. La scenografia si dispiega in questo senso: una grande strada/skené, issata su piloni e crollata rovinosamente (ma se il regista e scenografo è il direttore del teatro di Genova è difficile chiedere al pubblico di non pensare al crollo del Ponte Morandi), l’orma gelida del tempo che copre ogni cosa (dai due pianoforti a uno sbilenco divano Chester, da un grammofono a un tavolino coperto di calici e champagne), una interessantissima, enorme ed enigmatica sfera, luminosa e di grande effetto che accompagna le varie fasi dello spettacolo ore come sole, stella, galassia, ora come occhio, ora terra, oceano, divinità luminosa, ora come astratto schermo trasmettitore di immagini, colori e atmosfere. Nulla è privo di senso, al punto di rischiare un po’ lo stucchevole laddove Elettra riconosce il passaggio del fratello non dal ricciolo ma da un proiettile, o quando Oreste uccide Clitennestra dandole da trangugiare del veleno e un calice di champagne oppure ancora – forse un po’ peggio – laddove la luminosità di Apollo non si trova di meglio che rappresentarla da uno smoking a giacca bianca che, inevitabilmente, fa tanto James Bond.
Il dittico “Coefore/Eumenidi” costruito e diretto da Davide Livermore, avendolo tratto dalle omonime tragedie di Eschilo è uno spettacolo serio, importante, ben strutturato. In scena, a giorni alterni dal 3 fino al 31 di luglio. Uno spettacolo totalmente e positivamente politico, scavato nel soggetto mitologico ma proiettato ben oltre esso, politico nella sua sostanza più profonda, come è giusto che sia una tragedia. Il regista ha fatto bene e ha saputo onorare sia il compito che gli è stato assegnato, sia l’importanza dello spazio e della tradizione teatrale in cui si è trovato ad operare. L’idea centrale è quella di usare il segmento mitologico della vendetta di Oreste su Clitennestra per l’assassinio del padre e marito Agamennone e del superamento del matricidio imposto da Apollo con l’intervento di Atena e la creazione del tribunale dell’Areopago, come plot di senso per scandagliare un periodo abbastanza recente (e rimosso) della nostra storia nazionale, ovvero negli anni quaranta del secolo scorso l’estrema decadenza e la fine del regime fascista, nella sua cruenta facies repubblichina, e della monarchia collusa con esso, e l’avvento della democrazia e della repubblica ancorata ai valori della resistenza antifascista. Un ancoraggio dovuto alla saggezza politica, prima che giuridica, dei padri e delle madri costituenti. La traduzione del testo euripideo, bella e densa di sensibilità teatrale, è di Walter Lapini, le scene sono dello stesso Livermore, i costumi di Gianluca Falaschi, le musiche di Andrea Chenna e in buona parte eseguite in scena da Diego Mingolla e Stefania Visalli (due pianoforti e un’arpa), il disegno luci è di Antonio Castro. Non è pleonastico ricordare questi nomi oltre a quello del regista, responsabile artistico primo di quanto va in scena: una delle qualità fondamentali di questo lavoro è appunto la sua densità nell’utilizzare magistralmente tutta la scena, nel riempirla d’azione, di colori, di oggetti, nell’innervare di senso ogni minima scelta. Nulla è lasciato al caso e nulla è autonomo rispetto alla lettura che il regista vuol offrire del testo eschileo. La scenografia si dispiega in questo senso: una grande strada/skené, issata su piloni e crollata rovinosamente (ma se il regista e scenografo è il direttore del teatro di Genova è difficile chiedere al pubblico di non pensare al crollo del Ponte Morandi), l’orma gelida del tempo che copre ogni cosa (dai due pianoforti a uno sbilenco divano Chester, da un grammofono a un tavolino coperto di calici e champagne), una interessantissima, enorme ed enigmatica sfera, luminosa e di grande effetto che accompagna le varie fasi dello spettacolo ore come sole, stella, galassia, ora come occhio, ora terra, oceano, divinità luminosa, ora come astratto schermo trasmettitore di immagini, colori e atmosfere. Nulla è privo di senso, al punto di rischiare un po’ lo stucchevole laddove Elettra riconosce il passaggio del fratello non dal ricciolo ma da un proiettile, o quando Oreste uccide Clitennestra dandole da trangugiare del veleno e un calice di champagne oppure ancora – forse un po’ peggio – laddove la luminosità di Apollo non si trova di meglio che rappresentarla da uno smoking a giacca bianca che, inevitabilmente, fa tanto James Bond.
Funzionale a questa organicità di visione è ovviamente l’interpretazione consapevole e complessivamente molto solida degli attori: in Coefore, Giuseppe Sartori (Oreste), Spyros Chamilos (Pilade), Anna Della Rosa (Elettra), Gaia Aprea, Alice Giroldini, Valentina Virando, Chiara Osella, Graziana Palazzo, Silvia Piccollo (le Coefore), Laura Marinoni (Clitennestra), Stefano Santospago (un Egisto debosciato e spaventato), Maria Laila Fernandez, Marcello Gravina, Turi Moricca (delle Erinni – poi Eumenidi - straniate, ambigue, decadenti in brillante costume charleston); Maria Grazia Solano (la Pizia), Giancarlo Judica Cordiglia (Apollo), Olivia Manescalchi (Atena). Vale davvero più di tutto la straordinaria forza del gruppo ma è evidente che, confrontandosi con personaggi di grande complessità, devono rilevarsi le prove di Sartori che disegna con nettezza di tratto un Oreste debole e soggiogato da Elettra (un’Anna Della Rosa di bella e severa assertività), giovane balbettante di fronte alla madre Clitennestra (una grande Marinoni di incontenibile vitalità, sfatta di troppa vita, ferita e dai mille altri colori che confermano - se mai ce ne fosse bisogno - la strepitosa interprete che conosciamo), annichilito da Apollo che - immaginato come un politico scaltro e sicuro delle sue carte - lo spinge, lo manovra e lo protegge con freddezza quasi sorniona (molto efficace Judica Cordiglia). Nulla di particolarmente nuovo però nell’immaginazione di questa rete di personaggi, se non fosse che, nella metafora storico-politica complessiva di cui si è detto, la debolezza di Oreste finisce con l’incarnare con grande raffinatezza una certa debolezza della cultura politica resistenziale nei confronti dei residui tossici del fascismo nella società italiana del dopoguerra: una società che si struttura velocemente e superficialmente come post-fascista più che, consapevolmente e rigorosamente, anti-fascista. Alla fine dello spettacolo le Erinni, sanguinarie vendicatrici dei consanguinei trucidati (in un contesto che si definirebbe di guerra civile), si trasformano in benevole Eumenidi - e qui l’eco della riflessione di Pasolini sull’Orestea si avverte con nettezza. Evidentemente però, secondo la lettura di Livermore, questa trasformazione non deve essersi compiuta del tutto se alle scorie tossiche del fascismo possono essere collegati alcuni degli episodi più tragici della storia italiana repubblicana (dalle stragi di stato ai fatti di Genova, dai rapporti tra stato e mafia ai più sanguinosi omicidi della mafia). Interessantissima è allora la luminosa figura di Atena rappresentata in due visioni: da una parte la statua della dea che aggancia il personaggio all’iconografia classica e al muto linguaggio del mito (Federica Cinque), dall’altra una rigorosa “madre” della repubblica capace di gestire con perfetto rigore formale ed equilibrio politico la dialettica giudiziaria e politica tra Apollo e le Erinni che porterà alla assoluzione di Oreste e alla trasformazione di quelle divinità ctonie in luminose Eumenidi: un personaggio molte interessante in questo contesto teatrale e davvero assai ben interpretata da un’ottima Olivia Manescalchi. Tutto positivo allora in questo lavoro? In effetti no, ci sono delle fragilità che vanno notate e, per quanto possibile, spiegate. L’idea di regia ha avvolto totalmente il testo di Eschilo e ne ha ricavato una rilettura/riscrittura bella, compatta ed estremamente politica. Ma appunto proprio perché politica Livermore ha voluto, e forse dovuto, allontanare gli eventi, metterli sotto una luce epica. Questo carattere epico ha quindi trascinato con sé le musiche che, pur molto interessanti e di gusto contemporaneo, hanno talvolta assunto i toni – assai meno efficaci e pregnanti - di una colonna sonora cinematografica. Ancora questo carattere di epos politico ha indebolito, se non proprio azzerato, la presenza ingombrante dell’alterità (o di una riflessione visibile rispetto all’alterità) della cultura greca: ad esempio nel maschilismo con cui si spiega la dimensione di non consanguineità delle madri rispetto ai figli o nella religiosità ancestrale che è, ovviamente, del tutto intrecciata alla presenza stessa del tragico.  Di tutt’altro tenore è lo spettacolo Baccanti che la compagnia catalana Fura dels Baus ha costruito a partire dal testo di Euripide, ritradotto per l’occasione da Guido Paduano. In scena a giorni alterni dal 4 al 30 luglio e dal 4 al 20 agosto. Se lo spettacolo di Livermore è profondamente politico e rivolto a una riflessione sulla storia contemporanea, questo Baccanti presenta una riflessione maggiormente rivolta al dato antropologico del nostro presente: chi è oggi Dionìso? Da dove nasce la sua forza inarrestabile? La risposta del regista Carlus Padrissa, leader in questo caso dell’ensemble catalano, si colloca evidentemente nel “femminile”, nella forza liberante e rivoluzionaria del femminile rispetto al potere maschile che ancora perdura nella violenza della sua prassi di sopraffazione: Dioniso diventa donna, diventa Dionisa e le baccanti, bellissime, energiche, selvagge finiscono con il caricarsi simbolicamente del peso di tutte le rivolte femminili e femministe che attraversano da sempre l’occidente e la sua storia e che nei nostri anni stanno giungendo, forse finalmente, ad una affermazione piena e definitiva della parità e della libertà delle donne. È legittimo costruire uno spettacolo di questo tipo a partire dal testo di Euripide? Assolutamente sì: come per Coefore/Eumenidi non vediamo Eschilo ma Livermore che si confronta con Eschilo, così qui non vediamo Euripide ma Padrissa che si confronta, da artista, con Euripide. Padrissa e l’intero immaginario artistico, consolidato e riconoscibilissimo, della Fura: la periferia urbana e degradata riempie tutta la scena con una gru che col suo braccio solleva in alto il coro delle Baccanti a formare (ed è una immagine di strepitosa intensità) un essere mobilissimo, vibrante, plurale e pluriforme che vuol essere il corpo mistico di Dionìso; i costumi delle baccanti/donne in rivolta dal potere maschile che ricollocano l’ancestrale clamore bacchico nel presente delle donne che si ribellano (nel Messico, ad esempio, due anni fa); un’enorme testa umana di reticolato metallico che accoglie aprendosi le baccanti a suggerire una dimensione immanente e mentale del dionisiaco (tutti e tutte siamo Bacco). Un'altra grande statua di reticolato metallico è situata sulla parte opposta della scena, rappresenta ancora la divinità in questione nella forma tradizionale e ambigua di uomo e toro insieme, ma la sua funzione appare pleonastica. Come sostanzialmente pleonastica appare la grande lavagna nera, semicircolare che copre metà dell’orchestra e riporta l’albero genealogico di Cadmo, Penteo e Dioniso. A dirla tutta è complessivamente tutta la scena che appare poco meditata e non convince soprattutto per gli spazi vuoti che, se permettono le energiche camminate di Dioniso, sembrano più effetto di poca conoscenza delle dimensioni della scena siracusana che consapevoli scelte artistiche. Cosa non convince ancora in questo percorso concettuale? Il fatto che viene sostanzialmente eliminato dalla costruzione dello spettacolo il dato del mistero oscuro, ambiguo e perciò stesso inquietante (perturbante) che circonda la religiosità dionisiaca ma soprattutto, anche in questo caso, non convince la rinuncia a confrontarsi (e a far confrontare il pubblico), anche criticamente, con il dato dell’irriducibile alterità del testo antico e della cultura che lo ha prodotto. È molto discutibile l’affermazione/assioma che “siamo tutti Bacco” e, se mettere in scena “Dionìsa” rende possibile una conseguente strategia di costruzione dello spettacolo, questa scelta semplifica la meravigliosa polisemia del testo Euripideo che certo può includere una riflessione sul percorso di liberazione delle donne ma, ad esempio, oggi potrebbe sollecitarci moltissimo sul rapporto tra desideri e vissuti personali e diritti pubblicamente sanciti o tra libertà personali ed esercizio del potere pubblico, tra religiosità e religione civile. Detto questo però è chiaro che parliamo di uno spettacolo comunque importante: interessante è il tentativo di riscrivere in scena la potenza disumana della presenza e dell’intervento di Bacco; straniante (e affascinante) è il clamore delle Baccanti, numerosissime e selvagge, che entrano in scena colpendo e afferrando da sopra e dalle spalle l’attenzione del pubblico; sicuramente notevole è la potenza con cui Dioniso (una Lucia Lavia in stato di grazia) attraversa la vicenda e con cui le corifee guidano quell’esercito femminile a al femminile (Simonetta Cartia, Elena Polic Greco e, con loro, Rosy Bonfiglio, Ilaria Genatiempo, Lorenzo Grilli, Cecilia Guzzardi, Doriana La Fauci, Viola Marietti, Katia Mirabella, Giulia Valentini a cui si aggiungono almeno una cinquantina di artisti del “coro sospeso” e del “coro dei cittadini”). Ovviamente se Lavia segna profondamente questo spettacolo con la sua energia, all’altezza appaiono (se non altro per la solidità del mestiere, anche quando si trovano a dover omaggiare in modo improbabile il genio di Franco Battiato) Stefano Santospago (Cadmo), Antonello Fassari (Tiresia), Linda Gennari (Agave). Senza particolare profondità ed emozione le prove di Spyros Chamilos e di Francesca Piccolo (il primo messaggero) e di Antonio Bandiera (il secondo messaggero). Debole appare invece il Penteo di Ivan Graziano: però, al di là della prova attorale, è la stessa concezione registica che lo presuppone debole. Dopo la scoperta del terribile omicidio di Penteo da parte della madre Agave, menade furiosa e leonessa selvaggia, il testo stesso di Euripide si avvia per bocca di Cadmo a delle considerazioni che se nell’antichità potevano avere un senso (“morirò senza discendenza maschile” etc.) oggi e in questo spettacolo – in questa rilettura - appaiono superflue e nulla aggiungono all’economia complessiva del lavoro.
Di tutt’altro tenore è lo spettacolo Baccanti che la compagnia catalana Fura dels Baus ha costruito a partire dal testo di Euripide, ritradotto per l’occasione da Guido Paduano. In scena a giorni alterni dal 4 al 30 luglio e dal 4 al 20 agosto. Se lo spettacolo di Livermore è profondamente politico e rivolto a una riflessione sulla storia contemporanea, questo Baccanti presenta una riflessione maggiormente rivolta al dato antropologico del nostro presente: chi è oggi Dionìso? Da dove nasce la sua forza inarrestabile? La risposta del regista Carlus Padrissa, leader in questo caso dell’ensemble catalano, si colloca evidentemente nel “femminile”, nella forza liberante e rivoluzionaria del femminile rispetto al potere maschile che ancora perdura nella violenza della sua prassi di sopraffazione: Dioniso diventa donna, diventa Dionisa e le baccanti, bellissime, energiche, selvagge finiscono con il caricarsi simbolicamente del peso di tutte le rivolte femminili e femministe che attraversano da sempre l’occidente e la sua storia e che nei nostri anni stanno giungendo, forse finalmente, ad una affermazione piena e definitiva della parità e della libertà delle donne. È legittimo costruire uno spettacolo di questo tipo a partire dal testo di Euripide? Assolutamente sì: come per Coefore/Eumenidi non vediamo Eschilo ma Livermore che si confronta con Eschilo, così qui non vediamo Euripide ma Padrissa che si confronta, da artista, con Euripide. Padrissa e l’intero immaginario artistico, consolidato e riconoscibilissimo, della Fura: la periferia urbana e degradata riempie tutta la scena con una gru che col suo braccio solleva in alto il coro delle Baccanti a formare (ed è una immagine di strepitosa intensità) un essere mobilissimo, vibrante, plurale e pluriforme che vuol essere il corpo mistico di Dionìso; i costumi delle baccanti/donne in rivolta dal potere maschile che ricollocano l’ancestrale clamore bacchico nel presente delle donne che si ribellano (nel Messico, ad esempio, due anni fa); un’enorme testa umana di reticolato metallico che accoglie aprendosi le baccanti a suggerire una dimensione immanente e mentale del dionisiaco (tutti e tutte siamo Bacco). Un'altra grande statua di reticolato metallico è situata sulla parte opposta della scena, rappresenta ancora la divinità in questione nella forma tradizionale e ambigua di uomo e toro insieme, ma la sua funzione appare pleonastica. Come sostanzialmente pleonastica appare la grande lavagna nera, semicircolare che copre metà dell’orchestra e riporta l’albero genealogico di Cadmo, Penteo e Dioniso. A dirla tutta è complessivamente tutta la scena che appare poco meditata e non convince soprattutto per gli spazi vuoti che, se permettono le energiche camminate di Dioniso, sembrano più effetto di poca conoscenza delle dimensioni della scena siracusana che consapevoli scelte artistiche. Cosa non convince ancora in questo percorso concettuale? Il fatto che viene sostanzialmente eliminato dalla costruzione dello spettacolo il dato del mistero oscuro, ambiguo e perciò stesso inquietante (perturbante) che circonda la religiosità dionisiaca ma soprattutto, anche in questo caso, non convince la rinuncia a confrontarsi (e a far confrontare il pubblico), anche criticamente, con il dato dell’irriducibile alterità del testo antico e della cultura che lo ha prodotto. È molto discutibile l’affermazione/assioma che “siamo tutti Bacco” e, se mettere in scena “Dionìsa” rende possibile una conseguente strategia di costruzione dello spettacolo, questa scelta semplifica la meravigliosa polisemia del testo Euripideo che certo può includere una riflessione sul percorso di liberazione delle donne ma, ad esempio, oggi potrebbe sollecitarci moltissimo sul rapporto tra desideri e vissuti personali e diritti pubblicamente sanciti o tra libertà personali ed esercizio del potere pubblico, tra religiosità e religione civile. Detto questo però è chiaro che parliamo di uno spettacolo comunque importante: interessante è il tentativo di riscrivere in scena la potenza disumana della presenza e dell’intervento di Bacco; straniante (e affascinante) è il clamore delle Baccanti, numerosissime e selvagge, che entrano in scena colpendo e afferrando da sopra e dalle spalle l’attenzione del pubblico; sicuramente notevole è la potenza con cui Dioniso (una Lucia Lavia in stato di grazia) attraversa la vicenda e con cui le corifee guidano quell’esercito femminile a al femminile (Simonetta Cartia, Elena Polic Greco e, con loro, Rosy Bonfiglio, Ilaria Genatiempo, Lorenzo Grilli, Cecilia Guzzardi, Doriana La Fauci, Viola Marietti, Katia Mirabella, Giulia Valentini a cui si aggiungono almeno una cinquantina di artisti del “coro sospeso” e del “coro dei cittadini”). Ovviamente se Lavia segna profondamente questo spettacolo con la sua energia, all’altezza appaiono (se non altro per la solidità del mestiere, anche quando si trovano a dover omaggiare in modo improbabile il genio di Franco Battiato) Stefano Santospago (Cadmo), Antonello Fassari (Tiresia), Linda Gennari (Agave). Senza particolare profondità ed emozione le prove di Spyros Chamilos e di Francesca Piccolo (il primo messaggero) e di Antonio Bandiera (il secondo messaggero). Debole appare invece il Penteo di Ivan Graziano: però, al di là della prova attorale, è la stessa concezione registica che lo presuppone debole. Dopo la scoperta del terribile omicidio di Penteo da parte della madre Agave, menade furiosa e leonessa selvaggia, il testo stesso di Euripide si avvia per bocca di Cadmo a delle considerazioni che se nell’antichità potevano avere un senso (“morirò senza discendenza maschile” etc.) oggi e in questo spettacolo – in questa rilettura - appaiono superflue e nulla aggiungono all’economia complessiva del lavoro.
Crediti fotografici: Luigi Carnera, Franca Centaro, Maria Pia Ballarino.