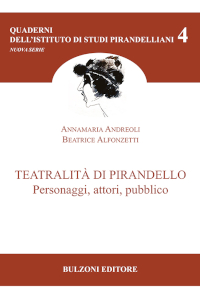I termini che a mio avviso si possono più coerentemente accostare alla attività e alla creatività teatrale di Arturo Cirillo mi paiono soprattutto due e reciprocamente illuminanti: Paradosso e Ossimoro. In effetti Arturo Cirillo nasce e si forma all'interno di un fiume della tradizione italiana che ha come suoi argini da una parte l'Accademia, nella forma di indirizzo ed educazione all'arte drammatica che nasce nel secondo dopoguerra, e dall'altra il teatro partenopeo che scavalca le due guerre mondiali per approdare ad Eduardo. Ma nonostante questo, o forse, paradossalmente appunto, proprio attraverso questo, è anche artista che sta dentro l'innovazione e la ricerca del nuovo teatro, a cui si è guadagnato, per intuizioni ed espressioni di scrittura scenica, il diritto ad appartenere. Un tradizionalista innovativo, dunque, o anche un innovatore tradizionale se vogliamo (e questo è l'ossimoro). Ed è proprio questa ultima frizione che, io credo, produce l'energia drammatica che, sia nell'aspetto della recitazione che in quello della regia e anche, ora, della drammaturgia, leggiamo nelle sue messe in scena, e non solo nelle ultime. Diplomatosi nel 1992 in recitazione all'Accademia nazionale di arte
drammatica Silvio d'Amico, presso la quale continua ad insegnare, ha avuto la capacità di articolare la sua sensibilità oltre i facili richiami al teatro più tradizionale ovvero a quello napoletano, cui peraltro non ha mai cessato di corporalmente, come dice lui stesso, più che linguisticamente appartenere, acquisendo man mano un respiro che lo avvicina ad esperienze di maggior richiamo, anche internazionale. L'utilizzo assai singolare che fa dell'elemento comico, della sintassi leggera del varietà e del travestitismo, per andare ad indagare i territori del sentimento e anche del dolore che spesso al sentimento si collega, sono man mano diventati la cifra sua propria, la cifra di un teatro di grande qualità. Peraltro questa evoluzione artistica ha preservato anche quella forza, quell'elettricità scenica, quello sguardo (dionisiaco ho pensato di definirlo) che della presenza e della recitazione di Cirillo è una sorta di DNA. Nel corso della rappresentazione ma anche dopo, nelle incursioni tra il pubblico che lo contraddistinguono e ce l'hanno fatto ancor più apprezzare. Lo incontro per questa intervista nei camerini del teatro Gustavo Modena di Genova, dove sta recitando la sua rivisitazione, molto personale e profonda, del “Cyrano de Bergerac” da Edmond Rostand.
MD Nelle tue più recenti prove mi sembra che l'intervento sui testi da parte tua si faccia più profondo, non solo dal punto di vista della regia ma anche da quello della drammaturgia. Penso ad esempio al “Cyrano” che stai portando in tournée. È una evoluzione che ti porta più vicino alla tradizione dell'attore/autore o a quella del dramaturg in senso più ampio?
AC Io forse mi metto più vicino al primo, l'attore/autore, nel senso che, teatralmente, faccio drammaturgia essendo soprattutto guidato dal mio essere attore. Infatti all'Accademia Silvio d'Amico ho fatto il corso di recitazione e non quello di regia. Tra l'altro il caso ha voluto che nella mia stessa classe ci fosse anche Emma Dante, anche lei iscritta al corso di recitazione e non a quello di regia. Dunque è a partire dal mio essere attore che imposto le regie e poi, nel suo complesso, maturo il mio teatro. Nel tempo dunque anche il mio fare drammaturgie è partito sempre dall'assunto di ciò che io, come attore, vorrei fare di quel testo. Divento cioè una sorta di referente teatrale di quella scrittura. Rispetto a quello che ho fatto, ad esempio, con il “Cyrano”, c'è innanzitutto l'intento di mantenere fortissimo il senso di una narrazione, perché credo che il teatro sia soprattutto raccontare storie. Quando questo manca in uno spettacolo allora io, in un certo modo, mi sento meno coinvolto. A me piace infatti raccontare delle vicende e, all'interno di queste, le evoluzioni dei personaggi. Con il “Cyrano” mi sono trovato di fronte a un testo di origine scritto molto bene ma che tuttavia era, io credo, un successo studiato un po' a tavolino e in questo anche un testo un po' convenzionale in certi suoi aspetti, in cui si mescolano tradizione, romantiscismo, giogionismo interpretativo con, tra l'altro, l'arte del fine dicitore un po' formale e retorica. A me invece interessava approfondire uno sguardo più personale, legato emotivamente alla sfera dei sentimenti, e quindi dal punto di vista della trascrizione drammaturgica mi sono un po' spostato e concentrato sull'aspetto che più mi attraeva, innanzitutto facendo una serie di tagli rispetto al testo originale. Così attraverso questi tagli ho potuto a questo fine sia reintegrare il testo di Rostand, sia inserire tutt'altro.
MD Al riguardo la tradizione del teatro napoletano da cui provieni è ricchissima di riferimenti e di esempi che hai avuto modo di attraversare ed anche implementare nel corso della tua ormai importante carriera. Questo ricchissimo universo, su cui ovviamente si impone il genio di Eduardo, può diventare per un attore o anche un autore/regista, oltre che uno stimolo, anche un ingombro talora?
AC Guarda, innanzitutto il mio rapporto con la tradizione è un rapporto molto, molto particolare, e già Franco Quadri mi definiva un “napoletano astratto”. Anche rispetto alla lingua, ad esempio, io il dialetto napoletano l'ho scoperto e ho cominciato a parlarlo solo a teatro. Quando ero piccolino, tra l'altro all'interno di un rapporto molto competitivo con mio padre che invece parlava molto bene il napoletano, l'ho sempre rifiutato. Io per la prima volta ho affrontato il dialetto teatralmente in un saggio all'Accademia, diretto da Davide Iodice, allora mio compagno del corso di regia, prova che era “Uscita di emergenza” di Manlio Santanelli. Quella è dunque stata la prima volta in cui, per così dire, ho toccato la drammaturgia napoletana. Con Carlo Cecchi ho quindi fatto “Sik Sik l'artefice magico” di Eduardo De Filippo e poi appunto, come mia seconda fortunata regia teatrale, la commedia di Edoardo Scarpetta “Mettiteve a fa' l'ammore cu me!”, che ho riproposto per quattro o cinque anni e in cui ho cercato di cogliere una mescolanza tra la tradizione e l'innovazione, tra Mejerchol'd e la biomeccanica. Dunque il mio rapporto con la tradizione è abbastanza complesso, un po' consapevole e un po' no. Innanzitutto è un rapporto che per così dire ho scoperto, come detto, da grande, per cui non appartiene tanto alla mia biografia, però appartiene al mio corpo, nel senso che, in particolare facendo il testo di Scarpetta, ho scoperto di avere quella tradizione nel mio corpo, pur non padroneggiando, linguisticamente, un napoletano proprio giustissimo e canonico, bensì, come diceva Quadri, un napoletano astratto. Quindi questo mio rapporto con la tradizione è di vicinanza ma allo stesso tempo di distanza e questo mi ha accompagnato nel mio percorso di messa in scena di varie cose napoletane, tra “Fatto di cronaca di Raffele Viviani a Scampia”, ovvero lo Scarpetta citato, ma soprattutto molti testi di Annibale Ruccello. In proposito io ho molto rappresentato e sono molto legato a Ruccello perchè, pur parlando e vivendo lui la lingua napoletana in maniera più immediata e molto meglio di me, ha delle caratteristiche in cui mi riconosco, soprattutto nel fatto che tutti e due pensiamo che la tradizione bisogna seguirla ma anche un po' tradirla, e anche se ha prodotto anni ricchissimi bisogna andare un po' oltre e altrove, ma soprattutto bisogna contaminarla. Io non credo che essere nel solco della tradizione, parlando dal punto di vista teatrale, voglia dire ricostruire oggi uno spettacolo quale era, nelle forme che storicamente aveva assunto ad esempio nelle rappresentazioni dell'800 al Sancarluccio di Napoli, anche perchè in realtà nessuno può sapere come effettivamente allora si recitava, bensì è anche e soprattutto inventare. È un inventare a partire da quel substrato quasi fisico, almeno per quanto mi riguarda, e non tanto e non solo restare dentro a quell'orizzonte ma anche metterlo un po' in crisi. In questo l'attività di Carlo Cecchi è emblematica perchè in fondo lui è stato capace di mettere insieme Eduardo De Filippo con il Living Theatre, due esperienze che all'apparenza sono lontanissime ma che forse in realtà non sono proprio così lontanissime. La tradizione è dunque qualcosa verso cui inevitabilmente vado ma da cui sento, in qualche modo, anche il bisogno di fuggire.
MD Al di là della voluta precedente provocazione, mi sembra che il tuo teatro, sia nelle forme della recitazione che nelle strutture della messa in scena, sia diventato capace di distillare le corrispondenze e le suggestioni che ti vengono dal mondo che ti ha formato, trafigurandole in un approccio che è molto singolare e nuovo. Condividi questa mia impressione?
AC In effetti io ho cominciato a calcare il palcoscenico non tanto per fare un teatro di prosa quanto per fare saggi di danza. Così, prima di addentrarmi nel teatro di parola, io, con una mia amica danzatrice che ha iniziato a Wuppertal con Pina Bausch per poi passare al Kuber Ballet di Stoccolma, ho fatto tre spettacoli di teatro-danza. Per questo ho parlato, a proposito della tradizione e del dialetto, del corpo, in quanto io do interesse al teatro di parola e insieme do altrettanta importanza ad una comunicazione fisico-gestuale che per me è fondamentale.
MD Vedendo e apprezzando il tuo “Cyrano”, ma anche il precedente “Orgoglio e Pregiudizio”, ad esempio, ho scritto che usi il linguaggio e la sintassi del Varietà, come Fassbinder usava quelli del Melodramma, cioè per far emergere il sentimento, quel sentimento la cui forza spesso ci imbarazza ma la cui mancanza ci impoverisce inesorabilmente. È il 'riso' che ci fa umani, come scrivono molti filosofi?
AC Innanzitutto io credo in una comicità in cui si ride “su” qualcuno e non “con” qualcuno, nel senso che ho un po' come modello una comicità che sia 'cattiva'. Una comicità cioè che sia più alla Totò che alla Salemme, per esempio. In realtà credo che la comicità sia al suo fondo sempre un atto anche molto crudele che il pubblico in quel momento 'attua' sull'attore comico, e dunque sia fondamentalmente una espressione molto tragica. Per questo penso non solo a Totò ma anche Buster Keaton tra gli altri. Ovvero mi rifaccio al Molière che non essendo riuscito, come voleva, a fare il tragico si è trasfigurato nella commedia. Per me dunque comico e tragico non sono due orizzonti che viaggiano su due binari separati, ma al contrario sono profondamente legati. Così, nella mia percezione, dentro ad ogni risata del pubblico c'è per certi versi un dolore dell'attore comico. Per questo nel “Cyrano” c'è tutta una apparenza divertita, leggera, di intrattenimento. Ma è appunto una apparenza, anche se ci può essere quello spettatore che dice: mi sono divertito, punto. Per me è una lettura del tutto limitata dello spettacolo e certamente, se tutti avessero questa reazione, io mi porrei delle domande. Invece molta parte del pubblico si lascia maggiormente coinvolgere e un po' alla volta, secondo quanto mi esplicita, trova la rappresentazione appunto molto toccante, commovente. Per me questa cosa può accadere proprio facendo all'inizio tutt'altro, e facendo tutt'altro, come hai detto tu, arrivare ad esprimere i sentimenti. E tutto questo costa comunque fatica e per me, soprattutto in principio, era molto importante per questa finalità raggiungere una forte caratterizzazione del personaggio. Ora forse ne sento meno il bisogno, però da questo, parlando in via generale, è nato un mio stile, è nato un codice dello spettacolo teatrale che lo fa iniziare molto più leggero rispetto a quello che effettivamente è, in rapporto a quello che stiamo mettendo in moto internamente, così da indurre lo spettatore a lasciarsi andare e, ormai senza tante difese, a scoprire infine, verso il quarto o quinto, atto, il sentimento; per cadere dentro, appunto, al sentimento, ai sentimenti sottostanti e spesso più dolorosi.
MD È un processo, una preparazione di cui, mi sembra, anche il pubblico ha bisogno proprio per la difficoltà che c'è oggi di entrare in contatto con il sentimento. In “Cyrano” infatti ciò che sembra apparentemente entrare in gioco è l'amore romantico tra lui e lei che però porta con sé anche altro, porta con sé anche il dolore.
AC Un dolore che per me nasce dal fallimento, fondamentalmente. Infatti, in un parallelismo che io sento tra il personaggio Cyrano e la figura storica che ha ispirato Rostand, quello che emerge è appunto, secondo la mia interpretazione, la storia di un fallito di successo. Cyrano de Bergerac è un fallito, o tale si sente, e così questo fallimento si trasferisce sul personaggio teatrale. Bergerac tenta la via del teatro ma Molière gli porta via addirittura una scena. Cerca di conquistare il successo letterario con romanzi fantastici come quello di un suo fantasmagorico viaggio sulla luna, ma anche lì non riesce. Allo stesso modo, in commedia, cerca di conquistare la cugina attraverso questa strana liaison, un po' Faust e un po' Mefistofele, con l'amico Cristiano, facendosi suo suggeritore e ad esso tentando di sovrapporsi, ma alla fine non ottiene nulla.
MD In questo però io non sono del tutto d'accordo con te in quanto Cyrano può essere un fallito rispetto ai parametri di successo che la Società, anche quella contemporanea, ci propone, parametri che riguardano soprattutto la quantità di cose che si sono ottenute dalla vita (denaro, donne e successo in primis). In realtà però Cyrano in scena, a mio avviso, è un uomo che si realizza intimamente e pienamente attraverso la narrazione di sé, è un uomo pieno al di là della figura che lo ha ispirato, e alla fine, nella storia che Rostand elabora e che l'attore racconta sul palcoscenico, la cugina si accorge che è lei ad aver sbagliato.
AC Questo è vero ma nel contempo Cyrano pensa che quell'amore non sia rivolto a lui ma alle sue parole (quelle parole al cui Sole si scioglie la sua bruttezza, che però è un Sole che non esiste nella realtà ma solo nella finzione) e che lui, come persona, in realtà non sia mai stato amato, anzi addirittura continua a considerarsi non degno di essere amato.
MD Appunto, ciò esprime quella linea di malinconia che percorre la nostra intera vita di esseri umani complessi, soprattutto perchè per molti aspetti siamo tutti dei 'falliti', inevitabilmente quasi, per quanto non abbiamo potuto essere e per come non siamo stati interamente capiti.
AC Infatti se Rostand non ne avesse recuperato, duecento anni dopo, la sua storia, di Cyrano de Bergerac non sapremmo nulla. Il drammaturgo in un certo senso, volendo anche parlare di sé attraverso lui, lo ha recuperato dalla sua morte, sconfiggendo l'oblio che quello che nella vita aveva fatto, il “suggeritore” di altri, gli aveva meritato.
MD Maschera che svela e travestimento che ribalta i ruoli consueti. Tu ne fai un uso ripetuto e molto figurativo, di finzione che porta con sé il vero, come nel teatro elisabettiano o nella Commedia dell'Arte, tale da sfuggire ad ogni più trito clichè. Cerchi in questo l'anima antica o quella futura del Teatro e dell'Attore?
AC La mia idea del ruolo “en travesti” nasce innanzitutto dalla messa in scena del personaggio della “zia Lavinia” ne “L'ereditiera” di Annibale Ruccello, che portai al teatro della Tosse, ispirata al famoso personaggio di Henry James in “Washington Square”, e, lavorando molto sull'originale di James, lì ho cercato di sentirmi intimamente “zia”. D'altra parte di un certo tipo di teatro en travesti in genere diffido, perchè spesso è molto esteriore e anche parodistico, mentre per quanto mi riguarda si tratta di andare a scavare dentro un lato femminile che mi appartiene. Ma anche riferendoci ad un altro attore che dirigo, penso ad esempio a Rosario Giglio ne “Le intellettuali” di Molière, non si tratta tanto di impostare superficialmente una recitazione “en travesti”, quanto piuttosto di 'vedere' e 'far vedere' un attore di sesso maschile che interpreta un personaggio di sesso femminile. Cioè io cerco per certi versi di entrare drammaturgicamente, quanto più possibile, dentro quel tipo di femminilità che sto interpretando. Anche quando io ho fatto le “Cinque rose di Jennifer”, che è stato al teatro della Tosse di Genova, ho molto lavorato sull'idea di un uomo che è fondamentalmente un uomo, e infatti non ho calcato sul travestimento facendo ad esempio la 'ceretta' alle gambe, a differenza di “Scendendo giù da Toledo” dove invece l'ho fatta. Questo in quanto il testo rappresenta quello che è il grande dramma di Jennifer, il dramma che alla fine lo condurrà al suidicio, cioè la schizofrenia di un uomo, assolutamente maschile, che però si sente profondamente donna. Infatti le didascalie sceniche scritte da Ruccello indicano un ambiente che deve far pensare a una persona che si sente 'morbosamente' donna. Quindi per me travestitismo e travestimento non sono mai state cose puramente fini a se stesse, bensì sono una modalità teatrale per indagare il lato femminile di me, che forse preferisco a quello maschile ad esempio. Io credo che questo lato, infatti, sia in un certo senso più profondo e illuminante, per cui inviterei gli attori a frequentare più spesso questo loro lato femminile, un lato che è in tutti noi. Del resto è un elemento che emerge anche nell'interpretazione che ho fatto di personaggi maschili, come ad esempio George di “Chi ha paura di Virginia Woolf” che è fondamentalmente passivo, che subisce molto, mentre, in fondo, l'elemento maschile è in realtà rappresentato da Martha. Proprio per questo è stato molto interessante interpretarlo.
MD Un'ultima domanda. Quali sono, se vuoi e puoi dirlo, i tuoi progetti teatrali per la prossima stagione? In sostanza cosa ti aspetti, e cosa dobbiamo aspettarci noi, dal tuo futuro?
AC In verità non te lo posso ancora dire perché ancora sto cercando. Intanto, dopo questo spettacolo, riprendo a fine stagione un monologo da Alan Bennet che si intitola “Il gioco del panino” già fatto per la rassegna “Trend” di Rodolfo di Giammarco, che mi ha suggerito ed invitato ad affrontare questo personaggio. È uno spettacolo molto interessante perché in sostanza questo monologo fa parlare un pedofilo. Però Bennet affronta l'argomento innanzitutto senza mai citare i termini pedofilia o pedofilo e poi lo affronta in un modo che io sento molto umano, cioè senza giustificare la pedofilia ma portando il pubblico a pensare che anche quello è un suo possibile fratello, che anche quella è una possibilità che può riguardare un essere umano. Un modo indubbiamente molto 'deviato', preceduto e seguito da fortissimi problemi psicologici, ma comunque una possibile propensione dell'essere umano. E poi riprenderò “Ferdinando” testo considerato da molti il capolavoro di Annibale Ruccello che ho già fatto, ma non a Genova, e che è un testo che io amo molto; un testo reso famoso tra l'altro da Isa Danieli che lo ha portato in scena per molti anni. È una mia regia di otto anni fa, in cui ovviamente ci sarà qualche cambiamento, soprattutto sul piano interpretativo. Mi fa molto piacere tornare, dopo “Cyrano”, a lui perchè Ruccello e Molière sono autori in fondo quasi fraterni per me.
MD Fa molto piacere anche a me sapere che tornerai ad un testo di Annibale Ruccello, che è un autore che io amo molto nelle tue interpretazioni. In proposito hai mai pensato a “Anna Cappelli” sia come regista che come attore?
AC Al momento non ho in programma altro, oltre al monologo e a “Ferdinando”. Però, come forse saprai, io insegno al terzo anno del corso di regia alla Accademia Silvio D'Amico di Roma e per la consueta esercitazione di fine anno faremo tre testi di Annibale Ruccello, e uno di questi è appunto “Anna Cappelli”, con l'interpretazione di Benedetta Buccellato, ora anche lei docente all'Accademia, che all'epoca ne è stata la prima interprete. Per tornare a me, mi è difficile al momento pensare ad un altro spettacolo così complesso, a un testo così drammaturgicamente articolato dopo “Cyrano”, che è stata una esperienza anche personalmente molto profonda e nel quale è più evidente un approccio autoriale. È un momento, dunque, in cui non so molto bene che cosa farò.
Si avvicina il momento dello spettacolo e dunque mi accomiato da Arturo Cirillo ringraziandolo per la disponibilità. È un arrivederci, spero e credo, in attesa di altre occasioni nelle quale poter approfondire un percorso artistico per me di grande interesse e arricchimento. Un ringraziamento sincero all'Ufficio Stampa del Teatro Nazionale di Genova e a quello di Marche Teatro che hanno facilitato e reso possibile l'intervista.