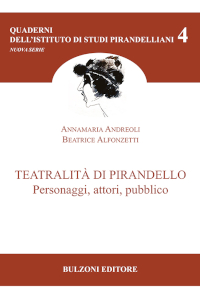San Ginesio, il borgo marchigiano che lo ospita, e il suo festival, giunto alla sua quinta edizione, sono un po' anch'essi una metafora del Teatro poiché tutti e tre sembrano dover e voler ricostruire se stessi dalle macerie che storicamente e
periodicamente minano le fondamenta della o delle Comunità che li abitano.
Ma, al fondo, c'è anche un altro aspetto simbolico comune alla loro intima natura, il fatto che luoghi dello spazio, del tempo e della mente come quelli di cui scriviamo, così umanamente e spiritualmente accoglienti per loro stessa profonda essenza, siano proprio quelli più spesso chiamati a doverlo e a volerlo fare.
Da una parte il borgo citato tra i dieci più belli di Italia, piccola gemma della provincia di Macerata, che ha subito profonde le ferite del terremoto del 2016, detto appunto del Centro Italia (dunque in fondo il suo Cuore stesso), rischiando poi di essere dimenticato se non fosse stata la testardaggine dei suoi abitanti a non voler abbandonare una bellezza altrove non 'ricostruibile'.
Già, la cosiddetta “Ricostruzione” che attraversa come una 'promessa' spesso disattesa tutti gli eventi tragicamente naturali che interessano il nostro paese e di cui si possono vedere i segni ancora incompiuti nelle tante transenne e nei tanti ponteggi che segnano San Ginesio ma che riescono a malapena a confonderne il fascino.
Incastonato in un territorio dalle molte radici naturali che si sono fatte, con il tempo sin dalla più lontana antichità, storiche e poi sociali e infine artistiche, a partire dal comprensorio dei Monti Sibillini, con l'antro della Sibilla crollato e scomparso, con affaccio sul Gran Sasso (ricordando l'altro grande e tragico terremoto de L'Aquila) e sulle spesso dimenticate più alte vette dell'Appennino, con la sua Natura viva, abitata e creativa che è quanto di più lontano dalla fredda esibizione in una 'turistica' bacheca.
E dentro questo orizzonte il segno di una spiritualità antica, segnata anche da lasciti ante cristiani, che l'Abbazia Cistercense immersa in una riserva naturale custodisce insieme a molti altri luoghi che quell'afflato trasfigurano nel respiro dell'arte.
Dall'altra il Teatro che sembra ancora doversi pienamente riscuotere dalla 'depressione' e dalla 'instabilità' dell'era COVID e che qui trova condivisione di stimoli irriducibili e di nuovi appassionanti progetti.
Perché, nonostante tutto e nonostante la nostra cecità, come scrive Lawrence Ferlinghetti citato a esergo dal Direttore Artistico Leonardo Lidi che ha scelto come tema, così inquietante ma così attuale, dell'Edizione 2024 “La solitudine”:
“Tra gli alberi si sentono / i violini dell'autunno / mentre i cavalli bianchi del mare / si lanciano ancora sulle nostre spiagge / con un ruggito immenso e perduto.”
Del resto, e qui chiudo con le corrispondenze, Ginesio, un guitto imperiale tra III e IV secolo D.C. che secondo la leggenda si convertì nel corso di una parodia del Battesimo e per questo subì il martirio, è tra l'altro il patrono degli attori, e per questo anche quest'anno il festival si è chiuso con la consegna dell'omonimo premio “All'Arte dell'Attore”, da parte della giuria presieduta da Remo Girone che lo ha ideato, a Vanessa Scalera e Giuseppe Battiston.
Prima di questo epilogo la Rassegna, ideata da Isabella Parrucci e diretta dal citato Leonardo Lidi e arricchita da una Sezione Infanzia e Adolescenza e da laboratori per giovani attori, ha presentato dal 18 al 25 Agosto una serie selezionata di spettacoli di cui, limitatamente al periodo 20-22 Agosto che mi ha visto ospite, dò un breve racconto.
ANNA CAPPELLI – 20 Agosto
A proposito di 'solitudine' questo apparentemente disturbante ma intimamente attraente testo del compianto Annibale Ruccello, uno dei suoi più nascosti e difficili, ci mostra come spesso la solitudine sia piena di figure che la riempiono ma non la saziano in quanto prive di umanità ma soprattutto di affettività, siano genitori 'assenti' o “molesti”, amici 'inesistenti', vicini 'riottosi' o compagni di vita che abortiscono ogni soffio di 'condivisione'. La narrazione di Ruccello, che è superfluo ripercorrere, è di una paradossale semplicità e di una straordinaria 'linearità', non fosse che per il tragicamente grottesco epilogo antropofagico. La sua scrittura drammaturgica può farsi così, nell'interpretazione registica ed in quella attoriale, sorta di tela di parole in cui filtrare attraverso il personaggio la propria singolare esistenza: quella del drammaturgo, quella del regista, quella dell'attrice e quella di ognuno di noi, ciascuna diversa ma sempre coerente e reciprocamente perspicua. L'effetto mimetico e specularmente moltiplicativo che il testo custodisce nelle sue mille stratificazioni, e che alcune messe in scena hanno voluto esplicitare nello sdoppiamento del personaggio, qui si realizza invece, in una strana magia, nei mille riflessi che il caleodoscopio della platea offre alle improvvise e abbaglianti sollecitazioni del testo stesso. In un certo senso è proprio la distanza (estetica, culturale ed anche esistenziale) tra il bravo metteur en scène del momento, l'argentino Claudio Tolcachir, e il creativo humus, un umore di cui percepiamo quasi la fragranza, approntato dal napoletano Annibale Ruccello che paradossalmente favorisce una più libera esegesi della drammaturgia, che trova proprio nella minore implicazione lo strumento di una maggiore comprensione con soluzioni che ne illuminano meglio la sottintesa significanza. D'altra parte in scena, ben guidata dalla regia ma che insieme ne suggerisce e guida i movimenti, c'è una intensa di umori (appunto) e bravissima Valentina Picello, quasi intrisa di una commozione, mai auto-commiserante, capace di farsi 'compassione' e 'perdono' ed in essi di irresistibilmente trascinarci. Una presenza scenica profondamente fisica, un corpo che si fa materia consapevolmente attraversata e fin resa tremante e 'tremula' dal sentimento che riesce con efficacia ad intercettare nelle stesse parole, addolorate e capaci di dare dolore, che sopporta. Il tutto dentro una scenografia che è una sorta spiaggia su cui la risacca della tempesta ha scaricato i suoi rifiuti, ovvero un luogo di raccolta di ciò che la vita ha ormai 'lasciato andare'. Una capacità di osmosi che la Picello ha ulteriormente dimostrato quando ha dovuto, per la pioggia, rapidamente riorganizzare lo spettacolo con l'aiuto di bravi tecnici, previsto nella corte, per effettuarlo al chiuso e in uno spazio più piccolo, con un risultato che ha comunque pienamente valorizzato la messa in scena in ogni suo aspetto. Un esempio di quando testo, regia e recitazione di qualità riescono a costruire un teatro di grande presa, che il pubblico da tutto esaurito proveniente anche da lontano ha voluto e potuto vivere intensamente. Moltissimi gli applausi.
“Anna Cappelli” di Annibale Ruccello, regia Claudio Tolcachir, con Valentina Picello. Produzione Carnezzeria / Teatri di Bari / Teatro di Roma, in collaborazione con AMAT & Teatri di Pesaro per RAM.
 VORREI UNA VOCE – 21 Agosto
VORREI UNA VOCE – 21 Agosto
Lo spettacolo nasce dall'esperienza vissuta da Tindaro Granata nei suoi Laboratori per detenute/attrici del Teatro Piccolo Shakespeare del carcere di Messina ed è il frutto di quella che considero una straordinaria intuizione, non solo estetica, capace di trasformarsi in suggestione profondamente teatrale. L'intuizione cioè di utilizzare le canzoni di Mina, in particolare alcune di quelle del suo ultimo lontano concerto, per aprire una sorta di zona smilitarizzata tra lui e le detenute, un luogo comune in cui poter far dialogare estroversamente l'introversa intimità, dal difficile linguaggio e dalle poche possibilità di essere ascoltata, non solo delle detenute ma anche del drammaturgo e attraverso di questo di tutti noi. L'intuizione costruisce lo spettacolo e la suggestione ce lo consegna intatto e, per così dire nuovamente vergine, ad ogni suo transito scenico. Le canzoni della grande cantante, che oltre alle grandi potenzialità tecniche possedeva ed esprimeva una altrettanto straordinaria e inusuale affettività, sono dunque usate dapprima come sonde per penetrare quella introversione e poi come esche per portarla alla luce del dialogo e della condivisione. Così non è tanto importante quello che la storia di ciascuno, felice o infelice, tragica o comica, che guarda al passato o pensa il futuro, ci e si racconta, quanto il fatto di poterlo finalmente dire agganciando come in un grande puzzle la nostra tessera a quella sconosciuta ma finalmente coerente che ci transita accanto. Per far questo paradossalmente Tindaro Granata utilizza a suo modo e trasforma una modalità sintattica della solitudine oggi molto di moda, quella del cantare in playback, simile per certi versi al popolare Caraoke, modalità straordinaria nel suo rappresentare appunto la solitudine tra i molti. Ma la forza affettiva e di empatia, di cui la scrittura di Tindaro Granata, anche nel suo riferimento a Mina, si fa carico, porta lo spettacolo molto oltre, sia dentro di sé che fuori di sé con gli altri, e ora con gli spettatori. Lo stesso disagio, talora disturbante, che la narrazione, anche sfumando delicatamente nella autobiografia, supporta e sopporta si trasfigura liricamente e così Tindaro Granata non è più solo tra i molti/e ma è uno dei molti/e che si incamminano attraverso il palcoscenico e la platea. Pur nella sua apparenza un po' 'pop', nel senso migliore del termine come una canzone di Mina, non è uno spettacolo facile nella sua ricezione né tanto meno semplice nella sua elaborazione ma possiede, io credo, un lievito insuperabile che è quello della affettività e dell'empatia che emana sulle sue ali oniriche, una affettività che produce anche nella sua dimensione scenica, come penso in quella del laboratorio, un raro, umano calore. Anch'esso molto applaudito e sold aut.
“Vorrei una voce” di e con Tindaro Granata, con le canzoni di Mina. Ispirato dall’incontro con le detenute-attrici del teatro Piccolo Shakespeare all’interno della Casa Circondariale di Messina, nell’ambito del progetto “Il Teatro per Sognare” di D’aRteventi, diretto da Daniela Ursino. Disegno luci Luigi Biondi. Costumi Aurora Damanti. Regista assistente Alessandro Bandini Produzione LAC Lugano Arte e Cultura in collaborazione con Proxima Res. Partner di produzione Gruppo Ospedaliero Moncucco.
 ME VOJO SARVA' / NESSUNO CI GUARDA – 22 Agosto
ME VOJO SARVA' / NESSUNO CI GUARDA – 22 Agosto
La maschera è parte essenziale del Teatro, e dunque anche della vita. Serve in entrambi a dissimulare e nascondere, come la porta della nostra solitudine spesso eterodiretta e introiettata, ma anche, come aveva intuito Luigi Pirandello, a dis-velare o anche a ri-velare, nella suggestionante ambiguità che quest'ultimo termine custodisce e che del Teatro è potente e irriducibile meccanismo sin dai tempi della aristotelica mimesi. La brava Eleonora Danco, sia nella cura della parola oltre l'apparente dialettismo che del vernacolo romanesco è maschera ri-velatrice, che nella recitazione spontanea ma sempre ben guidata e controllata dalla superiore 'ragione' scenica, con questo suo spettacolo, costituito in doppio e speculare monologo, intercetta appunto maschere. Ma non lo fa per copiarle, portandone in scena immagini di banalità, bensì per coartarle e quasi costringerle a farsi integralmente quello che solo fingono, per stanchezza o anche decenza sociale, di essere. Sono maschere immerse, e quasi annegate, in un flusso joyciano di coscienza opportunamente trasfigurato (ormai siamo in una Società che da liquida tende a farsi liquefatta) per farsi limpida immagine del nostro tragico e narcisistico voyeurismo. Non certo privo di ironia, peraltro mai fino in fondo cattiva, è però la comicità lo strumento che Eleonora Danco utilizza per spiccare il volo, per cercare di liberarsi/ci dalle catene dell'ovvio e del consueto, ribaltate entrambe in commovente, ma condivisa, sorpresa. I due monologhi, pur in fondo diversi per sintassi e finalità scenica, ben si amalgamano in questa figura recitante aggrappata ad un leggio come un naufrago alla sua zattera, anche per la capacità di continuamente evolversi e trasformarsi non avendo quale sua altra forma, come tutto ciò che è liquido, se non quella del suo contenitore. Va detto che lo spettacolo ha paradossalmente suscitato nella critica reazioni opposte. Ma è proprio quando uno spettacolo fa discutere che possiamo pensare che è successo qualcosa sul palcoscenico e che, questo qualcosa, ci è entrato dentro e fa riflettere. Io condivido fino in fondo l'apprezzamento mostrato dal numeroso pubblico che ha molto applaudito.
“Me vojo sarva’- Nessuno ci guarda” di Eleonora Danco, disegno luci e regia Eleonora Danco; musiche scelte da Marco Tecce, costumi Marisa Di Mario, produzione La Fabbrica dell'Attore - Teatro Vascello.