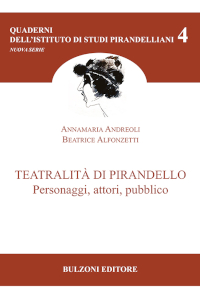Sebbene il nome di Schiller sia legato all’ universale “Inno alla gioia” musicato da Beethoven per il finale della Nona sinfonia e sebbene questa composizione venga sovente contrapposta all’aria del Don Giovanni di Mozart (per una diversa e individualistica aspirazione alla libertà), tuttavia è alle “Nozze di Figaro” che mi accade, invece, irresistibilmente, di pensare in alternativa, per riflesso condizionato. Perchè dovendo ipotizzare un raffronto di Schiller (e non di Behetoven) con Mozart, che possa essere immediatamente esplicito sull’ origine di un anelito antioppressivo così meravigliosamente condiviso, la visione che prende corpo è quella del paggio Cherubino.
Johann Christoph Friedrich Schiller era infatti un giovanottino pieno di poesia e di gioia di vivere, quando venne reclutato a 14 anni dal supponente e retrivo duca Carlo Eugenio di Baden-Wuttemberg presso l’Accademia militare alla Solitude (!) di Stoccarda e costretto a diventare medico militare come suo padre, invece che teologo o filosofo o poeta come sognava. Una disciplina durissima che, in modo diverso, il piccolo Mozart doveva aver sperimentato.
“I masnadieri” è il primo lavoro drammatico di un diciassettenne intelligentissimo e assetato di libertà , il cui destino iniziale sembrava perversamente segnato (come per Cherubino) da uno dei molti conti d’Almaviva” di fine Settecento, gelosi oppressori di una nuova giovane classe emergente, colta e consapevole:
“Addio,
piccolo Cherubino!
Come cangia in un punto il tuo destino.
Non più andrai ()
notte e giorno d’intorno girando
……………………………….
Non più ai avrai questi bei pennacchini,
quel cappello leggero e galante …
……………………………….
Tra guerrieri, poffar Bacco
gran mustacchi stretto sacco,
schioppo in spalla, sciabla al fianco…”.
Alla Karlsschule Schiller ebbe, se non altro, l’opportunità di fare esperienze artistiche a lui congeniali appassionandosi allo stesso Shakespeare che, sull’onda degli studi critici di Lessing e Schegel, andava entusiasmendo in quell’epoca le nuove generazioni di poeti, dallo sturm und drang al romanticismo pieno. Viceversa, l’antinaturalismo della tragedia francese che imperversava nel repertorio della scuola ducale, non favorì Schiller nella plasticità del portamento e nella correttezza della dizione, viziata dal dialetto svevo. La cosa non gli impedì di diventare uno dei più eminenti autori drammatici di tutti i tempi e il più affabile e lungimirante dramaturg della sua epoca, famoso per saper trasmettere agli attori il suo entusiasmo e la sua fantasia. Quando, nel 1797 Goethe lo volle con sé a Weimar, comprendendo fino in fondo i suoi bisogni estetici e filosofici, seppe trovare per un così raro amico queste argomentazioni: “Tra colui che deve comandare e colui che deve dare a un siffatto istituto una guida estetica vi è una enorme differenza. Questo deve operare sull’animo e deve quindi mostrare anche animo, quello si deve invece chiudere, per tenere unite la forma politica e quella economica”. Per Schiller si era molto appropriatamente configurato un ruolo di stimolo spirituale e di guida estetica degli attori, “egli badava più all’esperienza viva e all’intima comprensione dei personaggi, mentre Gothe era occupato con l’esteriore apparenza della vita “.
Nel 1784, nel saggio “Il teatro come istituzione morale” la sua estetica aveva assegnato al teatro il compito di fornire la coscienza critica dell’epoca, trattandosi della forma più alta di espressione artistica e della più evidente manifestazione dell’essenza mediatrice dell’arte, tra intelletto e sensibilità. Aveva dato corpo qui ad una nozione che lo avvicinava a Kant: quel concetto di “gioco” che rappresenta per Schiller un libero esercizio riguardante lo spontaneo accordarsi delle facoltà conoscitive, rispetto a qualcosa che è adeguata ad essere compresa dalla mente umana. Per Kant si trattava di una funzione puramente estetica che valeva solo per la bellezza, o l’apparenza, non per la morale, mentre per Schiller è una distinzione inutile, poiché se il gioco attesta il dispiegamento della personalità in una più profonda armonia di tutti gli elementi che la compongono, l’apparenza esprime ciò a cui siamo destinati, qualcosa di sperimentabile. Esiste poi un’esperienza in cui le esperienze estetica e morale si identificano e ciò accade quando l’imperativo etico scaturisce da sé e il dovere coincide con il piacere. Abbiamo allora a che fare con “un’anima bella”, ma è una condizione armonica passibile di educazione e si può raggiungere per mezzo di un progressivo affinamento dello spirito. Siamo nel campo dell’educazione estetica, che diventa così propedeutica all’educazione alla libertà. Schiller sa che esiste una modalità di scaturigine della complessità, che attraversa i secoli e si ripropone a distanza, come a voler suggerire una forma, quasi si trattasse del ritrovamento di un dagherrotipo domestico un po’ sgualcito e premonitore: un’ immagine antica dove la contemporaneità viva, abitata dalle nostre attitudini emergenti è già riconoscibile nella lontananza color seppia di certe fattezze e pose familiari… A possedere una simile capacità prospettica, atemporale e nitida, sono le grandi opere di genio, spesso drammatiche. La natura del Teatro ama affondare i suoi scandagli negli spazi non ancora codificati dei sistemi culturali in evoluzione: la drammaturgia possiede la vocazione a carpire il senso delle contraddizioni nel momento stesso del loro insediarsi nel tessuto sociale, sovente attraverso l’evasività dell’interdetto, e ad esplicitarne l’effettivo significato magari dissolvendone la conflittualità verso una crescita collettiva. Ne “I masnadieri”, per l’appunto, si annida il germe di una frattura epocale che non smette di tornare a deflagrare a intermittenza, da due o tre secoli circa. A colpire immediatamente è l’analogia della visione schilleriana con l’erompere a noi contemporaneo di una disperazione giovanile a cui futuro sembra negato (come allora in Germania e poco dopo in Francia), dal declino del potere patriarcale illuminato, verso un destino di replicanza e oscurantismo. Sviluppo fatale, allorché l’ energia di chi ha la facoltà di governo smette di evolversi su posizioni di ascolto verso il nuovo che avanza e si concentra sterilmente su sé stessa, lungo un’ involuzione incapace di rigenerarsi se non in negativo. Passaggi storici sempre scanditi, nel loro riproporsi, da varianti epocali delle forme del capitale, che nell’acuire le pretese dei dominanti esasperano l’anelito alla libertà dei dominati e ne alterano la disperazione in violenza.
E’ la genesi di questa mutazione che occupa esattamente il cuore de “I masnadieri”. Le modalità di avvicinamento e di ribellione delle forze in campo sembrano essere le stesse di oggi: Illuministi versus masnadieri, sessantottini versus brigate rosse, indignados versus black bloc? Se è riduttivo e semplicistico accennare alla questione tanto sommariamente, è innegabile che la suggestione esiste, perché i sentimenti che Schiller ci propone rivelano modalità pulsionali del tutto plausibili dopo circa duecentotrentanni, due rivoluzioni, due guerre mondiali, alcuni totalitarismi…. Arrivati qui è più facile concepire con maggior empatia la furia dei figli, la rabbia degli esclusi, lo struggimento dei padri amorevoli sopravvissuti e lo sgomento di quelli inflessibili pentiti.
Tutta la favola dei “Masnadieri” tratta, in fondo, dello smascheramento progressivo di una struttura di potere in via di degrado, regressiva e repressiva, e tuttavia replicatesi con identica criticità nelle nuove generazioni. Non resta che affrontare il testo.
Il conte Maximilian von Moor di Franconia è un padre anziano che, come Lear, attraversa un momento di declino emotivo e fisico e sta perdendo il suo antico vigore. Ha avuto due figli nei confronti dei quali si è comportato con leggerezza e parzialità, indulgendo nel compiacersi per la bellezza e l’esuberante giovialità di Karl, mentre al secondo, Franz, bruttino e poco amabile, non ha avuto il tatto di risparmiare distratte e ripetute mortificazioni. Il figlio amato è lontano da tempo, apparentemente perso in una vita da rampollo scapestrato e ribelle, più conforme al repertorio di un giovanotto narcisista e viziato che a quello di un effettivo dissoluto. Intanto che questa lontananza comincia a suscitare in Karl una grande nostalgia dei suoi affetti e un senso di inutilità, per quella vita condotta in compagnia di giovanotti non sempre raccomandabili, per non dire ribaldi, Franz ne approfitta per simulare dapprima una grave colpa da attribuirgli, in modo da persuadere il padre a punire il suo beniamino per il tramite di una dura lettera. Lo stesso Franz otterrà di incaricarsi di scriverla, fingendo di voler rendere il compito meno gravoso all’anziano conte, ma cercando nei fatti di allontanare definitivamente suo fratello con l’inganno. In seguito darà anche ad intendere a tutti che Karl è morto, combattendo da eroe, riproponendosi tre obiettivi: gestire il potere in via delegata, circuendo suo padre e occupandosi personalmente dei contatti con il fratello lontano, così da manipolare a suo piacimento la situazione; far morire lentamente il vecchio conte, gravandolo ripetutamente di sensi di colpa; infine, irretire Amalia, l’ aristocratica fanciulla legata a Karl ma del tutto inarrivabile per l’irrilevante portata umana del fratello minore e difficilmente raggirabile di suo. Karl, in attesa di una lettera di invito a tornare da parte del padre, al quale ha inviato un messaggio pieno di affetto e nostalgia prontamente intercettato da Franz, si vede pervenire un’odiosa missiva, gelida e intimidatoria, che lo maledice e disereda. Lo spazio riservato al Louvre al quadro di Jean Baptiste Greuze datato 1777 e intitolato “La maledizione paterna”, la dice lunga sul senso di un avvenimento simile negli anni in cui Schiller scrive i Masnadieri: non tanto un evento doloroso, quanto una sciagura insormontabile.Travolto da una rabbiosa disperazione, credendosi incompreso e tradito da un padre amatissimo, Karl precipita in un abisso di autodistruzione e si lega più scelleratamente al gruppo di amici che lo attornia. Lasciatosi persuadere dal mefistofelico Spiegelberg a nascondersi nella foresta boema per costituire una banda di masnadieri e risolvere così il problema della prigione per debiti, la sua drammatica caduta volge risolutamente in tragedia. Le impreviste efferatezze conseguenti alle imprese che avrebbe voluto degne di un generoso fuorilegge sul modello di Robin Hood lo schiacciano a un’evidenza delittuosa e sanguinaria senza possibile riscatto. Alla ricerca di un brandello dell’identità perduta torna in Franconia per affrontare Franz e conoscere la sorte di Amalia, liberando, come prima impresa e senza saperlo, il vecchio Moor. Imprigionato in una torre dal servitore che avrebbe dovuto ucciderlo e che intendeva invece salvare il conte e sé stesso dalla vendetta del feroce Franz, l’anziano aristocratico trova gli accenti accorati di un padre amorevole e pentito nei confronti di tutti e due i figli, pur non riconoscendo ancora Karl. Sarà Amalia a riconoscere il suo diletto amico e a chiedere di poter tornare con lui o morire, sorda e cieca di fronte alla mutazione sinistra di Karl, vittima di una dolorosa dissociazione scatenata dall’inconciliabilità delle richieste alle quali è sottoposto. Sotto i colpi incalzanti di un Super–io multiplo che lo reclama guida di una banda assassina con la quale sa di essersi irrimediabilmente compromesso e nel contempo invocato come nobile feudatario-figlio amorevole-sposo appassionato, da quegli antichi affetti dei quali non si sente più degno, Karl si abbandona ad una resa che gli appare ineluttabile e che implica fatalmente la definitiva soppressione del vecchio conte e di Amalia. L’eterno ritorno di una carneficina.
La contraddizione della frattura epocale trova fondamento nell’incoerenza emotiva del conte Von Moor. L’anziano padre non si risolve a scegliere fra due ruoli: quello del padre severo, rigido custode dei valori della nobiltà e quello del padre amorevole che si annuncia come un pentito sgomento e devastato dal rimpianto.
Questa irresolutezza genera replicanza nella posizione dei figli, anch’essi l’uno opposto dell’altro per forma fisica e contenuto interiore e per giunta, lessinghianamente, uno espressione della “corte come vizio, corruzione, frivolezza, apparenze” e l’altro espressione di una presa di distanza dalla cultura della “sensibilità, famiglia, amicizia, natura, che diviene fonte di tragici dilemmi”. Già fuori dall’Illuminismo ma neppure al fianco di Rousseau, entrambi i figli si confermano tuttavia rappresentanti di strutture di potere autoritarie e immature, incapaci di uno sguardo complessivo che possa fornire interezza alle loro esistenze, condotte nel segno doppio di una passionalità e di una razionalità strumentale, causa di frammentazione dell’esperienza.
Alla ricerca di una perfettibilità umana che investa le istituzioni e la famiglia, il giovane Schiller usa abilmente, alcuni effetti di straniamento che spingono il fruitore del testo verso una dialettica di decostruzione dei propri convincimenti, per introdurre nel concetto di attività di pensiero anche il concetto di interpretazione, volendo attribuire a questo processo lo sviluppo di un cammino di civiltà.
Così, se la detonazione della crisi epocale de “I masnadieri” torna a deflagrare nel tempo, segnando il configurarsi storico di analoghe criticità, gli accordi dell’ “Inno alla gioia” del 1775, musicato da Beethoven nel 1826, risuonano di nuovo nel 1916 in un brano del Barbiere di Siviglia e nel 1989 durante la solenne cerimonia che celebrava la caduta del muro di Berlino. Questa volta nel titolo, appariva finalmente la parola “libertà”. Da parte sua Beethoven, afflitto come tutti sanno da sordità, volle costruire gli splendidi accordi chiave dell’inno, in forza di uno strumento insolito dal nome, nel suo caso, impertinente. Si trattava, infatti, di un formidabile, sonorissimo, “timpano”.
La gioia di Schiller
- Scritto da Daniela Pandolfi