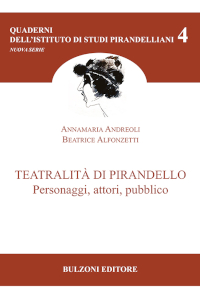California, anni ’30 del secolo scorso: grande depressione economica e contestuale crisi sociale. Torme di persone si ritrovano in situazioni di povertà e disagio fra prospettive talmente smorte da stringere ogni afflato interiore sino al male di vivere. Come tante opere di narrativa ed epiche trasposizioni cinematografiche ci hanno raccontato, lo screziato melting pot statunitense si anima di vagabondi smarriti,
 di diseredati in cerca di fortuna nella terra fondata sul credo della conquista della frontiera e del sogno. Di questo tratta anche il romanzo Non si uccidono così anche i cavalli? di Horace McCoy, da cui un adattamento teatrale di Giorgio Mariuzzo andato in scena – come novità assoluta per l’Italia – al Teatro Due di Parma il 14 gennaio, per la regia di Gigi Dall’Aglio e la scrittura scenica di Michela Lucenti, con ben ventidue interpreti e un quartetto di musicisti più un cantante. Ma il testo (attingendo proprio alla biografia dell’autore) parla soprattutto di una disumana maratona di ballo a cui partecipa una folta schiera di miserandi reietti in coppia, i quali devono ballare fino allo sfinimento per giorni e notti finché vincerà il duo in grado di resistere di più. Oltre all’ingente somma in palio, il concorso permette ai partecipanti di rifugiarsi temporaneamente dalla fame e dalle strade, strappando una serie di repentini pasti da consumarsi sulla pista e un alloggio dove potere risicare dieci minuti di riposo, tra un’estenuante sessione di ballo e l’altra. In più, c’è la possibilità di farsi notare dai produttori cinematografici o teatrali seduti in platea, dai quali potere avere un lavoro e forse successo. Il riferimento all’attuale sfera dei nostri reality televisivi va da sé; idem per quanto riguarda le somiglianze alla corrente epoca di recessione e crisi micidiale di idee, dove paiono pure languire orizzonti ampi dai rischiaranti contorni a cui rivolgersi. Un discorso, quindi, che riguarda tutti e non solo chi tenta di surrogare tali ristrettezze con la grandeur abbacinante della celebrità mediatica e del brivido del successo a ogni costo: annientando le distinzioni tra pubblico e privato, intimo ed esibito, vero e non vero, magari alla faccia di umana dignità e autenticità. Siamo tutti coinvolti, nessuno escluso. Ecco perché, allora, Dall’Aglio sceglie intelligentemente di mischiare l’ingresso del pubblico in sala con l’inizio dello spettacolo. Gli attori, infatti, stanno già recitando allorché ciò accade; tuttavia, un paio di loro accoglie gli spettatori fornendo indicazioni dove accomodarsi e scambiando rapide battute, mentre di soppiatto gli altri interpreti danno avvio alla rappresentazione facendo cominciare la trafila delle iscrizioni al contest danzante. Ne scaturiscono subito dei quadri simultanei in cui le voci si sovrappongono, sotto le luci accese, e fra il chiacchiericcio del pubblico non ancora sistemato. Per cui si crea un eloquente caos – tra la platea e la scena – abile a esprimere la confusione medesima contrassegnante il nostro odierno vivere, a cui il mondo dello spettacolo fa tutto sommato da specchio. Inoltre, la messinscena punta su una dimensione corale della vicenda a scapito di figure protagonistiche, sottolineando perciò il coinvolgimento della comunità nella questione. E qui risulta determinante la scrittura fisica di Michela Lucenti capace a tal fine di amalgamare con efficacia e precisione il gruppo di performer del suo Balletto Civile con l’ensemble di attori del Teatro Due. Un contributo determinante non soltanto ai fini della strutturazione dei vari numeri di ballo (collettivo o meno) che si susseguono lungo lo show, ma altresì per la creazione di talune scene danzate d’assieme caratterizzate da un’atmosfera e da una gestualità oniriche (quasi da incubo, in alcuni lividi passaggi) che apportano un maggiore tasso di drammaticità alla vicenda, altrimenti restituita dalla regia con troppa linearità. Poiché se la coralità sopraccitata ha certo valenze significative, manca però – tra le altre cose – un minimo di approfondimento nel trattamento di certe figure cardine della storia che, lavorando maggiormente su sbalzi di vertigine psicologica e giustappunto drammatica, riuscirebbero a catalizzare con vivezza umana i portati tragici racchiusi nel cuore della narrazione. Succede così che allo spettacolo, ad onta delle premesse, venga a mancare una forza emotiva che depotenzia o addirittura vanifica proprio l’intento suesposto di operare una pregnante connessione con la problematica situazione di recessione e crisi dei giorni presenti: perché esso difetta di quel pathos e di quella esasperazione di cui, diversamente, è possibile avvedersi nella realtà sociale quotidiana. La stessa violenza della competizione è qualcosa che, sì, si capisce in maniera chiara, ma senza che ne venga trasmessa la carica struggente tramite un ricorso maggiormente insistito a modalità espressive più marcate, sfatte e dirompenti a livello corporeo o recitativo, per non dire scenico; giacché l’insieme spettacolare è semmai piuttosto levigato, bien fait e senza scatti fuori norma, perciò alla fine distante dal far vibrare le corde dell’emozione. Non basta – ad esempio – far vedere i performer che, progressivamente, ballano con minore enfasi, allegria e vigore rispetto all’inizio; un’opzione simile fa solo intendere che sono stanchi e non anche umanamente annientati, intimamente spezzati e divisi dall’autenticità vitale che lo slancio, il ritmo del ballo potrebbe liberare. C’è solo senno, insomma, e non sensibilità. Sicché, perfino la miccia di un ragionamento critico attorno a un opinabile sistema dello show business non prende fuoco. Ed è un peccato giacché, sulla stessa falsariga, pure lo spazio scenico sembra rimandare a un ring: in quanto delimitato su tre lati dalle poltrone del pubblico (ovvero, gli sguardi degli altri che imprigionano, mettono all’angolo) e, sul quarto lato, dal palco a gradoni riservato allo specioso presentatore – il meschino padre padrone della kermesse – nonché ai musicisti impegnati a suonare dal vivo nel corso della sfiancante esibizione. Una messinscena, pertanto, dimidiata nel suo ricco potenziale espressivo e contenutistico; un lavoro teatrale che poteva essere davvero un capolavoro e, invece, si accontenta di essere solamente un buon spettacolo, tanto da riscuotere parecchi applausi. Una realizzazione di valida e bella fattura, talvolta divertente, capace di discorsi interessanti e però priva di coinvolgente, disperata – eppure necessaria – vitalità.
di diseredati in cerca di fortuna nella terra fondata sul credo della conquista della frontiera e del sogno. Di questo tratta anche il romanzo Non si uccidono così anche i cavalli? di Horace McCoy, da cui un adattamento teatrale di Giorgio Mariuzzo andato in scena – come novità assoluta per l’Italia – al Teatro Due di Parma il 14 gennaio, per la regia di Gigi Dall’Aglio e la scrittura scenica di Michela Lucenti, con ben ventidue interpreti e un quartetto di musicisti più un cantante. Ma il testo (attingendo proprio alla biografia dell’autore) parla soprattutto di una disumana maratona di ballo a cui partecipa una folta schiera di miserandi reietti in coppia, i quali devono ballare fino allo sfinimento per giorni e notti finché vincerà il duo in grado di resistere di più. Oltre all’ingente somma in palio, il concorso permette ai partecipanti di rifugiarsi temporaneamente dalla fame e dalle strade, strappando una serie di repentini pasti da consumarsi sulla pista e un alloggio dove potere risicare dieci minuti di riposo, tra un’estenuante sessione di ballo e l’altra. In più, c’è la possibilità di farsi notare dai produttori cinematografici o teatrali seduti in platea, dai quali potere avere un lavoro e forse successo. Il riferimento all’attuale sfera dei nostri reality televisivi va da sé; idem per quanto riguarda le somiglianze alla corrente epoca di recessione e crisi micidiale di idee, dove paiono pure languire orizzonti ampi dai rischiaranti contorni a cui rivolgersi. Un discorso, quindi, che riguarda tutti e non solo chi tenta di surrogare tali ristrettezze con la grandeur abbacinante della celebrità mediatica e del brivido del successo a ogni costo: annientando le distinzioni tra pubblico e privato, intimo ed esibito, vero e non vero, magari alla faccia di umana dignità e autenticità. Siamo tutti coinvolti, nessuno escluso. Ecco perché, allora, Dall’Aglio sceglie intelligentemente di mischiare l’ingresso del pubblico in sala con l’inizio dello spettacolo. Gli attori, infatti, stanno già recitando allorché ciò accade; tuttavia, un paio di loro accoglie gli spettatori fornendo indicazioni dove accomodarsi e scambiando rapide battute, mentre di soppiatto gli altri interpreti danno avvio alla rappresentazione facendo cominciare la trafila delle iscrizioni al contest danzante. Ne scaturiscono subito dei quadri simultanei in cui le voci si sovrappongono, sotto le luci accese, e fra il chiacchiericcio del pubblico non ancora sistemato. Per cui si crea un eloquente caos – tra la platea e la scena – abile a esprimere la confusione medesima contrassegnante il nostro odierno vivere, a cui il mondo dello spettacolo fa tutto sommato da specchio. Inoltre, la messinscena punta su una dimensione corale della vicenda a scapito di figure protagonistiche, sottolineando perciò il coinvolgimento della comunità nella questione. E qui risulta determinante la scrittura fisica di Michela Lucenti capace a tal fine di amalgamare con efficacia e precisione il gruppo di performer del suo Balletto Civile con l’ensemble di attori del Teatro Due. Un contributo determinante non soltanto ai fini della strutturazione dei vari numeri di ballo (collettivo o meno) che si susseguono lungo lo show, ma altresì per la creazione di talune scene danzate d’assieme caratterizzate da un’atmosfera e da una gestualità oniriche (quasi da incubo, in alcuni lividi passaggi) che apportano un maggiore tasso di drammaticità alla vicenda, altrimenti restituita dalla regia con troppa linearità. Poiché se la coralità sopraccitata ha certo valenze significative, manca però – tra le altre cose – un minimo di approfondimento nel trattamento di certe figure cardine della storia che, lavorando maggiormente su sbalzi di vertigine psicologica e giustappunto drammatica, riuscirebbero a catalizzare con vivezza umana i portati tragici racchiusi nel cuore della narrazione. Succede così che allo spettacolo, ad onta delle premesse, venga a mancare una forza emotiva che depotenzia o addirittura vanifica proprio l’intento suesposto di operare una pregnante connessione con la problematica situazione di recessione e crisi dei giorni presenti: perché esso difetta di quel pathos e di quella esasperazione di cui, diversamente, è possibile avvedersi nella realtà sociale quotidiana. La stessa violenza della competizione è qualcosa che, sì, si capisce in maniera chiara, ma senza che ne venga trasmessa la carica struggente tramite un ricorso maggiormente insistito a modalità espressive più marcate, sfatte e dirompenti a livello corporeo o recitativo, per non dire scenico; giacché l’insieme spettacolare è semmai piuttosto levigato, bien fait e senza scatti fuori norma, perciò alla fine distante dal far vibrare le corde dell’emozione. Non basta – ad esempio – far vedere i performer che, progressivamente, ballano con minore enfasi, allegria e vigore rispetto all’inizio; un’opzione simile fa solo intendere che sono stanchi e non anche umanamente annientati, intimamente spezzati e divisi dall’autenticità vitale che lo slancio, il ritmo del ballo potrebbe liberare. C’è solo senno, insomma, e non sensibilità. Sicché, perfino la miccia di un ragionamento critico attorno a un opinabile sistema dello show business non prende fuoco. Ed è un peccato giacché, sulla stessa falsariga, pure lo spazio scenico sembra rimandare a un ring: in quanto delimitato su tre lati dalle poltrone del pubblico (ovvero, gli sguardi degli altri che imprigionano, mettono all’angolo) e, sul quarto lato, dal palco a gradoni riservato allo specioso presentatore – il meschino padre padrone della kermesse – nonché ai musicisti impegnati a suonare dal vivo nel corso della sfiancante esibizione. Una messinscena, pertanto, dimidiata nel suo ricco potenziale espressivo e contenutistico; un lavoro teatrale che poteva essere davvero un capolavoro e, invece, si accontenta di essere solamente un buon spettacolo, tanto da riscuotere parecchi applausi. Una realizzazione di valida e bella fattura, talvolta divertente, capace di discorsi interessanti e però priva di coinvolgente, disperata – eppure necessaria – vitalità.
foto di Marco Caselli Nirmal (particolare)
Non si uccidono così anche i cavalli? di Horace McCoy.
Traduzione e adattamento: Giorgio Mariuzzo.
Regia: Gigi Dall’Aglio.
Scrittura fisica: Michela Lucenti.
Luci: Luca Bronzo.
Costumi: Marzia Paparini.
Adattamento musicale: Gianluca Pezzino.
Interpreti: Roberto Abbati, Alessandro Averone, Maurizio Camilli, Andrea Capaldi, Cristina Cattellani, Ambra Chiarello, Laura Cleri, Andrea Coppone, Paola De Crescenzo, Massimiliano Frascà, Francesco Gabrielli, Luchino Giordana, Francesca Lombardo, Michela Lucenti, Luca Nucera, Massimiliano Sbarsi, Emanuela Serra, Giulia Spattini, Chiara Taviani, Nanni Tormen, Marcello Vazzoler, Chantal Viola e i musicisti Gianluca Pezzino (pianoforte), Paolo Panigari (clarinetto/sax), Francesca Li Causi (contrabbasso), Gabriele Anversa (batteria), Carlo Massari (voce).
Produzione: Fondazione Teatro Due in collaborazione con Balletto Civile.
Al Teatro Due di Parma fino al 5 febbraio (www.teatrodue.org).
Non si uccidono così anche i cavalli?
- Scritto da Damiano Pignedoli
- Visite: 5793