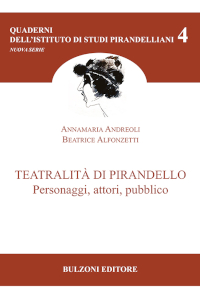Ci sono spettacoli che attraversano il presente con la forza e la compatta struttura interna di una lama, spettacoli semplici e solidi che sembrano figli diretti delle migliori teorizzazioni della cultura teatrale contemporanea e novecentesca, eppure vengon fuori e arrivano al pubblico con l’urgente e necessaria immediatezza di un urlo. Parliamo di “La merda”, spettacolo scritto e diretto da Cristian Ceresoli e interpretato
 da Silvia Gallerano che, dopo aver debuttato a Milano a marzo e aver vinto quindi il Fringe di Edimburgo, riprende a girare per i teatri italiani cominciando dal Festival Primavera dei teatri” di Castrovillari, dove s’è visto il 5 novembre scorso e dove, tra l’altro, è stato premiato dall’Associazione nazionale dei critici di teatro. Si tratta di un denso monologo/flusso di coscienza, dedicato ai centocinquanta anni dell’unità d’Italia, che Silvia Gallerano, nuda e seduta su un altissimo e largo sgabello, interpreta con potenza e sorprendente varietà di toni. L’immagine è feroce e grottesca, la postura, l’ acconciatura dei capelli, il trucco esagerato sulle labbra, la luce verde che investe quel corpo, tutto richiama il segno di quelle meravigliose donne disegnate da Altan: non è un caso, come per le vignette Altan è infatti il disgusto (il disgusto dell’intelligenza) per l’attuale realtà italiana il filo conduttore di tutta l’operazione. In scena è l’ossessione per un’idea di corpo femminile che piace ai maschi che dominano il mondo: un mondo in sé rivoltante, eppure vissuto con spasmodico, paradossale, desiderio; un mondo desiderato che di quella ragazzina rifiuta però l’altezza minuta e le cosciotte di bambina; un mondo che la costringe a provare le diete più strambe, a oscillare tra anoressia e bulimia. E, su tutto, l’ansia di riuscire a farcela, costi quel che costi ma farcela, l’ansia di vincere, di sfondare nel mondo della televisione e quindi esser riconosciuta per strada, entrare in qualche salotto televisivo, trovarsi un piccolo posticino, perché certo è così che si comincia e poi una volta che si è dentro…, l’ansia febbrile d’imparare a esser forte (forte di stomaco soprattutto) e furba e tenace e coraggiosa e disinvolta, l’ansia di superare il ribrezzo per ogni cosa, per ogni mano che si allunga, per ogni sesso maschile che ti punta, e dunque a tutto esser pronta e tutto riuscire a mangiare, ingoiare, digerire. Tutto. Questa è la linea principale di sviluppo del monologo e su di essa poi s’innestano altri motivi come la retorica patriottica, quella dell’ inno nazionale certo ma anche quella repubblicana e resistenziale, il rapporto col padre, molto interessante, il rapporto con la morte, con l’idea e la presenza della morte, e la malattia e, ancora, altre linee di riflessione, risolte talvolta con esiti affettati, se non gratuiti, e passaggi politicamente scorretti messi lì, abbastanza scopertamente, tanto per epater le bourgoesois. Ma seppure tutto si condensa nella metafora centrale della “merda”, è nell’urlo finale, stremato e poetico, che questo spettacolo trova il suo compimento esatto e la sua dimensione più feconda e aperta: a volerla dire tutta, se si trattasse solo di una immaginifica ripresa teatrale ad esempio de “Il corpo delle donne”, il bellissimo e intelligente documentario/pamphlet di qualche anno fa di Lorella Zanardo, si tratterebbe solo di un’operazione, come dire, fuori sincrono, in ritardo ormai sulla sostanza culturale di un presente che oggi sembra aver superato la mitografia delle veline e di tanto porno-ciarpame televisivo, mentre quel grido sa andare oltre il presente e il passato prossimo: oltre e avanti. Quel grido sa parlarci, sa parlare a noi di noi stessi, sa dirci della sterilità di una cultura che se, strutturalmente, tradisce e mercifica l’umanità non può più esser riscattata da nessuna retorica e finisce col divorare se stessa, imputridire, trasformarsi inevitabilmente in merda. Appunto.
da Silvia Gallerano che, dopo aver debuttato a Milano a marzo e aver vinto quindi il Fringe di Edimburgo, riprende a girare per i teatri italiani cominciando dal Festival Primavera dei teatri” di Castrovillari, dove s’è visto il 5 novembre scorso e dove, tra l’altro, è stato premiato dall’Associazione nazionale dei critici di teatro. Si tratta di un denso monologo/flusso di coscienza, dedicato ai centocinquanta anni dell’unità d’Italia, che Silvia Gallerano, nuda e seduta su un altissimo e largo sgabello, interpreta con potenza e sorprendente varietà di toni. L’immagine è feroce e grottesca, la postura, l’ acconciatura dei capelli, il trucco esagerato sulle labbra, la luce verde che investe quel corpo, tutto richiama il segno di quelle meravigliose donne disegnate da Altan: non è un caso, come per le vignette Altan è infatti il disgusto (il disgusto dell’intelligenza) per l’attuale realtà italiana il filo conduttore di tutta l’operazione. In scena è l’ossessione per un’idea di corpo femminile che piace ai maschi che dominano il mondo: un mondo in sé rivoltante, eppure vissuto con spasmodico, paradossale, desiderio; un mondo desiderato che di quella ragazzina rifiuta però l’altezza minuta e le cosciotte di bambina; un mondo che la costringe a provare le diete più strambe, a oscillare tra anoressia e bulimia. E, su tutto, l’ansia di riuscire a farcela, costi quel che costi ma farcela, l’ansia di vincere, di sfondare nel mondo della televisione e quindi esser riconosciuta per strada, entrare in qualche salotto televisivo, trovarsi un piccolo posticino, perché certo è così che si comincia e poi una volta che si è dentro…, l’ansia febbrile d’imparare a esser forte (forte di stomaco soprattutto) e furba e tenace e coraggiosa e disinvolta, l’ansia di superare il ribrezzo per ogni cosa, per ogni mano che si allunga, per ogni sesso maschile che ti punta, e dunque a tutto esser pronta e tutto riuscire a mangiare, ingoiare, digerire. Tutto. Questa è la linea principale di sviluppo del monologo e su di essa poi s’innestano altri motivi come la retorica patriottica, quella dell’ inno nazionale certo ma anche quella repubblicana e resistenziale, il rapporto col padre, molto interessante, il rapporto con la morte, con l’idea e la presenza della morte, e la malattia e, ancora, altre linee di riflessione, risolte talvolta con esiti affettati, se non gratuiti, e passaggi politicamente scorretti messi lì, abbastanza scopertamente, tanto per epater le bourgoesois. Ma seppure tutto si condensa nella metafora centrale della “merda”, è nell’urlo finale, stremato e poetico, che questo spettacolo trova il suo compimento esatto e la sua dimensione più feconda e aperta: a volerla dire tutta, se si trattasse solo di una immaginifica ripresa teatrale ad esempio de “Il corpo delle donne”, il bellissimo e intelligente documentario/pamphlet di qualche anno fa di Lorella Zanardo, si tratterebbe solo di un’operazione, come dire, fuori sincrono, in ritardo ormai sulla sostanza culturale di un presente che oggi sembra aver superato la mitografia delle veline e di tanto porno-ciarpame televisivo, mentre quel grido sa andare oltre il presente e il passato prossimo: oltre e avanti. Quel grido sa parlarci, sa parlare a noi di noi stessi, sa dirci della sterilità di una cultura che se, strutturalmente, tradisce e mercifica l’umanità non può più esser riscattata da nessuna retorica e finisce col divorare se stessa, imputridire, trasformarsi inevitabilmente in merda. Appunto.
La merda
- Scritto da Paolo Randazzo
- Visite: 10236